Odissee
di Pasinetti Mario
Anno: 2025
ISBN: 978-88-6932-323-2
Prezzo: 10.00 €
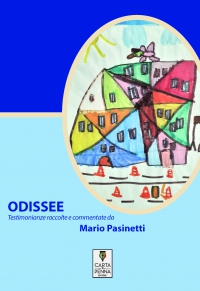
Dalla premessa dell'autore:
In questo opuscolo si citeranno spesso le parole di Simone Weil (1909-1943); questa pensatrice non è stata una filosofa nel senso classico del termine, è stata, come si dice, on the road, ha vissuto, sofferto e filosofato in un periodo del XX secolo che, parafrasando il celebre libro di John Reed1, possono essere definiti i dodici anni che sconvolsero il mondo.
Dagli anni dell’insegnamento, la sua esistenza si snoda attraverso un’esperienza operaia vissuta direttamente in fabbrica, una militanza controversa in continua polemica con le istituzioni storiche del movimento operaio, la guerra di Spagna, l’esilio e l’esperienza mistica, da ultimo il tentativo di farsi coinvolgere in prima persona nella Resistenza francese.
Lungo questo percorso intellettuale, non privo di contraddizioni, si alternano visioni filosofiche di carattere generale a intuizioni premonitrici sull’avvenire dell’Europa e sul rapporto tra quest’ultima e le popolazioni oppresse dal giogo coloniale.
L’attualità del suo pensiero risulta evidente in merito alle eredità lasciateci dal colonialismo, di cui le grandi migrazioni di oggi sono una delle conseguenze.
Questo opuscolo si compone di tre interviste ad altrettanti profughi, due di esse sono state rese possibili tramite i contatti che la signora Jamila Morchid, che opera in qualità di mediatrice culturale presso la Camera del Lavoro di Biella, ha stabilito con alcune di queste persone. Altri spunti mi sono stati dati dalla visione di un filmato prodotto dalla studiosa curdo-turca Merve Cirisoglu e dalla lettura di un libro redatto dallo scrittore e profugo Abbas Khider.
1) John Reed, Dieci giorni che sconvolsero il mondo, traduzione di M. G. Cavallo, Editori Riuniti, Roma, 1957.
ATTESE TRADITE
L’intervistato è un libico, laureato in ingegneria e munito di regolare permesso di soggiorno che, prima di lasciare il proprio Paese, godeva di uno status sociale ed economico superiore a quello della media dei suoi concittadini. Al momento della caduta di Gheddafi, ha ritenuto fosse giunto il momento, da lui per lungo tempo auspicato, nel quale fosse possibile l’instaurazione dello Stato di diritto nel proprio Paese.
Il principale ostacolo verso il raggiungimento di questo traguardo era però costituito dal proliferare delle bande armate che minacciavano la sicurezza dei cittadini e agivano indisturbate, commettendo ogni sorta di arbitri. Per contrastare tutto ciò, insieme con altre persone che condividevano le sue idee, ha iniziato a stilare un elenco contenente le informazioni relative a queste bande criminali; una particolare attenzione è stata posta nel censire i luoghi della predicazione jihadista; essi erano facilmente identificabili dal momento che gli adepti a questi gruppi, generalmente in concorrenza tra di loro, operavano alla luce del sole.
Ritenendo fosse un suo dovere civico contribuire alla messa in sicurezza del proprio Paese, ha fornito alla polizia l’elenco degli appartenenti a questi gruppi armati, ma, in conseguenza di ciò, invece di essere adeguatamente protetto, ha ricevuto ripetute minacce di morte ed è stato fatto oggetto di numerosi agguati.
Non riuscendo a spiegarsi questo stato di cose, ha svolto per proprio conto ulteriori indagini, scoprendo che il responsabile della polizia con il quale aveva interloquito era, a sua volta, un dirigente di queste associazioni criminali. Da qui è scaturita la decisione di lasciare la Libia per l’Italia.
Nel corso del colloquio, ha fatto inoltre notare come, nel suo Paese, fosse di dominio pubblico il fatto che gli inviati da parte dei Servizi segreti di molti governi europei avessero avuto contatti di varia natura con questi gruppi armati e come fosse noto che, presso l’ambasciata americana, si fossero tenute riunioni in forma semipubblica con molti esponenti di queste fazioni armate.
Il profugo, dunque, credeva, sperava che l’instaurazione dello Stato di diritto costituisse la logica conseguenza della caduta della dittatura, la domanda è quindi: dobbiamo ritenere che il profugo abbia peccato di ingenuità ritenendo che il cammino verso la democrazia fosse lineare, senza tenere realisticamente conto del quadro oggettivo costituito dalle forze in campo?
Se la risposta a questa domanda fosse positiva, ciò significherebbe che, al venir meno del monopolio nell’uso della forza esercitato dallo Stato dittatoriale, è seguito, come era prevedibile, un uso della forza basato sull’iniziativa dei singoli privati.
Tuttavia si potrebbe osservare che anche in Occidente lo Stato detiene il monopolio della forza, pur mitigato nel suo uso dall’esistenza di un sistema di controllo esercitato dal potere legislativo; ciononostante, l’uso della forza si manifesta spesso in forme brutali e questo avviene a opera di apparati che sono in larga parte autoreferenziali.
Pertanto, in Occidente, il confine tra uso legittimo e illegittimo della forza non è così netto come molti potrebbero farlo apparire.
A queste affermazioni si potrebbe obiettare che, nel corso della sua storia, l’Occidente è pervenuto gradualmente a realizzare questa mitigazione e che, viceversa, ciò non si è ancora (?) realizzato nei paesi sottosviluppati.
Nel caso della Libia descritto dal profugo, si sarebbe addirittura verificata un’involuzione, nel senso che uno Stato, sia pure basato su di una dittatura, si sarebbe disgregato lasciando spazio alle lotte intertribali.
Secondo questa visione di tipo storicistico, una gran parte dei Paesi del mondo si troverebbe nella situazione hobbesiana della guerra di tutti contro tutti, alla quale dovrebbe gradualmente far seguito un patteggiamento tra le parti in lotta, come preludio all’instaurazione dello Stato di diritto...
...continua