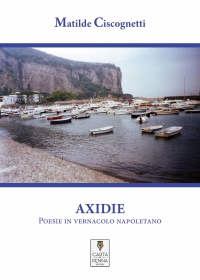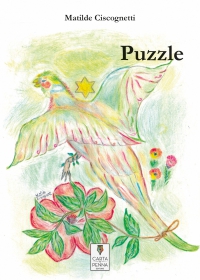Quando era poco più che adolescente, mia madre ha lavorato per alcuni anni come aiutante apprendista in una sartoria di Torre del Greco che confezionava cappotti e abiti su richiesta a diversi clienti della zona, soprattutto donne, di ogni età e rappresentative dei più vari ceti sociali. Capitava però che ogni tanto facesse capolino in negozio un giovanotto elegante, o anche un distinto signore un po’ attempato, per soddisfare l’esigenza di un nuovo abito cucito su misura, con stoffe scelte di persona, e la qualità primaria dei tessuti ricercata anche nel capriccio del panciotto a righe, come voleva l’ultima moda, e della camicia, di popeline o di seta, vero fiore all’occhiello per una persona che mostrasse inclinazioni e attitudini ad una formale, ricercata eleganza.
Situata a via Calastro, in un palazzetto nei pressi dell’antico Mulino sul porto, la bottega fu per molto tempo lo scrigno dischiuso per tesori di apprendimento da distribuire a giovani vite laboriose; mia madre vi attingeva entusiasta e, lavorando con tenacia e convinzione perché, ne era sicura, quel cofanetto prezioso di aghi e macchine da cucire, le avrebbe schiuso, in una naturale metamorfosi del tempo, l’approdo sicuro della indipendenza conquistata. Nello spirito sognatore che alitava nelle stoffe, vi coltivava l’orgoglio di esercitare non solo la doverosa invenzione di un mestiere che garantisse indipendenza e sopravvivenza, ma la fantasia e la bellezza di un personale istinto creativo, coniugati con la compiacenza del prossimo e l’ammirazione di una sia pur piccola fetta di società di signorile riguardo.
Circondate da bottoni, spolette di cotone e miriadi di aghi che luccicavano formando piccole pozze d’argento, quasi seppellite da tagli e rotoli di stoffa che scivolavano e si dipanavano come torrentelli bizzosi sui tavoli e sul pavimento, al suono cadenzato delle macchine da cucire (solo dalle sartine più brave utilizzate; quelle nuove, che imparavano il mestiere, se ne stavano quasi tutto il tempo a imbastire pieghe e a infilare aghi), le ragazze trascorrevano gran parte della giornata a incrociare e a bucare dita e cotone. Esse sedevano a dei tavoli, o semplicemente l’una a fianco dell’altra con il lavoro in grembo, le più fortunate vicino alla finestra dove poter catturare i languidi sguardi di un innamorato in paziente attesa in strada, mentre ‘la padrona’, dai ricci capelli neri e i fianchi opulenti, non ancora intaccati dal vento di carestia che di lì a poco la guerra avrebbe soffiato, dirigeva, ordinava, valutava, criticava. E qualche volta lodava, anche se di rado. Di paga neanche a parlarne, doveva bastare la fortuna di potere apprendere un mestiere che era un’arte antica che prima o poi si sarebbe tradotta in una risorsa economica. Ma la proprietaria della sartoria, cioè della casa il cui salone, era adibito a tale attività, era anche una amica di mia nonna. Quando erano ragazze, avevano spesso preso il caffè insieme in questa sala, arredata tanti anni prima con mobili eleganti che ne facevano il salotto buono per gli ospiti e che erano stati collocati in una stanza più piccola ma forse più accogliente, per via del terrazzino fiorito che affacciava sulla piazzetta principale del corso. Quale occasione più propizia per innocenti pettegolezzi di due giovanette che spiavano la strada e i passanti…In virtù di quella amicizia, mia madre era stata subito accettata nella scuola di cucito e trattata quasi come una di famiglia, ma, come le altre sartine lavorava sodo, e nel tempo si era molto affezionata a questa signora che era affiancata nella gestione dell’attività da suo figlio Antonio. Il nome è ideato in questo momento che scrivo perché non ricordo il vero, userò quello del Santo che aiuta a ritrovare le cose perdute, e forse il senso della vita smarrito o in qualche modo rinnegato. E’ questo giovane il protagonista di questa storia di vita, come mi è stata raccontata, anche più di una volta, quando ero però abbastanza grande, per via dell’argomento considerato per quei tempi di estrema riservatezza, se non persino foriero di messaggi d’impudicizia, anche solo tramite le parole. Egli era giovane, poco meno che trentenne, il volto rotondo e pallido, su una figura piccola e un po’ tarchiata, con il viso sempre rasato di fresco e la pelle profumata di acqua di colonia. Sulla camicia portava sempre le bretelle, le preferiva morbide e colorate, quasi srotolate sulla camicia a quadretti trattenuta dentro i pantaloni di tweed grigio che evidenziavano la leggera rotondità delle sue forme. Il metro da sarto, giallognolo, un po’ sbiadito dall’usura, era appoggiato sulla spalla a mo’ di nastro capriccioso: una sorta di guarnizione mobile che gli scendeva fin sulla vita, scivolando e ritraendosi lungo il gilet di seta, adornato dall’ elegante orologio a catena, come un’onda che s’infrange e di nuovo rifugge capricciosa sulla riva, in un serpentino rifulgere d’oro sbiadito.
Antonio era un giovane come tanti. Aveva lasciato la scuola dopo le medie, allora considerate un titolo di studio più che elevato, e dopo varie esperienze come apprendista di svariati mestieri presso alcune bottegucce, e alcuni anni passati ad attendere qualcosa che mettesse in luce eventuali talenti nascosti, si era pensato di avviarlo al mestiere di sartoria. Già la madre, abile cucitrice, da anni lo esercitava con consensi entusiastici da parte una clientela affezionata, la stessa che, nelle sue previsioni, poi avveratesi, avrebbe schiuso nella luce di un irradiata amorevole lungimiranza, albe foriere di colorate stagioni nel genio rivelato del figlio.
Di carattere gioviale e molto espansivo, il giovanotto aveva mostrato all’inizio un’ostile diffidenza verso quel mestiere, secondo lui così poco virile, civettuolo, roba da femmine, lo definiva.
Si limitò all’ inizio a svolgere mansioni di secondaria importanza, quali annotare su un registro i nomi delle clienti e l’abito commissionato da ciascuna, con relativi costi, anticipi e saldi. Si occupava anche di rifornire di aghi e bottoni la sartoria, trattando con i commercianti quantitativi e prezzi, e distribuiva la paga alle poche sartine (quelle di ‘ruolo’), che la percepivano, consegnandola ogni venerdì in una busta bianca semichiusa, dopo averla contata al loro cospetto, sotto l’occhio autorevole e il silenzio accondiscendente della madre. Ma con il tempo, da quell’occupazione di solerte utilità, egli era passato ad esercitare poco alla volta, una forte predominanza sulla gestione artistica della bottega, manifestando un istinto creativo innato e molto variegato che si esplicava in una produzione di idee intessute di fantasia, gusto e attenzione all’evoluzione culturale della società.
Il suo destino si era d’improvviso schiuso dalla conchiglia della casualità.
Con lo spirito di un rivoluzionario riusciva a soddisfare le richieste più originali ed esigenti, attuando su di esse con dolce accondiscendenza e fine psicologia, i ritocchi del suo entusiasmo personale. Si sa che la tenacia forgia e alimenta il fine di ogni cosa, così il giovane Antonio e sua madre videro consolidare ed aumentare come un torrente in piena, l’ordinazione e la cucitura di abiti. con l’avvicendarsi costante di clienti di ogni età e rango sociale. E fu proprio una di queste clienti che innescò un meccanismo che dimostrò come un uomo in apparenza libero nel soddisfare i suoi sani istinti di realizzazione, potesse trasformarsi in un individuo imprigionato in una rete tessuta di verbale retorica e silenzioso compromesso, la prima generata dagli ipocriti consensi dei benpensanti, il secondo alimentato dalla necessità di compiacere e non deludere le aspettative di una tranquilla famiglia borghese. Antonio era quello che si definisce un uomo rispettabile, abbastanza istruito e con un lavoro sicuro che gli permetteva di godere di una buona rendita.
Gli abiti eleganti, i pranzi con gli amici, un piccolo libretto di risparmio aperto di recente e destinato ad arricchirsi, erano piccoli vezzi di orgoglio che lo connotavano come persona di ricercata autonomia e di affidabile considerazione sentimentale ( non un riferimento di incostanza e incertezze), agli occhi di una ragazza che, giunta in età da marito, sognava un matrimonio alloggiato nel benessere e nell’appagamento dei bisogni. E dietro di essa si potevano immaginare genitori benevoli e accondiscendenti, di quelli che, anche oggi, contano e ricontano, accumulandole come un tesoro, le monete della dote e ricamano sogni di un castello fiabesco dove la loro figlia regni felice. Dato il consenso al fidanzamento si pregherà poi perché bruci la fiamma di un giuramento d’amore eterno davanti a un prete sotto l’egida sovrana di un protocollo legale. Per il momento però il giovanotto non manifestava il desiderio di una compagna ufficiale, gli bastavano gli amici e la conoscenza di qualche ragazza alle feste dove era invitato. Con esse non andava mai oltre qualche scambio di battute improntate ad una amichevole cordialità. Pur abitando ancora con la madre (il padre era morto già da qualche anno per un mal di cuore), egli occupava due stanze attigue dell’appartamento che gli erano state assegnate come abitazione personale; le separava idealmente dal resto della casa una libreria ove erano in bella mostra molti volumi con fregi dorati e alcune porcellane di Capodimonte. Antonio l’aveva posta al centro del lungo corridoio per sancire una informale indipendenza dei due ambienti familiari. Sembrerà una cosa strana, ma io ho visto fare la stessa cosa in tempi molto più recenti in casa di alcuni amici con lo stesso problema. Altre stanze di uso comune venivano utilizzate da entrambi, secondo necessità, senza distinzione di appartenenza specifica a qualcuno.
La madre si riprometteva però di lasciargli anche tutto l’appartamento, riservandosi solo una stanza per sé, il giorno che avesse preso moglie, perché va bene mangiare e vestire bene, ma il fine supremo della vita per un uomo rimaneva accasarsi e mettere su famiglia. Lei ne era sicura: suo figlio ci sarebbe riuscito presto. Al di là della cura della persona e della buona educazione che gli era stata impartita, egli mostrava una gentilezza d’animo che si traduceva in una serena compostezza e un fare delicato e cortese che non poteva non piacere alle donne. E anche se non bello, la dolcezza dello sguardo, scevro da languori e da tristi pensieri, ne illuminava il viso e ne plasmava i lineamenti, donando loro una piacevolezza d’insieme che compensava in armonia una bellezza mancata.
Proprio quello sguardo la madre colse posarsi e sostare dolcemente ammaliato su una ragazza di nome Rosaria che un giorno si presentò in sartoria col fratello per commissionare un abito da indossare per un matrimonio di un cugino.
La scelta del taglio fu fatta sfogliando alcune riviste di moda che la cugina di mia madre acquistava da un giornalaio di Resina; il suo piccolo chiosco nei pressi della stazione sembra abbondasse di riviste patinate, piene di foto di abiti e accessori tra i più eleganti e variegati nella foggia.
Tra il conteggio di bottoni e uno scambio di battute sugli eventi del giorno e su banalità quotidiane quali il tempo e la classe politica al governo, di prassi elogiata, visto l’autoritarismo dittatoriale dell’epoca che falciava il libero volo del pensiero, (e guai a sgarrare!) tra i tre giovani nacque e si consolidò un’amicizia allegra e profonda. Ma vide nascere anche quella che sembrò l’inizio di una intesa sentimentale e il nascere di una nuova giovane coppia.
Dopo i primi giorni di occasionali contatti e retorici scambi di cortesie verbali, cominciò una frequentazione più intima e confidenziale, fatta di incontri per passeggiare insieme nei ritagli di tempo, e di pomeriggi trascorsi in casa il sabato e la domenica, a giocare a carte e ad ascoltare musica dalla radio. Grande e a corrente, una delle prime acquistate da una famiglia di quei tempi, il piccolo altoparlante con il marchio in ferro di una nota fabbrica italiana diffondeva ritmi di charleston e one-step, secondo l’ultima moda americana, e la nascita dei primi contrappunti jazzistici, alternati a romantiche melodie orchestrali. Accomunava questi ragazzi la buona educazione e i sani istinti del rispetto che la brava persona riserva sempre agli altri. E a osservarli più attentamente, si intravedeva la luce che brillava negli occhi di lei sostare e indugiare nello sguardo buono e vulnerabile dell’amico, e come una preda al laccio, catturarne la sua segreta risposta. Non erano sdolcinati sdilinquimenti, come può capitare tra giovani allettati dalla scoperta di emozioni nascenti. Chi aveva modo di vederli, avrebbe dato per scontato una prossima dichiarazione e una ufficializzazione di intenti.
I tre amici si incontravano di solito a casa dei due fratelli; allora non era consentito a una ragazza di uscire da sola con un uomo, era considerato sconveniente, segno di una spregiudicatezza ardita e fastidiosamente provocatoria.
La madre di lei considerava con simpatia quel bravo giovane, lo accoglieva volentieri in casa per alcune ore e, tra un caffè, un liquore e il vassoio di sfogliate e babà, offerto tra un ballo e una chiacchiera, vegliava con affettuosa discrezione a che non si superassero i limiti di una libertà consentita. In segreto, non tanto però, lei e suo marito facevano progetti e centellinavano risparmi per la dote della ragazza che, ne erano sicuri, da lì a poco, avrebbe ricevuto l’anello vincolante di una promessa e la richiesta formale di matrimonio. La madre di Antonio era anch’ella spronata da questa piacevole atmosfera, a progetti di vita che accomunavano suo figlio a una ragazza gradevole e degna di stima, e cuciva vestiti col sorriso di luce sulle labbra e sogni che sfilavano davanti ai suoi occhi.
L’occasione che desse un punto di svolta a questa sensazione di grandi attese, sembrò presentarsi il giorno della festa dell’Immacolata che doveva essere l’evento chiarificatore, il dubbio svelato di una certezza imminente.
Già da alcuni giorni c’era un sentore che qualcosa d’inespresso stava prendendo vita. Un intreccio di sguardi, ora di muta dolcezza dei grandi occhi cangianti di lei, ora di coinvolgente assenso da parte di lui, scriveva e stava componendo lietamente il finale di quella amicizia, in una muta complicità che aveva cacciato via ogni dubbio o timidezza.
E il fratello di lei, fra una frase sussurrata di nascosto alla sorella, e lo sguardo indagatore e poi complice all’amico, si comportava come un ago della bilancia che né propende per l’uno né per l’altro, ma mantiene il felice equilibrio dei sentimenti.
Anche quando i due innamorati furono visti scambiarsi bigliettini con mani furtive, (in realtà non si sapeva cosa fossero, ma non c’era bisogno di assumere quell’aria circospetta di segreti sussurrati se fossero stati cioccolatini), il futuro cognato si limitò a riferirne alla madre, con serena meraviglia di lei).
E poi venne quel giorno.
L’otto di dicembre, giorno in cui si festeggia l’Immacolata Concezione, la Basilica di Santa Croce a Torre del Greco, fa da sfondo a un evento grandioso. Per annunciare questa festa si celebra alle quattro la messa notturna dedicata a tutti gli zampognari, musici antichi della più pura tradizione natalizia che al mondo cattolico ricordano ed annunciano l’avvento miracoloso nella grotta di Betlemme. Adulti freddolosi, con bambini assonnati per mano, si alzano in piena notte, e in piccole fila che provengono da ogni strada e vicolo, attraversano strade buie e solitarie per partecipare in tempo alla messa. E il canto dell’usignolo insonne risuona nel fruscio delle vesti e lo strofinio delle scarpe sull’asfalto; ad illuminare la via la fiamma della luna nel cielo e qualche lampione dimenticato acceso qui e là, insieme a poche stelle ostinate e a qualche lucciola solitaria e incuriosita. I più riottosi alla levataccia preferiscono continuare a dormire, ma sono in tanti, di ogni età che rimangono fedeli a questa tradizione; mia madre e sua sorella, bimbe eccitatissime all’idea di uscire di notte, rimanevano sveglie tutta la notte per essere portate alla funzione. E quale occasione migliore per indossare qualcosa di nuovo, anche solo un cappellino o un paio di guantini, come voleva la tradizione? Quando la messa sta finendo, al momento della benedizione del presepe, i suonatori lì giunti soffiano armoniose melodie nelle otri di pelle che rivestono le zampogne, e nella struggente penombra della notte che sta finendo, si levano nel cielo i suoni suggestivi che riscrivono ogni volta nel tempo la storia spirituale dell’umanità. Oggi questi musicisti, simbolo di mistica rappresentatività, partecipano alla funzione indossando abiti di normale quotidianità, talora giacca e cravatta, non resistendo alla spinta di ammodernamento dei tempi; fino a pochi anni fa essi ancora suonavano ricoperti con panciotti di montone e sandali di pelle intrecciati sulle gambe, nella rievocazione fedele di quella che è l’immagine tramandata dai tempi più aviti. Gli strumenti invece sono sempre quelli, rustici, quasi primitivi, ma intoccabili nella struttura e nell’essenza dei loro suoni suggestivi. Il sunto dell’evento, delicato ed esaltante nel succedersi delle fasi, è delineato nei versi seguenti: trepidanti ansie che diventano commoventi certezze, fino al momento in cui l’emozione dell’attesa sfocia nella musica delle voci e degli strumenti accomunati in un unico tripudio al cielo illuminato dal candore niveo delle colombe e da una luce simbolo di un evento di gloria.
“Brillano croci
(La festa dell’Immacolata alla Basilica di Santa Croce di Torre del Greco)
“Scarpette bianche tra le siepi brune
alla sonata dell’Ave Maria
rischiarano il silenzio di risonanti cuori,
lungo le curve primule dei muri
ombre leggere smarriscono nel buio,
è gioia che spinge volti assonnati e lieti
a rifiorire a un lume di Madonna,
palpita schivo tra i poggi della notte
su una chiesina prona a sciabordii di stelle,
Tra tremuli graffiti di preghiera
schiumosi suoni di zampogne tronfie
accendono campane ed occhi stanchi:
è un vivere pulsante d’aliti schiusi
per la notturna messa degli zampognari,
uomini dolci dagli squadrati manti
vibranti come fiori di candide
memorie sull’osannante prato.
L’attesa di una luce…
Trasmuta il giorno alle spirali
note di sinfonie di soli…
Il Santo Carro ondeggia sugli spiazzi
nell’umettoso azzurro dell’aurora,
di soavità tripudia su uomini ansimanti,
l’eburneo volto dell’Immacolata
al mondo mostra inciso nella pietra,
sul seno trecce di pallide corolle
imbevono la veste come chioma,
stringono intorno mani di bimbi gigli
chiari, a una folata il manto scuotono
di seta…e dalla ondosa ruota
effluvio di colombe in volo s’alza,
come coriandoli di luna sparsi al cielo
da un incantesimo svelato…
Brillano croci al nome di Maria,
la nuvola sciaborda degli uccelli
sulle gugliate anse di una raggiera al sole,
frullo d’ali che lambisce i visi…
Sono di Madre baci sulla divina soglia
donati in pioggia agli stupiti cuori
nel fiume in piena del mattino…”
Era giunto il momento dove l’aspetto emotivo raggiungeva la sua massima esaltazione spirituale nella celebrazione del rito.
La statua della Madonna era stata portata fuori dalla Basilica di Santa Croce, e si ergeva magnifica e grandiosa sul carro tenuto a spalla da una cinquantina di uomini devoti. La folla, tra stupore e bisbigli trepidanti, fremeva in attesa del segnale convenuto: un rintocco di campane che all’ora stabilita squarciò il silenzio echeggiando con le sue onde melodiose nel pentagramma del cielo. Il manto di seta della Santa fu sollevato, e in volo si levarono, celate nel grembo e ai piedi della statua così scoperta, decine di bianche colombe che disegnarono nel manto della stella solare cerchi armoniosi, in una fluttuante nube di luce che disegnava volute ricamate nel tripudio delle campane. Come una enorme stella filante, dolcemente esplose, dissolvendosi in evanescenti stalattiti d’avorio, mescolate a frange d’oro e d’azzurro, in un tripudio festoso, osannante alla vita. I tre amici erano andati insieme a quell’evento, come pure le famiglie, sia pure ciascuna per conto suo.
Almeno così si sapeva. La mamma di Antonio si era recata alla funzione con mia nonna ed alcune amiche, e nella piazza affollata indagava con lo sguardo, tentando di riconoscervi il figlio e la sua innamorata.
Cerca, ansiosa e sorridente, si guarda intorno curiosa, allunga il collo alzandosi sulla punta dei piedi, essendo piccola di statura, e scruta ovunque abbia un sentore della loro presenza, tra la folla che ancora sosta vicino al carro e nel gruppo di avventori di una bancarella di torroni, sulla rotonda ove si attarda il gruppo di giovani musicisti della banda locale, o ai lati di qualche viuzza, che confluisce sulla piazza.
Ed era sorridente e certa di trovarli. Viene anche sospinta un po’ indietro dalla folla che preme intorno, tanto che per qualche minuto le sue compagne la perdono di vista. Ma lei si è solo allontanata di poco, per sbirciare nel vicolo che confluisce nella lunga discesa verso il mare. Tante volte i ragazzi hanno fatto quella strada nelle loro passeggiate.
E finalmente lei, ed un sorriso di esultanza le spuntò sul viso, individuò la coppia sotto l’archetto di un portone antico, appena all’interno di esso; lui, quasi celato alla vista da un albero sul marciapiede, parlava alla ragazza seminascosta dal buio. Antonio la madre lo riconobbe quasi subito, lei…non riusciva a vederla bene, ma di sicuro si trattava della ragazza. La donna stette incerta qualche secondo, poi mosse decisa qualche passo verso di loro che si stagliarono nitidi e chiari nella loro compostezza.
Seminascosti rispetto alla strada, i due ragazzi apparivano immersi in un mondo lontano, avulso da ciò che li circondava, ove la realtà si plasmava e prendeva corpo in una atmosfera indefinita perché si erano persi nel dialogo muto e universale che solo gli innamorati sanno scambiarsi appena guardandosi e sfiorandosi.
I corpi vicini, le mani strette le une nelle altre, quasi i fiati a lambirsi nel sussurro di parole, non lasciavano dubbi sull’innamoramento della coppia che seppure fremente nel rivelarsi, manteneva il riserbo dell’audacia non superata.
Gli sguardi erano turbati, ma non della dolce emozione che muove i cuori alla gioia, ma pervasi da una sofferenza indicibile che bruciava nelle carezze lievemente accennate. Sfiorare i propri volti, e le labbra, lambire l’altrui pelle con timidi accenni di tocchi sulle braccia, sul viso, sul collo, come cose preziose, bruciava di un ardore turbato, era di chi sapeva che il male che avrebbe potuto fare andava oltre il dolore di un graffio o l’insolenza di un accenno impudico.
E a guardarli insieme trapelava da loro la sofferenza di un dolore senza soluzione.
Nello sguardo della madre di Antonio, prima di raggiante lietezza, ancora inattaccabile dalla crudezza degli eventi, si spense a poco a poco in quei pochi passi compiuti, ogni certezza, trattenuta e difesa con l’ostinazione del rifiuto. Il suo cuore in tumulto si aggrappava all’ombra del dubbio, palesato e partorito dall’stinto di difesa che lottava e si spegneva come un lume nella visione svelata. I due innamorati erano là, intoccabili e inattaccabili; suo figlio Antonio e il fratello di Rosaria, un uomo con un altro uomo!
Si fermò e guardò a lungo, annichilita come una statua, soppesando in silenzio pensieri che l’assalivano in un turbine d’angoscia e di rabbia, sconfiggendola e rivestendola per sempre di una seconda, indelebile pelle. Ora l’orrore la investiva e la ripugnanza dell’evento. La vergogna, il male della natura che consentiva e causava quella perversione erano capitati in casa sua. Proprio a lei, così devota e religiosa, così rispettosa dei suoi doveri, e orgogliosa dell’educazione che aveva dato a suo figlio e che forse…Ma sì, di sicuro lui era solo vittima delle abiezioni di uno sporcaccione che lo stava plagiando approfittando della sua indole timida e vulnerabile…E la ragazza, cosa avrebbe detto…forse sapeva e copriva anche lei col suo silenzio questo inganno, per questo giravano quei bigliettini segreti tra suo figlio e il fratello di lei…No, no, poveretta, di sicuro era stata ingannata, non poteva essere altrimenti.
Quando i suoi occhi però incrociarono quelli del figlio, luminosi ed ardenti di quel fuoco che solo l’amore sa accendere, capì che non c’era più niente da fare. Perché vi lesse la scelta consapevole e definitiva di un uomo e la sua anima.
Pensò allo scandalo che l’avrebbe investita, lei e il suo buon nome. Ne sarebbe morta di dolore, non avrebbe più mostrato la sua faccia in giro. E ne provò una rabbia enorme, la sensazione del tradimento estremo da qualcuno ritenuto incapace di tale empietà. In un moto di ribellione, pensò che forse era ancora a tempo a far cessare quella vergogna, che non era successo ancora nulla di irreparabile, e tutto poteva essere cancellato se fosse intervenuta subito, adesso, a interrompere quell’abominio. I pensieri si accavallavano e le turbinavano in mente, sostenuti da passi incerti e tremanti. Ora era molto vicina, aveva compiuto quei passi quasi vacillando, nascondendosi quasi dietro il grande albero che nulla poteva fare per lei se non ritardare il terrore di doverli fronteggiare, ma quando raggiunse il portone, il suo cuore cercò l’estrema via di fuga, e dinanzi a loro, come un nodo reciso nel sole, la donna perse i sensi.
Si, il nodo di quel cordone che non più legava madre e figlio, e invece di una luce nuova, irradiava ombre infinite di una immagine che era parvenza di morte. Non quella fisica, ma la morte del proprio essere a cui ti costringe il ghetto gelido del labirinto oscuro della mente. Di alcune menti. Di tante menti.
Allora l’omosessualità era considerata una perversione, un’immorale deviazione dalla normalità consacrata, un delitto contro la vita stessa. Ma solo allora? Ed oggi che a distanza i secoli, l’omofobia sembra una piaga insanabile? Si può essere ghettizzati e puniti quando c’è l’amore offerto senza chiedere conto e l’ardore vive della sua sofferenza, senza defraudare alcuno di niente?
Ne sono passati di anni da quel giorno di festa che continua a celebrarsi ogni anno con sacralità e spirito gioioso. Quante cose segrete hanno pulsato, celate dal manto di luce turchina? Quanti desideri custoditi negli scrigni di antiche mura? Qualche anno dopo Antonio sposò una brava ragazza, una sartina amica di famiglia che gli diede due figli, donando così due amati nipoti alla cugina di mia nonna che poté salvare la reputazione della famiglia agli occhi del mondo e rinchiudere quella del figlio nell’involucro di naftalina della sua ipocrita società di benpensanti riguardo il tradizionale rapporto di un uomo con una donna.
Della ragazza si seppe che fece un buon matrimonio con un marittimo del paese, ma era lei stessa un ottimo partito, e visse una vita tranquilla. L’altro, Michele, mi pare che si chiamasse così, scomparve dalla vita di Antonio e si evitò di parlarne in seguito. Ma mia nonna raccontava a mia madre che a quell’angolo della piazza di Santa Croce, si intravedevano spesso due figure maschili, un po’ mature per gli anni, incontrarsi al tramonto e parlare fitto fitto vicini , seminascosti dall’albero di fronte al palazzetto antico. In tanti sapevano e tacevano, e il pudore di questo silenzio, alimentato dalla inviolabilità del segreto perché scrigno di una impudicizia indicibile ed esecrabile, li isolava, ma pure li proteggeva. Avevano inseguito la gioia e in qualche modo ancora l’afferravano e ne stringevano i lembi. E quella era l’unica strada che potevano seguire, un esile e pure indistruttibile sentiero che portava a loro la felicità della conoscenza. E a quel prete che in un’omelia domenicale (ma ci sono quelli che lo fanno nel dialogare quotidiano, i ’Girolamo Savonarola’ dell’identità sentimentale) ha bollato l’omosessualità come un male della società da estirpare, foriero di tremendi castighi divini, mi piacerebbe dire che mi dispiace se forse è stato costretto a rinnegare la sua e a nasconderla nella cassaforte della veste talare. Ci sarà riuscito?
Rinnegare un istinto non ne uccide gli impulsi. E se persino una tonaca, cucita col filo dei vangeli, tesse il pregiudizio, la stoltezza morale di chi la indossa svilisce la sua dignità di uomo che ha rinnegato se stesso, e di prete che vilipende il credo della sua vestizione con messaggi di brutale giustizia, fomentando la segregazione degli uomini tra di loro e abiurando il motto evangelico, i moniti del Papa a combattere la discriminazione e le norme dello Stato secondo le quali gli uomini sono uguali davanti a Dio e dinanzi alla legge. Che fare? Provasse egli a dare e a ricevere amore, mettendo in pratica gli insegnamenti del Vangelo che enuncia dall’alto del suo pulpito. Perché non vada perduta quell’innocenza recondita che permette all’anima di liberarsi dal baratro del rimpianto, e di abbracciare la possibilità di redimersi, per lui e per quelli che spingono alla violenza dell’uno contro l’altro, abiurando la luce buia dell’intolleranza che allontana l’uomo dalla via dell’umanità. |
La sera autunnale spargeva rosei bagliori attraverso i dorati tendaggi, appena trattenuti da un cordone di velluto blu sui vetri azzurrini del grande balcone che affacciava sul portoncino dell’ingresso. Gli scalini, di solito ingombri di foglie soffiate dal vento e leggermente consunti, erano quel giorno ben spazzati e ripuliti fin del più piccolo rametto, asciugati della pur minima traccia di rugiada lasciata dal mattino oscurato da qualche nube vagabonda. Dalle ante socchiuse si percepiva un afflato di spirituale religiosità e condiviso dolore, e nell’interno della casa, nell’ora tiepida e tranquilla del tramonto, si respirava un sussiegoso silenzio, appena rotto da qualche sommesso sussurro e sporadici singhiozzi soffocati. La vita continuava; si immaginava la notte serena nel chiaro di luna, e il raro fruscio delle foglie degli alberi sulla strada faceva presagire il disporsi ordinato di stelle su un cielo limpido e assetato di luci. Nella stanza, una camera da letto non molto grande e costeggiata da mobili austeri e dignitosamente puliti, aleggiava un sentore di afa; qualche lucina qui e là, emessa da due o tre lampade di ceramica, colorate e a forma di anfora, disposte sul comò e sui comodini, accentuava l’odore di chiuso, ripercuotendosi dalla percezione visiva sullo stimolo olfattivo; come un soffio invisibile alitava il senso di malinconico oscurarsi della vita giunta al suo capolinea e al suo ricongiungimento al cordone ombelicale dell’ignoto. Sul letto. alto e di solido legno, la spalliera si ergeva imponente, formando due onde d’ebano con incisi dei rami di vite che si fondevano al centro in un unico grappolo intarsiato. Sulla sommità della spalliera un ricamo di foglie scolpite si stagliava come una piccola, preziosa cornice. L’insieme richiamava alla mente linde visioni agresti, l’odore del muschio nei boschi, il rumore scrosciante delle acque sulle gambe nude sguazzanti nei ruscelli.Ma non erano queste le immagini che gravitavano negli occhi spalancati di quei due o tre bambini che timidamente si affacciavano sull’uscio per spiare i grandi nella stanza; stupore, paura, un riso accennato, erano le sensazioni da loro provate verso un evento percepito per la prima volta nella sua totalità e unicità: l’uomo disteso sul letto, vestito di tutto punto, col vestito buono della festa e i baffi e i capelli lucidati con la brillantina, che non dava segni di vita alcuna e sembrava dormisse profondamente. Ma eccoli subito richiamati, gli impavidi esploratori, dagli adulti, perché ritornassero nella stanza buona degli ospiti, ad attenderli per poi andare via dopo la visita di rito. Qualcuno obbediva, altri ignoravano il comando; la visione nel suo insieme era fonte di grande curiosità. Il capo poggiato al centro del cuscino, era teso e allineato al resto del corpo e lo sovrastava come una vela eretta nel vento a mantenere costante la direzione della barca sulla quale sono disposti, pronti all’uso, i remi, in questo caso le sue lunghe rigide braccia dalle mani nodose, conserte sul petto.
La postura compunta e l’espressione in apparenza assorta del viso, di chi contempla una visione ammaliante nel sogno fantastico, delineavano una figura che, quasi per magia, presa da un impulso irrefrenabile perché posseduta da una idea, potesse in un istante strapparsi il fazzoletto avvolto intorno al viso per impedire alla bocca di aprirsi e, lancia in resta e bandiera spiegata, partire per nuove, ardimentose gesta, sanguigno soldato in sella all’audacia fiammeggiante di un arcobaleno.
Così il suo istinto ardimentoso e ribelle avrebbe dato vita a quel mistero ricco di promesse che si respirava nel fremito del suo silenzio eterno. E in quanto allo spavento degli altri, ancora più esaltante sarebbe stato farsi beffe della sdolcinata contemplazione dei presenti, e ridere del molliccio sentimentalismo e della pavida indole che li dominava e li marchiava esseri sterili e inattivi.
Nel trionfo della sua condizione di uomo isolato dal resto del mondo, egli appariva un gigante fiducioso e silente che riposa sul giaciglio che lui stesso ha predisposto per il riposo dalle fatiche quotidiane, e spiccava non per la sensazione di tetro e inquietudine, ma per l’armoniosa compostezza con cui egli si fondeva e “viveva” nell’ambiente che lo circondava.
Sì perché questo era colui che giaceva sul catafalco, allestito sul grande letto addobbato con il copriletto di damasco blu (tra i pezzi migliori del corredo), le poltroncine di raso dorato ai lati, e fasci di fiori freschi sul comò. Ma niente corone: il mio antenato da tempo dava precise indicazioni al riguardo, considerandole presaghe di ulteriori eventi nefasti e vietandone categoricamente l’uso in caso di morte. Forse però sorrideva al rametto di viole infilato con garbo all’occhiello della sua giacca che addolciva la foggia dell’abito dal taglio severo e rigoroso.
Eccolo, impavido e ardimentoso, dal cuore gonfio degli ideali di giustizia e di libertà, l’uomo pronto ad opporre la sua fede e la tenacia dei suoi principi alla perfidia dell’invasore e alla violazione del diritto sacro della libertà. Zio Domenico, detto “zio Mimì, il garibaldino”, fratello del mio bisnonno e prozio di mia madre, giaceva immobile e sereno, per nulla provato sembra, dal patire delle battaglie e dal sangue forse versato per esse, visto che era morto, per sua fortuna, di una sana e lunga vecchiaia. Sembrava che le difficoltà della vita ne avessero fortificato la tempra, e reso più tenace e convinto lo spirito di fratellanza che lo permeava e l’abnegazione per la sua preservazione e difesa. Mia madre, allora giovane mente in fiore, attenta a moine di gatti, giochi con la palla e salti con la corda, si trovò ad essere testimone inconsapevole e forse riluttante, costretta alla visita di circostanza come altri bambini Se non si sapeva a chi affidarli, loro seguivano i genitori anche negli impegni meno gioiosi; l’importante era non drammatizzare sull’evento e tenerli lontano da immagini cruente. A chiunque le chiedesse notizie a riguardo, amichette incluse, la piccola spettatrice raccontò tutto nei minimi dettagli, ripetendo e mimando coi gesti quello che fu il parere lapidario di mia nonna,:…”Steva frisco e tuosto ca pareva vivo…( Il suo aspetto era sereno ed altero, come quando era vivo). Un’espressione affettuosa, attinta al sanguigno e corposo vocabolario napoletano, così incline con le sue espressioni colorite e vivacemente descrittive fin nell’intima essenza, alla dolcezza del ricordo dei propri cari; in essa, ignorando il pessimismo e rivestendo la realtà del trapasso di un’importanza trascendentale, aveva dimora il segreto svelato che il defunto aveva varcato la soglia dell’altro mondo in ottimo stato fisico, realizzando un perfetto connubio fra materialità cessata ed ardente spiritualità. Nella luce del crepuscolo tutto l’insieme dava più la sensazione di una sopita ma fervente vitalità, anche nei dettagli ornamentali, disposti con cura ad abbellire, ma anche ad annullare il tempo presente per ridarvi l’identità del passato.
Ai piedi del letto, come un’aquila in veglia silenziosa sulle rocce, era distesa su un tappetino di velluto l’amata bandiera della sua giovinezza eroica, il vessillo italiano che aveva brillato sul sacrificio di tanti martiri sventolando come un’egida d’orgoglio
sulle lotte di tanti patrioti. Lo zio Mimì, orgoglioso e nostalgico l’ aveva conservato e protetto da tutto e da tutti, considerandolo il cimelio più nobile e eccelso, quello al cui servizio era stato chiamato dalla fede nello spirito e nella parola di un sublime eroe della vita, colui che avrebbe dischiuso un nuovo percorso alla storia dell’umanità, permeandone il tessuto etico e sociale del suo volto e delle sue azioni: Giuseppe Garibaldi.
Tanto l’amava la sua bandiera il prozio Domenico che non permetteva a nessuno di toccarla. Appoggiata al muro dello studio, accanto a un quadro che raffigurava l’entrata di Garibaldi a Napoli (7settembre 1860), lo zio Mimì di tanto in tanto la
prendeva, l’accarezzava e poi la spiegava ad un vento immaginario di luci e di fermenti, avvinto dalla nostalgia; così raccontavano i familiari, un po’ rassegnati a tale eccentrica abitudine. Egli la impugnava anche quando vedeva in qualche modo vacillare il suo ruolo gerarchico nella famiglia, riconducendo ad essa un significato morale ed autoritario che doveva simboleggiare e riflettere la sua predominanza nell’ambito affettivo, la sua forza di guida anche morale, e la sua intaccabile austerità, immutabile nella preziosità del valore e nella inviolabilità del ricordo. Ne era così geloso che non permetteva a nessuno di prenderla in mano; guai ai bambini che osavano profanarla per giocarci, il vocione tuonante dello zio che li inseguiva per tutta la casa, riempendoli di improperi, rimbalzava per tutta la strada come un tuono echeggiante presago di argini infranti di luci ed esplosioni diamantine di pioggia. Neanche di pulirla permetteva, e a nulla valevano le proteste delle figlie che si offrivano di lavarla e di ricucirne gli strappi. In quella bandiera, inviolabile come un ex voto, respiravano valore, coraggio, ardire, suoi e di tutti quelli che con lui avevano combattuto e di cui poteva vedere a migliaia gli occhi, le braccia, i volti: i suoi compagni, uniti dal giuramento del sangue offerto per nutrire la libertà, la cui storia era cominciata molti anni prima.
Nel 1859, morto il re Ferdinando II, era salito al trono del Regno delle Due Sicilie, il figlio Francesco I, giovane inesperto e di indole inetta. L’odio dei sudditi verso i Borboni aveva origine dalle tante repressioni di ogni moto di libertà e dallo scontento causato dal loro governo. Garibaldi il 5 maggio 1860 partì da Quarto e sbarcò a Marsala, dando inizio alla spedizione dei Mille che doveva liberare il Mezzogiorno. Dopo alcuni giorni occupò l’intera Sicilia suscitando un entusiasmo irrefrenabile con le sue gesta eroiche; il carisma della sua personalità magnetica era incontenibile e le sue vittorie erano circondate da un alone di magica epopea. Accorsero a lui uomini da ogni parte dell’isola e il manipolo di volontari che indossava la gloriosa camicia rossa divenne un grande esercito. Tornato sul continente si unirono a lui il popolo acclamante e persino i soldati borbonici, inizialmente inviati a combatterlo, nell’impeto di una compenetrazione trascinante. Dopo essere passato di trionfo in trionfo, Garibaldi precedendo le sue truppe e senza scorta, entrò a Napoli nel settembre 1860, accolto da migliaia di persone esultanti. E proprio a Napoli il prozio Mimì, focoso ragazzo dallo spirito ribelle e avventuriero, si unì all’esercito di Garibaldi e lo seguì pieno di entusiasmo nella successiva battaglia sul Volturno dove l’audacia del condottiero nizzardo e l’eroismo dei suoi seguaci (le camicie rosse erano meno della metà dei borbonici) riportarono una importante vittoria che sancì il crollo del Regno delle Due Sicilie. Non so se lo zio Mimì abbia indossato anche lui una camicia rossa, di sicuro fiero e sanguigno come pare che fosse, avrà fatto di tutto per averne una e portarla sul cuore, come scudo religioso per osteggiare l’invasore sacrilego. Al grido di guerra, eccolo correre in aiuto dei fratelli in pericolo, marciando alla riscossa con i suoi prodi compagni e la sua amata bandiera, fulcro della sua fede e della sua tenacia, contro l’inclemenza della sorte e le avversità del tempo…
Ma ad un tratto un fruscio rasente, uno scatto improvviso, uno sgattaiolare furtivo eppure stridente come lampi che nel silenzio si lambiscono e si azzuffano, e interrompono quelle magiche visioni. Luigi, uno dei bambini più piccoli, non visto, ha rubato la bandiera, ed ora la sventola facendola garrire al vento dei suoi passi frenetici, e correndo lungo la casa, al grido di “Avanti, seguitemi...!” Gli adulti, superato l’attimo di sconcerto per quello improvviso terremoto causato dal gesto irresponsabile, lo inseguono, tentano di afferrarlo, scandalizzati dall’atto profanatorio, mimando facce terribili, foriere di tempestose punizioni e sussurrando epiteti estremi che fanno presagire momenti difficili per l’autore di tanta dissoluta dissacrazione. Ma il giovane e audace condottiero è velocissimo, sguscia tra le braccia tese ad afferrarlo come un provetto sciatore tra i pali in uno slalom, e quel gesto irriverente, nonostante sia destinato nella sua mente a un epilogo drammatico che consisterà in una lunga prigionia in casa, viene compiuto fino in fondo, assurgendo ad estremo atto liberatorio, esaltante eppure grottescamente divertente. Egli, come una saetta, ha già infilato la porta di casa e corre frenetico nel giardino, tra le risa soffocate degli altri bambini e le minacce di sonori sculaccioni della madre che tenta invano di afferrarlo. Ma l’efficacia prodotta dalla scelta “licenziosa” del colpevole è ormai inarrestabile. Ogni rappresaglia lo lascerà indenne!
“L’attacco al nemico è riuscito e la bandiera è salva!..” penserà soddisfatto il prozio, che ha visto manomettere la sua reliquia del cuore da parenti ed estranei profanatori: quei nemici che forse l’avrebbero anche buttata via dopo le “schioppettate” del rosario funebre. E nel pensiero languente di quell’anima sul suo giaciglio finale, si possono immaginare i cavalli scalpitanti e madidi di sudore che si imbizzarriscono frementi ai colpi di frustino, e gli uomini che gridano ed esultano al fiato delle trombe, avvinti dalla folla esultante che acclama e respira la musica flautata della gioia…
Dopo la difficile attraversata della terra acquisita tra il tuonare delle voci, il rimbombo dei piedi che lo inseguono e le gragnuole delle male parole, il discolo eroe, volto arrossato e sorriso sfrontato, ha già infilato l’asta nel campo conquistato in un’aiuola di fresie. Ora nel vociare di bambini osannanti, la bandiera sventola ardita ed imperiosa nel grido di ‘evviva’, sfolgorando nel cielo alleato, circondata dalle migliaia di baionette dei bagliori d’oro del tramonto guidate dallo zio Mimì, mentre egli percorre la collina dei sogni, agitando il suo sanguigno vessillo…E al suo fianco l’eroe leggendario, che avanza nobile e austero sul suo cavallo Seid nell’immortale entusiasmo dei suoi fratelli di gesta gloriose, annoverando l’ennesima vittoria. Anche l’ultima battaglia è vinta!... |

 Matilde Ciscognetti è nata e vive a Napoli, è commediografa, scrittrice e poetessa, anche in vernacolo. Per la sua attività letteraria ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui il "Premio Vallesenio" per la narrativa; il "Premio Giovanni Gronchi" per la poesia in lingua; il "Premio Nicola Piacente" per la poesia dialettale, attribuitole dall'Assessorato P. I. e Cultura - Centro Ricerche e Studi Dialetti d'Italia - della Città di Bari; il "Premio Città di Mesagne" per il teatro. Tra le sue opere teatrali: "Viole per Vanni"; "Città dimenticata"; "Fole"; "Due più due cinque" ed altri.
Matilde Ciscognetti è nata e vive a Napoli, è commediografa, scrittrice e poetessa, anche in vernacolo. Per la sua attività letteraria ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui il "Premio Vallesenio" per la narrativa; il "Premio Giovanni Gronchi" per la poesia in lingua; il "Premio Nicola Piacente" per la poesia dialettale, attribuitole dall'Assessorato P. I. e Cultura - Centro Ricerche e Studi Dialetti d'Italia - della Città di Bari; il "Premio Città di Mesagne" per il teatro. Tra le sue opere teatrali: "Viole per Vanni"; "Città dimenticata"; "Fole"; "Due più due cinque" ed altri.


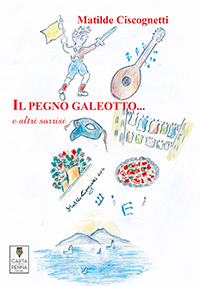 Alcuni dei testi teatrali dell'Autrice sono stati raccolti in questa piccola antologia, seguendo un criterio di selezione basato sulla scelta di varie situazioni i cui intrecci sono tutti basati su vicende umoristiche. I vari argomenti trattati si dipanano attraverso dialoghi salaci e di arguta furbizia (vedi Il Pegno Galeotto), istrionici ed ingenui (Pulcinella e… ), di sottintesa satira sociale (Acqua io…), d'ilarità più immediata (le mini scenette, il primo monologo, anche se non privi anche quest’ultimi di riferimenti a tematiche di respiro più ampio) e di una comicità che predilige l'aspetto grottesco dell'umorismo indiretto (vedi gli ultimi monologhi). 'Il Pegno Galeotto' è stato rappresentato in occasione del Premio; 'Pulcinella e il cappotto di Don Ciccio' è stato realizzato come evento teatrale nell'ambito scolastico. I due ultimi monologhi (tra i primi lavori giovanili) hanno fatto parte della Rassegna Monologhi – Dialoghi del grottesco – 1980.
Alcuni dei testi teatrali dell'Autrice sono stati raccolti in questa piccola antologia, seguendo un criterio di selezione basato sulla scelta di varie situazioni i cui intrecci sono tutti basati su vicende umoristiche. I vari argomenti trattati si dipanano attraverso dialoghi salaci e di arguta furbizia (vedi Il Pegno Galeotto), istrionici ed ingenui (Pulcinella e… ), di sottintesa satira sociale (Acqua io…), d'ilarità più immediata (le mini scenette, il primo monologo, anche se non privi anche quest’ultimi di riferimenti a tematiche di respiro più ampio) e di una comicità che predilige l'aspetto grottesco dell'umorismo indiretto (vedi gli ultimi monologhi). 'Il Pegno Galeotto' è stato rappresentato in occasione del Premio; 'Pulcinella e il cappotto di Don Ciccio' è stato realizzato come evento teatrale nell'ambito scolastico. I due ultimi monologhi (tra i primi lavori giovanili) hanno fatto parte della Rassegna Monologhi – Dialoghi del grottesco – 1980.