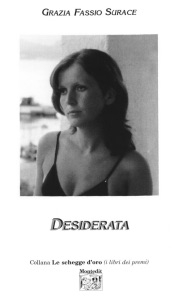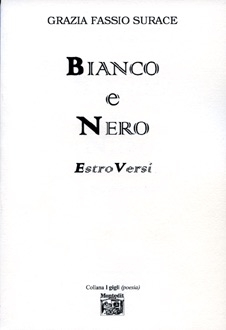|
Fassio Surace Grazia: nata ad Asti, ha da sempre vissuto tra Torino e dintorni. Ha pubblicato il romanzo "Una vita vinta" nel 1990, scritto col marito e le sillogi poetiche "Simpliciter (1998), "Sottovoce" (2000) ed "Acquarelli" (2002).
In seguito ha pubblicato il romanzo DESIDERATA (2004), le sillogi BIANCO E NERO (2009), LIRICHE E FILASTROCCHE (2013) e AFFABULANDO E NON (2018) e il romanzo TI SAZIERAI DI DOLCI (2018 - Carta e Penna Editore) e la silloge poetica A DIEGO (2020 - Carta e Penna Editore).
Nel 2024, con MONTEDIT ha pubblicato la silloge di racconti STORIE VERE O IMMAGINATE, in formato cartaceo ed elettronico.
Centinaia le pubblicazioni su settimanali ad alta diffusione editi da Rizzoli e condè Nast, su antologie (Lietocollelibri, Pagine, Book ecc.), su periodici culturali (Ellin Selae - Tribuna Letteraria - Poeti & Poesia - Talento ecc.), sui quotidiani "La Stampa" e "La Repubblica".
Curatrice del libro "RaccontAbili", raccolta di storie di coraggio quotidiano scritte da invalidi, edita non a fine di lucro da Suracewheelchairs.
Ha vinto tra gli altri:
1° Premio Nuove Lettere 2002 - Ist. Italiano Cultura di Napoli per la raccolta inedita di poesia;
2° Premio Palazzo Grosso 2002 - Riva di Chieri con la silloge edita "Acquarelli";
2° Premio Città di Torino 2001 - Cultura & Società con la silloge edita "Sottovoce";
2° Premio Penna d'Autore di Torino nel 1998 e 2003 per la narrativa inedita;
2° premio "Città di Fucecchio" 2008 per la narrativa edita col romanzo "Desiderata"
3° Premio Città di Lerici 1994 e 3° Premio Penna d'Autore 1997 col romanzo edito "Una vita vinta";
3° Premio Mario Pannunzio 2003 per la poesia e finalista nel 2011 (sempre per la poesia);
1° Premio per la poesia edita conferito da ARTISTI CON IL CUORE - SAN REMO NEL 2012, alla silloge poetica BIANCO E NERO ed. Montedit;
2° Premio sezione poesia edita al Concorso degli Assi - anno 2012 - indetto da Carta e Penna con la silloge poetica BIANCO E NERO ed. Montedit;
la silloge A DIEGO ha ricevuto - nel settembre 2024 - la menzione d'onore per la poesia edita nel concorso di Poesia e Narrativa “Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”, organizzato dall'associazione culturale Il Volo dell’Arte.
|
Con Carta e Penna ha pubblicato:
TI SAZIERAI DI DOLCI |

I fatti narrati sono tutti realmente accaduti e le persone sono reali. Solo alcuni nomi sono stati volutamente cambiati per discrezione.
Ti sazierai di dolci è la storia di Nino, un bimbo che agli inizi degli anni ‘50 si trasferisce da un piccolo paese della Sila in una grande città del nord.
Le difficoltà che il piccolo protagonista deve affrontare sono infinite: infelicità, lacrime, solitudine, morte di persone a lui care, miseria... ma poi il riscatto: felicità, successo, benessere e amore. Una favola a lieto fine, in cui trionfa la serenità e l’armonia.
Stilisticamente il lavoro è ben condotto, curato nei dialoghi, sempre sobri e ben articolati, che delineano con chiarezza il carattere e il nucleo psicologico dei personaggi.
Diego e Grazia Surace vivono nei pressi di Torino.
Lui imprenditore di successo, lei poetessa e scrittrice, ha pubblicato diverse raccolte di poesie e nel 2004 il romanzo Desiderata, edito da Montedit.
Un giorno hanno deciso di raccontare una favola, una favola vera, ed è nato questo romanzo.
L'ebook è in distribuzione sulle maggiori librerie digitali: Amazon, IBS, laFeltrinelli ecc.
Il formato cartaceo è anche distribuito dall'editore: scrivere mail a cartaepenna@cartaepenna.it o telefonare alla segreteria al 339.25.43.034.
|
A DIEGO |
 Grazia tesse in versi uno struggente dialogo con il compagno ammalato:IL TARLONella scrivania c’era troppo sole……ma un sentore di tempesta era nella mia testa.ATTIRAVAMO STRALICapelli bianchila mano nella manoe penso a noi com’eravamoti amo tantie poi bisticci di paroleamore e non amoreingrati alla benevole sorteattiravamo strali.QUEL MALEDETTO 23 OTTOBREEra l’albore di un mattino chiaroquand’hai percepito un vuoto dolore.L’ora ingrata era infine scoccata.
Grazia tesse in versi uno struggente dialogo con il compagno ammalato:IL TARLONella scrivania c’era troppo sole……ma un sentore di tempesta era nella mia testa.ATTIRAVAMO STRALICapelli bianchila mano nella manoe penso a noi com’eravamoti amo tantie poi bisticci di paroleamore e non amoreingrati alla benevole sorteattiravamo strali.QUEL MALEDETTO 23 OTTOBREEra l’albore di un mattino chiaroquand’hai percepito un vuoto dolore.L’ora ingrata era infine scoccata.
_______________________________
Questa silloge ha ricevuto la menzione d'onore per la poesia edita nel concorso di Poesia e Narrativa “Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”, organizzato dall'associazione culturale Il Volo dell’Arte.
_______________________________
|
Per i lettori di Carta e Penna ha scelto:
AFFABULANDO E NON - EDIZIONI MONTEDIT, 2018, |
Recensione di Fulvio Castellani
Tra armonie, asprezze, assenze, ardori, acquerelli e accidie si muovono i pensieri sparsi in versi delicati e affabulanti che Grazia Fassio Surace ci consegna tracciando itinerari di un Io quanto mai sensibile e abbeverato di luce iridescente. È un viaggiare, il suo, che evidenzia alla grande il suo "dire con leggerezza cose tremende", come ha rimarcato anche Maria Grazia Calandrone, e contemporaneamente con profondità il rotolare di profumi ciarlieri raccolti con quotidiana filosofia e colorata serenità.
C'è l'amore per la vita, per la bellezza, per l'ambiente, per chi le sta accanto... a marchiare a trecentosessanta gradi il suo itinerario poetico, il suo piacere di scrivere, di mostrare l'estate nuda, di gustare i baci della luna, di cantare le molli carezze di un sogno, di camminare ancora tra la gente, di curiosare, di "consumare le scarpe" per scoprire ancora e ancora altre bellezze, altre emozioni, altri paesaggi, altri ricordi...
Non dà freno al suo non invecchiare; il suo passo è spedito; il suo sorriso è pieno; il suo verso, di conseguenza, è una fattispecie di grande contenitore di rughe piacevoli su un viso "imbronciato di sorrisi"...
Quanta grazia nel suo spettinare ad arte i segni del tempo che fugge! Quanto amore nel suo abito interiore mai esangue che esplora e si accende di passione ad ogni battito del cuore!
Grazia Fassio Surace dimostra, pertanto, un concentrato di analisi ed una collaterale apertura al racconto, ossia la capacità di sintesi e di trasparenza espressiva. Come a dire che la sua poesia respira, in un certo qual modo, il fascino della natura in ogni sua espressione: un fascino che si sostanzia in versi brevi e in quadretti lirici altrettanto concisi, chiari.
Leggere le accelerazioni e le riflessioni di Grazia Fassio Surace diventa un piacere, un invito, cosicché le immagini vengono rivisitate da chi legge e gustate una ad una come le noccioline o le castagne d'autunno.
È come un risveglio continuo, un conversare con il tempo che ci ha accompagnato e ci accompagna nel segno dell'amore, nonostante tutto... In estrema sintesi la sua poesia è un po' come un profumo che si rinnova e che la fa dire, rivolgendosi ad un "tu" familiare: "Lo sai è profumo / l'odore di notte / sulla tua pelle / amore" oppure "Rassicura il tuo respirarmi accanto / nella notte scura" nella certezza di essere con ciò "ancora viva ignara magari / in una giornata chiara".
Un affabulare, quindi, questo di Grazia Fassio Surace, da centellinare con altrettanta gioia, con "libertà assoluta / cuore solare". |
LIRICHE E FILASTROCCHE - SILLOGE POETICA EDITA DA MONTEDIT, 2013 |
Recensione di Fulvio Castellani (UD)
Sarebbe sufficiente la frase “Non viaggio mai senza i miei sogni” messa in apertura di questa nuova silloge, che segue e completa la precedente dal titolo “Bianco e nero”, per entrare nel vivo del fare poesia e di catturare a sé la vita di Grazia Fassio Surace, un'autrice che riesce sempre a volare alto con i suoi pensieri e le tante colorature che pennellano, alla grande, emozioni, realtà, scampoli di storia personale, angoli di luce raccolta a tu per tu con la natura in ogni sua dimensione e proiezione. Ma c'è dell'altro, e molto. A cominciare dal viaggiare discreto a ritroso, rileggendo i propri passi e l'altalenante sinfonia di un vespero sull'isola, di un tramonto a Torino, di una carezza insperata con la luna piena che concilia un abbraccio di pace con il mondo. E quindi, proseguendo, enumerando gli incontri del presente mentre in lontanaza “la falce della luna taglia / i nostri sguardi fatti d'aria.” E ancora suggerendo opportunità e sprazzi ascendenti di luce anche se “non si ha sempre il sole nel cuore”… Grazia Fassio Surace usa versi brevi solitamente, immagini dal respiro forte e immediato, aperture improvvise in direzione di un carezza tremula che riesce, con continuità, a ricevere prima di tutto dalla luna (la luna, infatti, figura assai spesso nelle liriche e nelle filastrocche dai toni a dir poco affettuosi) e poi dagli acquarelli che abbracciano, sorridendo, i colori dei prati, il frusciare dell'erba a sera in un'altalena di passi, di sorrisi, di incontri, di parole, di silenzi… Va detto che “Liriche e filastrocche” è stato suddiviso in sette sezioni: Armonie, Ardori, Asprezze, Assenze, Affabulando e non, Acquarelli e Accidie. A nostro avviso la lettera A, con cui iniziano le parole che fanno da titolo alle singole sezioni, ha già di per sé, in nuce, la valenza delle singole composizioni poetiche in quanto la lettera A apre il nostro alfabeto e usarla come apri–pista di ogni sezione sta a significare quanto importanti siano i passaggi e i ritorni dipinti dell'autrice piemontese. Ogni sezione, poi, è preceduta da una frase o da alcuni versi di personaggi famosi come Mario Luzi, Corrado Calabrò, Eugenio Montale, Patrizia Valduga, Emily Dickinson e altri. Sono sufficienti poche versi a Grazia Fassio Surace (“Scusami / ma ho una vita sola / che mi vola / tra le dita” oppure nella poesia Testamento: “Non lasciarmi in pasto ai vermi della terra scura”) per farmi dire (e non accade sovente nel mio caso) che ci troviamo di fronte a una poetessa da incorniciare e che si fa leggere e rileggere perché volare è bello con le ali del suo io e perché rende possibile, almeno idealmente, “andare andare / dalla realtà amara fuggire” percorrendo “invero la realtà / con piedi di vetro / all'eterna ricerca di fole / e parole parole…” |
 |
DESIDERATA |
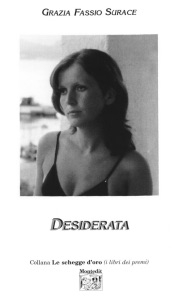 |
Nel 2004 ha pubblicato il romanzo Desiderata con le edizioni Montedit di cui pubblichiamo la recensione della poetessa Isabella Michela Affinito:
Pur non essendo un libro autobiografico, "Desiderata" è un archivio di sensazioni, stati d'animo, pensieri antitetici, ribellioni interiori e altro ancora, accortamente descritti da Grazia Fassio, nata ad Asti e vissuta a Torino e dintorni. Nel seguire la parabola esistenziale della vita di Desiderata (nome della protagonista del libro), viene in mente la parabola dell'evoluzione della donna in generale, la sua faticosa ascesa verso l'emancipazione, la conquista di un ruolo sociale parimenti a quello dell'uomo. La scrittrice nel parlare delle vicende - prima infantili adolescenziali e della divenuta donna - della protagonista, guarda molto più avanti delle stesse vicissitudini giornaliere di Desiderata, poiché il suo stile di scrittrice si è aperto ai venti che spiravano negli anni '60, periodo in cui le donne lottavano nell'ambito del movimento femminista per la nascita dei nuovi ruoli della donna, che avrebbero preso il posto di quelli tradizionali. La storia di Desiderata, o meglio la sua fase giovanile e oltre, si colloca in quel preciso momento storico, vale a dire che tutto ciò che nel bene e nel male capitò a Desiderata, in effetti è capitato alla maggior parte delle donne di ieri e di oggi. Dopo un'infanzia trascorsa nell'ovattato isolamento di figlia unica, Desiderata si accorgerà, dopo la morte (intenzionata?) del padre per un incidente automobilistico, di essere stata ingannata dal lui e con essa anche la mamma. Caduta in disgrazia per pagare i creditori del padre, Desirée scoprirà la crudezza d'animo nelle persone alle quali si rivolgerà per cercare lavoro, crudezza fatta di puro egoismo, edonismo, materialità oltre i quali non ci sarà più niente, mentre lei credeva di scorgervi i veri sentimenti umani. Si illudeva, rimarrà ferita nell'animo e nella mente per molti anni, fino a quando, continuando a credere nell'amore, non si sposerà con un uomo che sembrerà capirla. Ma le mancherà un figlio, quel figlio rifiutato molti anni addietro quando cercava di soddisfare il corpo e non l'anima, e per non diventare ragazza-madre aveva scelto l'altra ignobile possibilità, quando un tragico incidente stradale mise fine alla sua imbarazzante condizione. Un percorso, quello di Desiderata, uguale a tante altre ragazze prima e donne poi, che hanno lottato per superare la loro futile apparenza di donne per arrivare ad essere considerate per il loro operato, frutto di scelte e di incresciose rinunce.
L'INCONTRO, tratto dal romanzo Desiderata
Lo notai, la prima volta, un giorno sul finire di ottobre, alla tavola calda dove talora pranzavo, quand’ero troppo stanca per tornare a casa.
Eppure la sua immagine non mi era nuova.
Ecco: ricordava Bob, nei lineamenti, negli occhi chiari, nella figura alta, slanciata ed al tempo stesso vigorosa. I capelli neri, un po’ lunghi sul collo, erano lievemente spettinati, e una ciocca ricadeva ribelle sulla fronte.
Senza volerlo, ero rimasta incantata a fissarlo. Lui doveva aver sentito lo sguardo, perché si voltò, mi vide, e catturò i miei occhi.
Io ero imbarazzata ma non riuscivo a distogliere lo sguardo.
Aveva ordinato un panino e una birra al banco, e pareva solo.
Con me c’era Rita, la mia collega, alla quale non era sfuggito (sarebbe stato molto difficile) l’ardore delle nostre occhiate.
Mi aveva guardato complice e poi, senza interpellarmi, con la sfacciataggine consentitale dall’età, lo aveva invitato al tavolo.
Egli aveva sorriso e dicendo “Perché no. Con piacere!” si era seduto con noi.
Rita gli aveva chiesto allora se lavorasse da quelle parti. Aveva risposto: “Sì, qui vicino. Da pochi giorni.”
E mentre mi guardava e sorrideva.
Ero infuriata con Rita.
Mangiai in fretta, salutai, e me ne andai senza aspettarla.
Nell’attesa della riapertura della libreria passeggiai sotto i portici, cercando d’interessarmi alle vetrine.
Ma non vi riuscii: sentivo ancora sulla pelle l’insistenza la passionalità del suo sguardo, e negli occhi m’era rimasto il suo sorriso.
E quando lo intravidi riflesso nel vetro che attraversava la strada, e sembrava venisse verso di me, fuggii e, anche s’era presto, passando attraverso la porta del retro, mi rifugiai in negozio.
Dentro litigai per la prima volta con Rita. Le rinfacciai l’invadenza. Ribatté che l’aveva fatto per me. Aveva notato quanto mi piacesse. E che io piacevo a lui. E aveva voluto aiutarci.
Urlai: “Un’altra volta fatti gli affari tuoi!”
E lei, di rimando: “Desirée, sei stupida, lasciatelo dire!”
Ed io: “Sono stupida, d’accordo! Ma contenta d’esserlo. Non impicciarti più!”
Iniziò a borbottare: “Non riesco a capirti. A capire la tua vita d’asceta. Sei giovane bella, ma mi fai pena. Che cos’è che ti ha fatto diventare così? Tu non sei la mummia che sembri. Fai la mummia per difesa. Ti ho capito. Ma, lasciatelo dire da una che non è più giovane, la giovinezza non si ripete, quando finisce si può solo rimpiangere di non averla vissuta. Anche a costo di soffrire. Un bocconcino come quello, fosse anche solo per una notte, io non me lo proibirei, puoi star sicura! Purtroppo non mi avrebbe voluto neanche quand’ero giovane, perché non sono mai stata bella!”
La grossa testa ricciuta ballonzolava mentre parlava e, dietro le spesse lenti, gli occhi erano lucidi e mandavano faville. Mi fece ridere.
“Immorale! Svergognata!” le dissi, abbracciandola.
“Non sei offesa?”
“No. Ti voglio bene. Scusami. Lo so che lo hai fatto per me. Ma non farlo più. Abbiamo fatto una figura di m.... Avrà riso di noi.”
“Non ha riso di noi. Quando sei andata via abbiamo parlato. Mi ha detto che appena ti ha visto si è innamorato. E che non ti libererai facilmente di lui. Beata te!”
“Ti troverò un amante per spegnere i tuoi bollori. Ma, ripeto, non impicciarti! Naturalmente avrai parlato di me …”
“Poche parole. Che hai scritto un romanzo …”
“Lo avrei giurato!”
“Che vivi con tua madre. Che non ti ho mai vista con un ragazzo. Che sei una figliola d’oro. La migliore che conosco...”
“ E poi?”
“Nient’altro. Lo giuro!”
“Inguaribile pettegola. Hai detto fin troppo. Perché mi hai incensato? Non mi conosci a fondo… Che sai di me?”
Mise il broncio, ma subito si rischiarò.
“Però ho fatto anche a lui delle domande. Si è appena laureato. È architetto. Si chiama Marco.”
“Basta” la interruppi “Non voglio sapere altro. Chiudiamo l’argomento. Va bene?”
“Ma un amante me lo trovi?”
Ghignava in quel suo modo buffo e un po’ malizioso, da sempiterna bambina.
Non mi riuscì di stare seria.
Ridemmo insieme.
Tratto da Desiderata, romanzo pubblicato con Montedit |
BIANCO E NERO - RACCOLTA POETICA - ED. MONTEDIT, 2010 |
Recensione di Fulvio CASTELLANI pubblicata su Il Salotto degli Autori, n. 41 - Autunno 2012
Autrice di romanzi (esemplare e a dir poco coinvolgente Desiderata per grafia espressiva e per studio dei personaggi) e di sillogi poetiche come Simpliciter (1998), Sottovoce (2000) e Acquarelli (2002), Grazia Fassio Surace, che vive nell’hinterland torinese, ci offre in questa sua nuova cavalcata poetica, una ulteriore prova di maturità e di ampiezza linguistico-formale.
“Spero che i miei versi, nel loro porgersi nudi e veri, abbiano la forza empatica delle emozioni universali”, ha fatto presente nella breve nota introduttiva alla silloge Bianco e nero che si compone di sette stazioni di sosta, ovvero di altrettante plaquette unitarie e tra loro comunque intersecanti per profondità di immagini, pensieri, giochi di luci ed ombre, di scampoli di gioia e di apatia, di accelerazioni e di retromarcie. Come a voler significare d’un subito che il bianco e il nero vanno di pari passo anche se l’uno dispone alla felicità e alla serenità, e l’altro condensa malinconie e pessimistiche proiezioni per il dopo.
Si notano in Grazia Fassio Surace luminosità e carezzevoli armonie se parla dell’amore (Lo sai è profumo / l’odore di notte / sulla tua pelle / amore), se fotografa la poesia (è brezza di farfalla / posa lieve sul cuore / non deve far rumore /né urtare solo dare /vecchie nuove emozioni), se aggiunge al concreto e alla realtà non sempre, purtroppo, gratificante quel pizzico di verve fantasiosa e colorata (Le giovani casalingue / con un conto in banca pingue / chissà perché hanno anche / gambe lunghe da gazzella / vita da vespa ombelico a vista / auto di corrispondente altezza...).
C’è sempre, in ogni sezione del libro, una chiave di lettura che consente di appropriarci appieno del suo mondo poetico, del suo itinerario dentro la vita, il sogno, la verità, le occasioni per non lasciare che l’attimo sfugga di mano e che la luce in qualche modo perda la sua luminosità creativa. La poesia di Grazia Fassio Surace è in ogni circostanza comprensibilissima, non gioca a nascondino con le parole, va al fondo delle cose e degli argomenti senza costringere ad una rilettura; e questo quasi facendo suo quanto diceva Schopenhauer, ovvero che “Non vi è nulla di più facile che scrivere in modo tale che nessuno capisca”. È una poesia, dunque, che è poesia e basta, e non intrecci di fumo, di stucchevoli arzigogoli che, alla fin fine, dicono ben poco o niente.
Non a caso, del resto, hanno parlato di lei in maniera oltremodo positiva, tra gli altri, anche Maurizio Cucchi, Massimo Scrignoli, Stefano Valentini, Sandro Gros-Pietro, Giancarlo Piciarelli, Riccardo Ponti... |
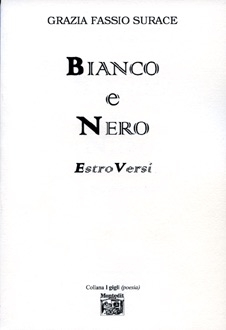 |
TI SAZIERAI DI DOLCI |
Primo capitolo dell’omonimo romanzo di Grazia Fassio Surace e Diego Surace
«Nino, Nino, figlio mio, è ora. Alzati. Lu postale sta per partire.» Filomena, la madre, seduta sul bordo del lettino, gli sussurrava nell’orecchio, quasi per non svegliarlo. Il ragazzino era ancora assopito e lei, accarezzandogli i capelli, lo chiamò con voce più ferma.
Il gallo non aveva ancora cantato nel pollaio dei vicini e fuori era ancora notte. Soltanto lontano, verso il mare, al di là del “varrancu” (il dirupo che, sotto il paese abbarbicato, sprofondava nella valle) un lieve chiarore tradiva lo spuntare del giorno.
«Nino, sbrigati. Alle cinque e mezza lu postale parte e non aspetta. Vestiti.»
Era Filomena una donna di circa trentacinque anni, alta e magra, a parte il ventre sformato dalle maternità. I grandi e rotondi occhi castani divoravano un viso dai lineamenti minuti. I capelli bruni erano strettamente raccolti sulla nuca, il vestito era lungo e nero, e ricadeva in pieghe morbide sui fianchi.
Quella notte la povera madre non aveva dormito. Aveva preparato la valigia di cartone del figlio che partiva, riempiendola con pochi indumenti puliti e rammendati: una camicia del padre ridotta, un paio di calzoni da adulti ancora troppo larghi nonostante le molte cuciture per restringerli, il pullover senza maniche della nonna con le asole rivoltate in modo da farne un indumento da ragazzo, un po’ di biancheria.
Poi, aveva trascorso il resto della notte seduta sulla vecchia sedia di paglia, vicino al tavolo, il gomito su di esso e la testa appoggiata ed appena ripiegata nel palmo della mano, lo sguardo fisso verso il lettino dove Nino dormiva. Forse per l’ultima volta.
Lo intravedeva appena alla luce del lume ad olio, e le ombre erano popolate di paure ed angosce. Un pensiero soprattutto la assillava: “Lo rivedrò ancora? Già mi avete preso due figli in tenera età, Signore, non portatemi via anche questo...” Ed era una preghiera, mentre lacrime irrefrenabili maceravano le gote stanche.
Allora, per alleviare il dolore, cercava di soffermarsi sui momenti lieti trascorsi col figlio, ma inutilmente, perché la sofferenza, accresciuta dalla nostalgia, riprendeva il sopravvento, cancellando il sorriso che i ricordi le avevano appena abbozzato sulle labbra.
“Dio, ha solo nove anni! È un bambino. E parte solo per una grande città per andare a lavorare, quando dovrebbe giocare.” E guardò le braccia e le gambe magre pensando: “Fosse almeno robusto, invece è così sottile .”
Eppure la fortuna sembrava averlo baciato, quand’era nato. Molto affetto lo circondava, perché era il primo figlio, tanto atteso, dopo quattro anni di matrimonio.
E poi era bellissimo, e gli occhi erano così vispi ed allegri che tante stelline sembravano essersi concentrate in quei pezzetti scintillanti di cielo. Nasceva, inoltre, in una famiglia benestante. Le carbonaie che suo padre aveva nella Sila rendevano parecchio. Poi, per faciloneria, sfortuna, o incapacità, egli aveva perso tutto. E in modo tragico ed irrimediabile da non avere, in breve tempo, quasi da sfamare la famiglia (che frattanto era aumentata: erano nati un altro maschio ed una femmina, oltre ai due figli morti di pochi mesi). L’avversa sorte aveva poi continuato ad accanirsi finché era stato costretto a lasciare la Calabria, dove non aveva trovato lavoro, ed emigrare, per il momento da solo, a Torino, in cerca di migliore fortuna.
Don Rocco “gargia” (il gradasso), così soprannominato al paese, il padroncino una volta rispettato da tutti, ora era soltanto un manovale con una paga di ottocento lire al giorno. E al Nord non poteva aspirare ad altro un pover’uomo, sradicato dal suo ambiente che, mestiere e prestanza fisica a parte, sapeva a malapena leggere e scrivere.
* * *
La lettera del marito era arrivata appena tre giorni prima. Filomena l’aveva aperta un po’ sorpresa. Rocco non le scriveva spesso.
Questa volta le notizie non erano le solite. Scriveva che aveva trovato un lavoro per Nino, da un panettiere pasticciere, e che, se il figlio lo avesse raggiunto, quella sarebbe stata una buona occasione, anche perché il negozio era proprio vicino all’abitazione. Però doveva partire subito.
Così Nino, a nove anni, andava a fare il panettiere.
* * *
Ora il bimbo era sveglio, ma gli occhi erano tristi, lontani, maturi, non c’era più traccia di quel brillìo di stelline che li rallegrava fino a poco tempo prima.
Al lume della lampada, la madre lo guardava armeggiare per infilarsi un calzino. Lui, chinato, percepì lo sguardo, e abbozzò un sorriso che voleva essere rassicurante.
Ma Filomena comprese che aveva paura e non voleva dimostrarlo e allora, un po’ per rincuorarlo, un po’ per invogliarlo, un po’ per far coraggio a sé stessa, quasi per trovare una giustificazione a tutto, gli disse: «Vedrai che ti gurdi. Ti gurdi di duci.» Ti sazierai di dolci.
Sperava così, con quella immagine di golosità che dovrebbe incantare qualunque bambino, di averlo tranquillizzato.
* * *
Poi riprese ad incalzarlo, a mettergli fretta, non sapeva nemmeno lei se effettivamente per timore che perdesse la corriera, o per affrettare il distacco che, nell’attesa, diventava sempre più insopportabile.
Intanto i pensieri si dissolvevano e si riformavano incessanti. Un momento le sembrava che tutto dovesse andare meglio per Nino in città, perlomeno avrebbe avuto da sfamarsi, ma un istante dopo già tutto precipitava nel buio del pessimismo più nero. Ed era come rinascere e morire infinite volte. Nino, intanto, aveva finito di sbocconcellare il suo pane. Gettò un ultimo sguardo alle pareti note, al fratellino ed alle sorelle ancora addormentate (le sorelle erano due, ora, l’ultima nata aveva pochi mesi).
La madre raccolse il misero bagaglio, uscirono in strada, e la porta si richiuse sulla lampada rimasta accesa.
Al bimbo, il tonfo sordo dell’uscio, sembrò che recidesse definitivamente ogni legame con il passato.
Camminarono in silenzio per i viottoli deserti, accompagnati soltanto dal tamburellare dei loro passi sull’acciottolato smosso. A tratti, lei riusciva a vincere la commozione e a mormorargli le raccomandazioni già ripetute cento volte, stai attento a questo e a quello, alle auto, ai tram, al caldo, al freddo, tanto che il ragazzino non l’ascoltava quasi più e si lasciava andare facendosi trascinare per un braccio. Tutte le altre cose che avrebbero voluto dirsi, affettuose, tenere, rimanevano racchiuse nei loro cuori, incapaci di mutarsi in parole.
Giunsero in piazza, alla fermata della corriera.
Nino, nella tasca dei calzoni corti, aveva il biglietto per Vibo Valentia, i soldi per la littorina fino a Santa Eufemia e quelli per il treno che l’avrebbe portato a Torino. In mano, un sacchetto, fatto con una calza rammendata, contenente qualche uovo sodo, un po’ di carrube, di noci e castagne secche, e un pezzo di pane, e, in terra, la valigia di cartone legata con uno spago.
Filomena lo teneva per mano, in un ultimo gesto di protezione. Finalmente l’autobus arrivò.
Un bacio, un abbraccio strettissimo, poi la madre aiutò il ragazzino a salire, passandogli quindi la valigia, che lui sistemò sopra l’apposita reticella.
Ancora una raccomandazione, attraverso il finestrino aperto, mentre la corriera si muoveva, e a Nino rimase negli occhi quell’ultima immagine di sua madre, alta e magra, lo scialle nero sul capo, bianca in viso come una morta, che agitava la mano in un tentativo incerto di saluto, sforzandosi di sorridere, tra stille di pianto.
Per la prima volta, si sentì solo. Rannicchiato sul sedile, il naso schiacciato contro il vetro del finestrino che aveva richiuso, lottava contro le lacrime che gli annegavano gli occhi, ed evitava di guardare gli altri viaggiatori, per timore che scoprissero la sua disperazione.
Alla prima svolta, “lu giruni” (il curvone), tutte le case scomparvero di colpo, come spazzate via dal cartello indicatore del comune. E quel giorno, precisamente il 21 agosto 1951, il piccolo emigrante disse addio ai luoghi che l’avevano visto nascere e crescere, e alla sua breve infanzia.
* * *
Addio, vecchio paese. Due file di case biancastre abbarbicate sulla cresta della collina, ai piedi della Sila, 300 metri sul livello del mare. Quest’ultimo si scorge in lontananza dalle finestre delle case affacciate sullo strapiombo del “varrancu”, e dalla piazza, vanto del paese, alla cui balaustra s’appoggiano gli uomini, quando il tempo è bello, per conversare. Tremila abitanti, allora, la caserma dei carabinieri, due chiese, l’ufficio postale, il bar e le botteghe, che i vecchi chiamavano “apoteche”, dove, a quel tempo, i ragazzini imparavano un mestiere, portandosi la sedia da casa.
Addio, casa che ha visto i primi passi, i primi giochi, ed ha udito le prime parole di questo bimbo che già è costretto ad affrontare la vita. Serrata tra le altre, è a due piani, costruita nel 1924, come attesta l’iscrizione sul frontale, e ha la facciata sulla via “Granda” e il retro sospeso sul “varrancu”. Sulla ripida scarpata di quest’ultimo si affacciano pure i cessi di mezzo paese, che scaricano direttamente tra il verde degli oliveti e delle ficaie. Addio, alle corse giù per i viottoli sul carrettino a quattro ruote, costruito da solo, al gioco del “lu piroci” (una trottola a cono con un lungo filo per lanciarla e farla girare), del cerchio, della “striglia” (la settimana), delle monetine gettate contro il muro; alle partite a briscola o ad asso pigliatutto.
Addio Pasqualino, Nicola, e Aurelio, miei compagni di giochi e di birichinate. Non ci caleremo più nei pozzi profondi, puntellandoci con i piedi scalzi alle pareti di cemento liscio fin giù, dove, a guardare in alto, l’orifizio appare poco più grande di una luna piena, e non salteremo ancora da un albero all’altro, rubando frutta matura. Addio, zio negoziante, finalmente non dovrò più arrossire nel sentirti rinfacciarmi il pane acquistato a credito. Addio, mamma.
Ti vedrò ancora? |
LIRICHE TRATTE DALLA RACCOLTA AFFABULANDO E NON |
Liriche tratte dalla raccolta AFFABULANDO E NON,
edita nel 2018 da Montedit
VICINANZA
Rassicura il tuo respirarmi accanto
nella notte scura.
DIVERSI UGUALI
L’altro è chi è nato diverso da te
chi una gamba ha perso
l’altro sei tu.
Diverso è chi vive in strada
mentre tu hai una casa
diverso sei tu.
L’altro è chi chiami matto
il bianco dal mulatto
l’altro sei tu.
Il sorriso in viso la mano che stringi
spariglia la vita
infine giochiamo la stessa partita.
IL MARE BLU
Quando entri in acqua tu
il mare è più blu.
ABITARE LA DISTANZA
Per salvarsi abitare la distanza
dalla stanza del dolore?
Impensabile, quando c’è amore.
TEMPORALE
E all’improvviso fu tutto giallo
il giallo come oro fuso scese
dal Monviso
a pitturare campi e fiori
visi e cose, castelli e case
poi il cielo si colorò di viola acceso
le nuvole rosse di fuoco
e il vento squassava spazzava furioso
e il mondo si fece nero come pece
ed era tutto nero
scuro come la notte
e cateratte d’acqua e sfere di ghiaccio
franavano dal cielo tra lampi e tuoni.
Poi si rischiarò improvviso il giorno
e giunse una pace tenera lilla
a coprire le cose.
L'ALTROVE
(C'è nel tuo scrivere uno struggente desiderio d'altrove)
Desideri l'altrove?
Cercalo! Dove?
Ma dov'è il tuo altrove?
Figlia e poi sposa
l'amore carceriere
ha chiuso l'alveare dei pensieri
stretti lacci d'organza
sanciti modi e tempi
non tua
una vita.
IGNAVIA
Srotola lento il tempo
nei giorni senza appetenza o intento.
TRE GENERAZIONI IN VACANZA
L'hotel era su un dosso
galleggiante sull'oro del mar Rosso
quattro stanze un terrazzo
e dieci manine che bussavano
al mattino in sequenza
reclamando carezze e clemenza
per i salti sul letto,
ma erano giorni chiari perfetti
sere calde sul mare
a ballare scalzi
al pallido tepore delle stelle
che imperlava le spalle.
Ho perso il cellulare, ma a chi devo telefonare?
S'ERANO INCONTRATI
S'erano incontrati un giorno d'inverno,
mia madre bella,
un poco fredda,
mio padre forte,
forgiato dalla sorte
avversa,
la barca il Po,
il loro amore
a remare.
ABITIAMO LA SPERANZA
Lo sfizio d’un inizio
di qualcosa
l’ho avuto da sempre:
ragazzina in collegio
poetavo sul bordo della mensa
aspettando chissà cosa,
o nell’ozio d’una calda estate
tracciavo sogni
su fogli sparsi alla rinfusa
sognando in rosa.
Trascorsi! Fili bianchi tra i capelli
ora vorrei giorni belli per figli
e figli dei figli e giovani spersi.
Ma senza lavoro affonda la vita.
E mi sento smarrita.
In rete dialoghi tra sordi
che ascoltano solo sé stessi.
Mai stati così soli.
Dimenticate le parole guardandosi negli occhi,
la penna sul foglio, sfogliare un libro,
l’odore della carta e dell’inchiostro.
Miete vittime l’odio.
L’egoismo annienta.
In questo contesto è utopia
sognare un futuro decente?
Eppure credeteci ragazzi,
abitate insieme la speranza,
attizzate lo spento dello sguardo,
reagite inventate amate e forse
un bel traguardo è possibile.
DATEMI UNA STELLA
Datemi una stella su cui stare e me ne andrò,
una piccola stella luminosa
Venere, che non è poi una stella,
o Sirio, non so,
solo una piccola stella su cui stare a guardarvi
senza interferire,
sono stanca, di questa vita incerta ho paura,
sarò finalmente cenere spenta che vive.
VESPERO SULL’ISOLA
C’è poesia in questa estate sfatta
sfumata d’afa che lenta scende
e si stempera sul mare nella sera.
Nella rena ragazzini si sfiorano appena
un braccio una gamba timorosi
sognando amplessi più amorosi.
C’è poesia in quest’estate umida
che scivola e discolora sull’isola
ora all’imbrunire viola.
Guardo monelli in cerca di mitili
assorti frugare tra scogli rotondi
e vecchi al buio fissare ricordi.
C’è poesia in questa sera calda
estranea al tempo.
TESTAMENTO
Vedi quel glicine che all’albero s’attorciglia
potrebbe essere il mio riposo culla tra il viola
quasi una diafana chiglia tra il verde e il nulla.
Non lasciarmi in pasto ai vermi nella terra scura.
ALIENA
(in discoteca)
Il locale passava per trendy
ma la musica a decibel mille
dopo tre drink squassava
quel po’ di self control che ci restava
eppure una ragazza forse di paese
un abito rosso la giacca turchese
capelli amaranto dal taglio a casaccio
vertiginose le scarpe col tacco
a suo modo con pretese d’eleganza
la ragazza era come chiusa in una stanza,
in mezzo alla movida e al vociare
ossessivamente cliccava i cellulare
tra lampi di luce e suoni assordanti
piatti bicchieri ballerini aitanti
truccata da vamp assente al presente
passava su internet la sera.
ACQUARELLO
L’auto tra fughe di smeraldo,
a mezza primavera
t’abbraccia chiara la sera,
viene incontro tra i prati
d’una cascina addormentata
solo un’altalena tra il viola
che dal Monviso cola.
PRIMAVERA
Su un cielo teso come vele
lembi di nubi chiare
bianco rosa lilla rampano
su frutici un po’ sghembi
bucano l’erba fiori
fibrillano città d’insetti
sugli alberi stridori trilli
cori d’uccelli allegri.
Etere di luce.
Sono tentata a vivere.
INNAMORAMENTO
Eloquio di sguardi
calde viscerali
emozioni
pulsazioni all’apice
bandite le parole.
UNA MODERNA DISAVVENTURA
Tra poesia e prosa una storia vera
Un giorno d'estate provate cosa vuol dire
essere sequestrati in una piazzola
vicina ad un casello autostradale
più o meno nove ore con quaranta gradi al sole.
Inizia così, con un colpo secco in galleria, la nostra peripezia.
“Cos'è questo fracasso, ci han tirato un sasso?”
“Ma no il computer segna alla ruota sinistra posteriore un problema”
“Va piano amore, frena, che la gomma è scoppiata,
senti il cigolìo sul selciato, sostare ci conviene, fermati,
c'è una piazzola lì di lato.”
Ma l'auto nuova di zecca accessoriata in ciò fa cilecca
non c'è la ruota di scorta e il nostro intento è lettera morta.
Stridendo arriviamo infine al primo casello e lì inizia il bello.
Un carro attrezzi in parcheggio ci pare un miraggio:
“Forse saremo soccorsi” prendiamo coraggio.
“No, adesso non posso”
sentenzia l'omone dell'Aci, più o meno due metri di panza,
e ci stende
“dobbiamo essere presenti per un'eventuale emergenza,
ma se avete pazienza, dieci minuti e arriva il collega,
e non c'è più problema”
Arriva il collega, porta un'auto, la molla, e sparisce.
“E' mezzogiorno” l'omone chiarisce “anch'io devo andare,
e poi le officine sono in chiusura, se ne parla all'apertura.
Cosa fate quì al sole, perché non andate a mangiare,
c'è un posticino vicino sul mare”
“Ci può accompagnare, pagando s'intende?”
“Non posso, ma un'auto la posso chiamare:”
L'auto arriva, ci porta,
per quattro chilometri quaranta euro è la posta,
più ottanta per empire la pancia.
Alle due c'è nessuno
ma nell'attesa qualcuno si è dato da fare
un'auto ha i vetri divelti in mille frammenti,
meno male che la nostra è intatta, ci diciamo tra i denti.
Chiediamo notizie al casello, ma che ne san loro di quello!
Due e trenta: il figlio dell'omone, anche lui col panzone,
arriva tranquillo. E suo padre? E' in arrivo.
La sua cagna spelacchiata legata e strattonata ci abbaia,
ma da una carezza rinfrancata, infine ci dà una leccata.
La cagna e un muro scrostato saranno la nostra compagnìa
in quella lunga giornata.
Arriva l'omone finalmente, ma che crede la gente,
sia facile da trovare una gomma e poi questa, per la stessa
due giorni quì sono stati i precedenti clienti.
“Ma stasera devo rincasare, forse dovrei anche lavorare,
costi quel che costi, si dia da fare, trovi la boita che me la monta.”
Sic parla la mia metà, ma non riscuote pietà.
Finalmente la sfinge al telefono si accinge,
ma sembra che questa gomma speciale sia cosa impossibile da trovare.
“Fuori dall'ufficio!” poi urla spazientito, a noi in speranzosa attesa,
e non resta che tornare sul selciato a giocare con la cagna vilipesa.
Insomma, per farla breve, arriva un carro attrezzi,
scarica un'altra auto a pezzi, e riparte.
Per tutto il pomeriggio il tran-tran continua,
tra dieci minuti arriva, poi riparte,
tra dieci minuti vi porto, un altro arriva,
tra dieci minuti... e poi riparte e un altro arriva.
A questo punto mi gira la testa, lascio la mia metà a litigare
e da vigliacca mi rifugio in auto rinunciando a lottare.
Provo a leggicchiare, ma non potete immaginare cosa succede
nello slargo di un casello stradale.
Un uomo attempato è fermo su un Cayenne.
Da mezz'ora attende. Ogni tanto scende.
Si guarda intorno e fuma, furibondo.
Uno dopo l'altro i mozziconi fanno tappeto con altri escrementi.
Un Suv argento arriva finalmente,
una quarantenne procace scende, e s'infila veloce nel Cayenne.
Ripartono sgommando. Già hanno fatto pace.
Due uomini scendono dalle loro auto.
Guardando in giro, si scambiano furtivi uno striminzito vasetto di fiori.
Sarà amore? Non ne sento l'odore.
Difatti cosa fanno? Com'erano venuti se ne vanno.
Intanto ho trovato tra l'erba un muro sporco
su cui m'accoccolo, tra vespe e vetri rotti.
Non tornano gli amanti. Nè il mazzolato con l'auto scassata.
Cosa c'era nel vasetto? C'è la mafia in questo ghetto?
Mio marito infuriato sbotta: creperemo nel parcheggio.
In effetti è un incubo questo continuo dileggio.
Ma poteva andare peggio se succedeva di notte.
Immagino l'omone che ci appare nel chiarore lunare.
Digrigna lunghi denti da vampiro.
Per fortuna il sole dardeggia ancora,
anche se un albero da quella parte si colora di viola.
Ritornano i carri attrezzi, c'illudono e ripartono.
Col cavolo la pazienza: ormai siamo a pezzi
e scopriamo cosa vuole dire l'impotenza.
Ma un autista ci dà un po' di speranza:
“Se rinunciate alla gomma porto un'auto e al ritorno
ove volete vi sgommo”
Ma non è tutto il giorno che ci ripetono la stessa cosa?
Però non sempre le rose hanno le spine.
Miracolo: ritorna! Appare all'angolo e si ferma.
Centocinquanta chilometri, milleduecento euro
per riportarvi a casa, ci sentenzia.
Prima erano ottocento, pazienza, ci sarà la tangente al bos inclusa?
Accettiamo per sfinimento, senza un lamento, disillusi.
Si parte. Saluto la cagna che guata triste.
Infine siamo in pista. Non è male viaggiare
in un big cabinato, sovrastare.
La vista è eccezionale, un arcobaleno in valle traspare.
Dietro l'auto acciaccata fa una pennichella.
Seduta accanto allo sportello, mio marito in mezzo,
torno a respirare.
Guardo l'uomo alla guida parlare, non sembra male.
Ma finché non arriviamo, di essere liberi ancora non ci crediamo.
La misura è già colma, la chiamano sindrome di Stoccolma?
Ogni incrocio è un incubo, ora volta e chissà dove ci porta.
Ma laggiù finalmente è casa nostra.
Nuove poesie per i navigatori di Carta e Penna:
NOI CANTORI DI SERA…
Mi scrive l'amica poetessa
la tua storia ad altri non interessa
per dirla con Montale il personale
è solo spunto per poetare
l'occasione per diventare universale
e catturare il lettore
è non parlare dei perché e percome
tu non hai più il sole nel cuore
non narrare il tuo personale, insiste,
tanto più se grigio e dimesso, ma scusa
allora perché vuoi sapere i motivi
della mia tristezza e mi scrivi
anche il lettore rimane curioso
e allora cara ti contraddici
perché noi cantori di sera
spiamo oltre le finestre accese
o spulciamo storie tra le righe,
e amiamo il racconto del passante
in cui scopriamo sentimento,
o forse il mio interessamento
il guardarmi intorno curiosa
è un patologia rara, da curare,
ma senza essere morbosa
sposo le storie degli altri.
MONFERRATO
Le mie colline hanno dolci fattezze
morbide pezze di terra a vigne
pioppi degradanti sul torrente
prati e stagni ove andavamo
zingare fanciulle a litigare
con altrettanti monelli.
Le mie colline hanno fattorie
con piccole finestre
orlate di mattoni
aie calde di bambini
e nebbia chiara che dai prati sale
negli umidi mattini.
Le mie colline hanno cuore mente
memoria
rammentano i passi che per celia amore
lavoro o guerra le hanno calpestate
ricordano un uomo appeso
a tegole rosse tra spicchi di cielo
che salutava una vita.
LAGUNA
(intorno a Venezia)
Scampoli di felicità in strade d'acqua
tra briccole abitate da voli,
contrade d'isole tra barche sparse,
brume filtranti stelle di sole,
scivola il battello come sospeso,
si ferma e parte, si ferma e parte,
mollano e tesano le sartie,
scendono salgono gitanti in silenzio
complici del momento,
c'è pace in questo andare
non scendiamo decidiamo di restare.
ESTATE SULL'AIA
Sul muro giallo le rose rosse
sonnecchia Lilli vicino al fosso
la vecchia all'ombra sferruzza un pizzo
il pupo in culla riposa quieto
avvolge l'aia polvere d'oro
il silenzio.
VACANZA IN BARCA
Il vento corre
sulla nostra pelle
calda di sole.
Le tue dita
traccian sul mio corpo
vaghi ricami.
L'anello d'acqua
che ci circonda
è il nostro oblìo
su cui scivolano
sogni teneramente
avvolti di niente.
FINIRÀ L'ESTATE
Basta sole smagliante
emozioni violente
parole sopra tono
suoni gente
finirà l'estate
sarà ancora autunno
grigio il tempo, lento,
sola, sul tavolo
un niente di quaderno
di fronte vetri
velati di perla
e il silenzio
potrà infine intrecciare
sogni di sole.
POESIA
Poesia è carezza
è brezza di farfalla
posa lieve sul cuore
non deve far rumore
né urtare solo dare
vecchie nuove emozioni.
...ADORO
Adoro dell'estate all'albore
il gelsomino di rose l'odore
dolciastro impiastro che brezza
scompiglia nell'aia carezza
le molli sere di sogni
in attesa.
Nel 2009 ha pubblicato la raccolta di poesie BIANCO E NERO, Ed. Montedit.
Pubblichiamo la recensione del volume a cura di Giuseppe Dell'Anna:
Raccolta di versi dove l'autrice confida l'altalena delle immagini del suo quotidiano vivere, una medaglia dai due lati, due poli: uno chiaro ed uno scuro che l'autrice non ha remore di evidenziare a se stessa ed agli altri. Nella sua nota iniziale, l'autrice ha però quasi il timore che il nero possa sommergere il bianco, per cui ha desiderato disporre inizialmente la silloge "Armonie" quasi ad incarnare in esse l'ottimismo, lasciando più avanti quelle che lei definisce "malinconie". Ebbene, personalmente, ho letto il libro al contrario, iniziando cioè dal fondo per la semplice intuizione che la malinconia, la nostalgia, il non senso, sono alfine le parti più profonde di se stessi, cosicché:
Nella raccolta "Accidie", l'autrice si guarda, si osserva, piange di se stessa, esprimendo così l'unica e immensa forza del riconoscimento concreto di se medesima: "Oggi ho inteso la mia vita / come un quadro / appeso all'infinito".
In "Acquarelli", c'è il tocco dell'osservazione sulla natura intorno, una natura che parla, che "viene incontro tra i prati", che trasforma la sera in "atmosfera", in attimo felice da vivere.
In "Affabulando e non", c'è il senso dicotomico del narrare il pensiero e di potersi ammalare dello stesso pensiero narrante. Un desiderio di mollare gli ormeggi del cogito, dell'intelligere, e del sorriso forzato, per salpare assieme all'istinto verso il desiderio di vivere.
In "Assenze", le assenze dell'autrice sono quelle che l'anima si prende per farle divenire "presenze": presenze forti e struggenti del cammino della propria storia che parla di colline, che "hanno cuore mente memoria" di risa di fanciulli e di amari distacchi… pur veri e fieri in attesa di "un'altra sera"…
In "Asprezze", l'autrice, attraverso un volo tra i sogni e le sofferenze d'amore d'un tempo e le realtà dell'oggi riflesse in uno specchio, si interroga cercando una propria definizione: "Chi sono non so / ma sono", "solo così posso amarmi".
In "Ardori", la luna "spalma lusinghe d'argento (e) arde d'amore la notte", "bandite le parole" resta preminente "eloquio di sguardi".
In "Armonie", l'autrice dosa e pennella le presenze e le assenze: la presenza del cielo "oltre il blu del mare", del "sole smagliante", della "brezza" che "scompiglia nell'aia carezza / le molli sere di sogni / in attesa", la presenza di un fiero sguardo "oltre il muro bianco" su natura, figli e nipoti; l'assenza, invece, diviene "l'assoluto / silenzio", l'"ozio virtuoso" di una mente vista come tabula rasa dove "soltanto il nulla crea".
La poesia di Grazia Fassio, nella sua raccolta "Bianco e Nero", penetra la parola quasi a sillabarla nella sua essenza, nel suo significato, rendendola quindi vicina, comprensibile, fino a renderla… interiore!
|
Ed ecco alcune poesie tratte dal libro: |
|

|
Il libro è in vendita a Moncalieri, alla libreria MONDADORI, presso il Centro Commerciale in V. Vittime di Bologna n. 20-22 oppure può essere richiesto alla Casa Editrice Montedit editrice@montedit.it o dal sito www.montedit.it
|
LA FELICITA' DELLA MALINCONIA
Una nebbia opale sfuma
portici illuminati
di mistero.
Tristezza
malinconica felicità
accompagnano i miei passi.
Partecipi d'una grigia
raggiante intima
ebbrezza.
LA CAPPELLA
Nella cappella del collegio
mi prostravo sovente
nella via Crucis.
Era raccolta la chiesa,
buia, profumata di cera
incenso e fiori
entravo in essa e mi pareva
liberarmi da pesi oscuri
di cui non conoscevo
la ragione.
ALASSIO
(in casa)
Il mare entra
da destra in fronte
da sinistra
lo senti
con le finestre chiuse.
L'azzurro fa da padrone
colora la marmellata
e il burro a colazione
l'alluce sfacciato che ammicca sul pouf
e quei tuoi occhi verdi adesso blu.
Ma improvvisamente s'alza vento
di scirocco
e tutto diventa rosso
persino il mare e
quei tuoi occhi blu.
È SABATO DOMANI
Andiamo a letto
è sabato domani
ci alziamo se vogliamo
come il giorno frugherà
lenzuola stropicciate
mani gambe allacciate
occhi d'oro sognanti ancora
in pigiami stropicciati
faremo colazione poi
lasceremo fluire il tempo
finché il cielo verrà viola
tra innocue occupazioni
come guardarci negli occhi
ancora.
In pace assisteremo
al sommesso spegnersi
d'un giorno di festa.
SILENZIO!
Soave
assenza
rumore di silenzio
soltanto.
Parole
senza senso
lasciamole fuori
nella mischia.
Qui vige l'assoluto
Silenzio
OZIO VIRTUOSO
Non ozio padre del vizio
ma ozio come sfizio
appropriamento di tempo
pensieri vagan leggeri
soffi di luce improvvisi
squarci di genio nati
dall'oblìo assoluto
- ozio virtuoso -
mente lavata riceve.
Soltanto il nulla crea.
SONO QUI
Chi sono non so
ma SONO
sono qui
rughe sul viso
bianchi sorrisi tra i capelli
ma sono qui
come sono
dentro e fuori
nulla di più
nulla di meno.
SINTESI
Rime le mie forti
scarne parole
entrano
colpo di fucile
che ti apre il cuore.
SUICIDIO
In un pugno teneva
ancora pezzi di vita
altri persi aveva per via
con desideri speranze
ora era soltanto stanco
così pensava intanto
il grilletto premeva
l'altra mano sulla vita
chiusa.
ASSOLUTO
Era blu il mare
oltre il bianco muro
e bianca la vela
solitaria.
Era chiaro il cielo
oltre il blu del mare
immoto in un'alba
senza nubi.
Niente interrompeva lo sguardo
sdraiata
oltre il muro bianco.
GENNAIO IN SICILIA
Impudico il sole
il talamo accendeva
all'ora della siesta:
tendendo una mano
oltre il celeste potevamo
afferrare l'Africa.
E i sogni.
TARDO AUTUNNO
Odio il tardo autunno di novembre
il sole che cala presto dietro l'ombra
alberi insetti in letargo e fiori e erba
stanca - e fuori - dentro - è nero il gelo
chissà perché non è bianco questo gelo
e delle feste già s'allarga impazza
l'attesa
-di cosa poi- incubo camuffato
da luci regali abeti cotillon
già visto il film che non annulla
i vetri grigi per lo smog
su cui con dita stanche traccio impossibili sogni
d'eterna primavera.
ABORTO
Quel seme di bimbo
inatteso
accolto col pianto
del ventre ostile
il rifiuto ha inteso
e se n'è andato
silenziosamente.
L'ho messo in un bicchiere
minuscolo angelo
rosso di sangue.
TRAFITTO
Tornavamo
da una chiara allegra serata
all'angolo un giovane bianco
d'avorio le braccia levate
apparve fantasma improvviso
pareva pregare la luna.
Guardammo incantati ma un ago
quel teso pallore bucava.
Si spense la luna.
RISVEGLIO
Odore di notte sulla pelle.
Lo sai è profumo
l'odore di notte
sulla tua pelle
amore.
HAIKU
Baci di luna
titillano su pelle
scura di sole.
PAGANI
Altri Ognissanti.
S’indossavano i primi cappotti
della stagione,
nella nebbia rasente le fosse
si faceva il giro dei morti.
Le foto roride sbiadite, i marmi,
pregando piano
mamma ripassava
con la pezza tolta dalla borsetta.
Noi la seguivamo a ruota.
Un tempo.
Ora.
Adesso pensare soffrire è out
meglio andare per mare in boat
-carpe diem!-
a cercare l’ultimo sole.
E poi elfi camuffati in folli sere
della morte esorcizzare la paura
in un carnevale importato dal west.
DOVE PASSEGGIAVA CAMUS
Ad Algeri si camminava
per strade bianche
su scogliere nere
un ristorante c'era
il più bello d'Algeri
appeso al mare
con le aragoste in fila a lato
delle scale d'ingresso
che ancora muovevan le chele
le tovaglie strappate
le posate d'argento
i bicchieri spaiati
ma l'onda che fuggiva
l'afferravi con le mani
quasi.
|
L'autrice c'invita a leggere, inoltre, alcuni suoi racconti e poesie.
Un momento magico
(tre generazioni)
La finestra è occhio sulla sera
dune di panna celano stelle
tenta Marcello d’usare il cannocchiale
per vedere se ride la luna
chiede a papà Ale che è appena giunto
se lo porterà al telescopio di Pino
che fa grande la notte.
Roberto è salito sulla sedia
lo sostengo curioso il naso
appiccicato al vetro
arrotonda i gesti e le parole
e solenne alita un “oh” di meraviglia
all'abete davanti che la luna scontorna.
Apparso in braccio a papà Andrea, a caso
Edoardo intona accordi sulla pianola
con le sue manine di sei mesi solo.
Fuori di luna piena è sera.
Senza far parola
dei miei figli lo sguardo incrocio,
fermo.
Non costa consumare le scarpe
Cammina incessante la gente
cammina e guarda e curiosa,
non costa consumare le scarpe
tutt’al più il calzolaio risuola
e la strada è più interessante d’un film,
si consola il laureato precario
mille euro al mese senza orario,
e poi, che vuole, la ragazza ce l’ha
che gli stringe la mano affettuosa
ed oggi la montagna nel sole
si tocca, è a due passi,
la gente si diverte per via,
almeno così sembrerebbe:
all’angolo un giovane strimpella
un altro un ballo s’inventa
e scherza e allunga una mano implorante
e dice ridendo che tiene famiglia
due mogli e sei figli.
Ha forse vent’anni.
Marcellino
Mi piace la mia casa
di cose un po’ confusa
i fiori in ogni dove
e colori di fiori
sul cretonne,
gli uccelli i pettirossi fuori
in concerto,
e Fred e Jessy pastori tedeschi
che fanno sentinella allo scoiattolo sul ramo
o al gatto
o abbaiano alla luna.
Mi piace la mia casa,
le foto i libri a iosa,
i ricordi sul filo dell’erba,
il sole acerbo del mattino
in posa
sulle tazze del caffè,
il salotto fané,
noi due,
i figli in visita
anzi di casa e
Marcellino c’ogni cosa colora
d’allegria.
Con le tre poesie sopra riportate l'autrice ha ottenuto una segnalazione di merito alla quinta edizione del Concorso Letterario Internazionale Prader Willi - anno 2008
VIOLENZA A NATALE
2° Premio Concorso letterario Penna d'Autore 2003
Anni fa. Un Natale diverso. Indimenticabile.
Già al mattino preannuncia la sua inconsuetudine
con uno splendido sole in un cielo terso dal vento.
Insolito, per noi, anche il pranzo natalizio:
per una serie di circostanze solamente in quattro,
mio marito, i bambini ed io, in uno squallido ristorante ,
mentre abitualmente riuniamo a casa nostra la parentela
in un'allegra tavolata.
Poi il rientro a casa, nella nostra casa celata
dai pini e dalle betulle, infilare la chiave nella
toppa, e non trovare nessuno, solo l'albero di Natale,
che sembra avvizzito e senza significato nel buio
delle tapparelle abbassate.
Scorre lentamente una mezz'ora. Le quindici sono
appena passate. Mio marito legge e i piccoli sono
occupati a demolire una montagna di giocattoli.
Desidero vedere mia madre e salutarla, perché
staremo via una quindicina di giorni. La richiesta
di accompagnarmi sortisce una serie di rifiuti, poiché
sono tutti troppo occupati nei loro passatempi.
E così sono circa le quindici e trenta quando parto
da sola. Prendo l'auto, scendo la collina, e imbocco da
Moncalieri la grande strada che costeggia il Po.
Accelero, ma ragionevolmente. Arrivo al primo semaforo
e sto ammirando le montagne innevate che si ergono
alla mia sinistra nitide e scontornate di azzurro,
quando sento strombettare vicino a me. Il mio sguardo
incrocia quello chiaro d'un uomo bruno che non conosco
e che sembra voglia parlarmi. Penso "il solito
pappagallo" e decido d'ignorarlo.
Ora giro e ho le montagne di fronte, tanto vicino
che sembrano venirmi incontro.
Non penso più all'uomo bruno quando risento
insistente il suono del claxon.
Sono ferma al secondo semaforo e vedo con la coda
dell'occhio che si è affiancato alla mia macchina.
Ma m'impongo ancora di non guardarlo. E' troppo recente
il ricordo dell'inseguimento in auto di quattro
giovinastri, della pazza gincana a cui mi avevano
costretto per un buon quarto d'ora, tagliandomi la
strada e urlando volgarità, per cedere alle sue
insistenze.
Allora avevo fatto lo sbaglio di voltarmi.
"Non lo rifarò" m'impunto. Ma al tempo stesso penso
che sono presuntuosa e maleducata, che forse mi sta
soltanto indicando qualcosa. E allora controllo le
luci, le porte, mi volto a vedere se per caso il
bagagliaio è aperto. Mi sembra tutto a posto.
E' di nuovo verde e riparto. Ma lui è sempre
dietro e continua a strombettare.
Il terzo semaforo. Si è accostato alla mia
sinistra, vicinissimo, ed insiste a suonare. Mi volto.
E il cuore si ferma, poi sussulta e mi sembra di sentirlo
battere impazzito fino all'estremità delle dita. Gli
occhi devono essere sbarrati dal terrore. Mentre i suoi
splendono chiari, di ghiaccio, occhi da pazzo, e la
bocca è un sadico ghigno di scherno. In mano ha una
pistola nera, enorme, massiccia, forse una calibro 38,
la vedo bene perchè si è allungato sul sedile di destra
e me la punta alla tempia, attraverso il vetro,
minaccioso.
Ora con la stessa indica una stradina a destra
ordinandomi di voltare. Istintivamente invece accelero
e parto, anche se il semaforo è rosso, e mentre corro
da folle sento che lui c'è sempre e ho la sensazione
fisica ineluttabile di una pallottola che fra breve
mi trapasserà la nuca.E allora attraverso un altro semaforo
con il rosso, ma mi tallona, supero a destra, ma è lì, non
molla, lo intravedo nello specchietto retrovisore, e mi
pare sghignazzare crudele.
Non connetto, sembro impazzita, vedo già il mio
epitaffio, morta il giorno di Natale, e ringrazio il
Cielo di non avere con me i bambini. Penso anche a
come può sorprenderci la morte, senza preavviso.
E corro corro, non so come faccio a uscire incolume
dagli incroci passati col rosso, ed a non ammazzare
qualcuno. Forse mi gridano improperi, strombettano, ma
non sento niente, solo l'istinto di fuggire da quella
pistola.
E' ancora dietro. La mia auto è una piccola scheggia
e ha un'ottima ripresa, la sua è un vecchio e grosso
cartone, una sportiva nera fuori serie, eppure non molla.
Passa anche lui col rosso, supera a destra, guida a zig-
zag, e mi è sempre alle spalle. In un tratto diritto
riesco a dargli un po' di distanza, ma c'è un altro
semaforo e ci sono macchine ferme e non posso passare.
"Se mi fermo sono perduta" mi dico "Quello si
accosta e mi ammazza"
Mi butto allora sul marciapiede di destra, dove
ci sono le auto parcheggiate, e riesco a procedere a
malapena.
"Ha la macchina più grande, forse l'ho seminato"
penso.
Invece quando ho svoltato guardo nello specchietto
ed eccolo. Mi porto sulla carreggiata sinistra di
sorpasso e sulla destra ci sono delle auto e non potrebbe
passare, ma ormai sono rassegnata e ho i nervi a pezzi.
"Non ce la faccio, è la fine.Oggi è toccato a me"
Difatti invade la corsia opposta di marcia e mi
taglia la strada e sono costretta a fermarmi.
"Non c'è un cane che mi venga in aiuto" mi dico
"E' finita".
Scende. Non è molto alto, ha capelli bruni piuttosto
lunghi e il volto scuro. Ha una mano in tasca.
Penso solo:" Adesso mi spara".
Mostra invece un tesserino :"Sono della polizia".
Rinasco. Ma ancora scioccata, gli occhi annebbiati,
non lo guardo nemmeno, e lui lo ritira svelto, dicendomi
brusco: "Favorisca i documenti".
Allora ritorno in me, reagisco.
"Ma le sembra il modo, minacciarmi con una pistola..
. Si può sapere che cosa ho fatto?"
"Eccesso di velocità".
"Se ho corso come una pazza è perché lei mi ha
minacciato. Se faceva vedere il tesserino, come ha
fatto adesso, mi sarei fermata."
"Correva anche prima."
"Sulla radiale corrono tutti, ma lei se l'è presa
con me. Ma ci pensa che avrei potuto ammazzarmi o
ammazzare qualcuno? E poi la sua auto non è della polizia,
poteva essere un delinquente."
Tra di me "E se ha la faccia del delinquente!"
"E' un'auto civetta. Siamo in giro per controllare
le persone sospette."
"E sarei io la persona sospetta? Una donna
dall'aspetto normale, tranquillo, che esce di casa
a Natale in pieno giorno..."
"Tutto a posto, può andare" dice, dopo aver
divagato sui documenti, sul nome, su dov'ero
nata, come se nulla fosse successo.
Resto un po' di tempo annichilita immobile,
e non penso nemmeno a segnare il numero di targa per
potere in seguito indagare. Del resto il disgraziato
è filato via come un razzo e prima la macchina era
di traverso e non avrei potuto leggere il numero di
targa se non scendendo dall'auto.
Ora penso soltanto che mi è andata bene, ma fino
a quando non arrivo da mia madre guardo sempre nello
specchietto col terrore di vederlo riapparire.
Devo essere uno straccio, perché la mamma mi domanda
subito: "Cosa è successo?"
La casa è piena di gente, ci sono parenti, amici.
Mi sporgono un cordiale, poi un caffè, tremo ancora.
Mi distendo un attimo sul divano. E devo raccontare.
Per tutti non è stato un poliziotto. I poliziotti in
servizio viaggiano sempre in due. E poi fermano con
una paletta, non con la pistola. Mia madre teme che
vogliano rapirmi. Siamo benestanti. Io non ci credo.
Se no l'avrebbe fatto. Come non penso fosse un rapinatore.
Ero un albero di Natale di gioielli, e non ha preso
niente.
Per me era semplicemente un uomo solo (poliziotto
fuori servizio, pazzo o uomo qualunque, in ogni caso
parto abnorme del consumismo natalizio) in possesso di
una pistola, che il giorno di Natale, vedendo una
persona sola come lui, aveva pensato di divertirsi un
po', spinto dall'acredine che può avere contro il
mondo chi è infelice e senza nessuno accanto, proprio
quando tutto intorno è festa.
Se è come immagino, che scopo si fosse prefisso
non lo so. Ci sono tanti modi di rivalersi per i
frustrati, i delinquenti e gli infelici.
Può essere violentare una donna, oppure sentirsi
importante nel dominarla vedendo il terrore nei suoi
occhi. Forse il sadico si era divertito in quella
mezz'ora, e vendicato per la sua solitudine.
Io per niente. L'ho rivisto spesso nei miei incubi,
e rideva puntandomi la canna al viso.
E, ancora adesso, quando mi fermo al semaforo,
guardo fisso davanti a me, nel terrore di voltarmi
ed incontrare quegli occhi e quella pistola. Può
essere Gesù Cristo, non mi volto.
E un'infinità di volte mi sono data della cretina
per non avere perlomeno letto il tesserino che mi aveva
mostrato, o aver scritto il numero di targa.
Certo, è stato un Natale indimenticabile.
INCINTA A QUARANT'ANNI
Luciana guardò lo specchietto del test che rifletteva
il cerchio scuro. Era incinta! La constatazione le
provocò un senso di disgusto, di nausea. Quella macchia
cremisi le pareva qualcosa di mostruoso, di abnorme.
Comprendeva che i suoi sentimenti erano riprovevoli,
ma non poteva evitare di provarli.
L'anello sanguigno danzava ineluttabile davanti ai
suoi occhi attoniti. E, dal primo istante che lo vide,
non desiderò altro che quell'abbozzo di bimbo se ne
andasse, da solo, così come si era presentato senza essere
desiderato. Oppure di potersi risvegliare e scoprire
ch'era stato soltanto un sogno.
Eppure le altre due volte ch'era rimasta incinta,
tanti anni prima, era stata felice all'annuncio: era
la realizzazione di ciò che desiderava. Ora aveva
quarant'anni, i figli erano cresciuti, aveva visto
tante sofferenze di bimbi, e l'allegra incoscienza
che l'aveva accompagnata in passato era svanita, c'era
solamente una grande paura. In più pensava egoisticamente
alla raggiunta tranquillità, al tempo prezioso che
finalmente poteva riservare a sé stessa, che avrebbe
perso, e, perché no, al fisico che, non possedendo
l'elasticità della giovinezza, si sarebbe sfasciato, e
a suo marito che si sarebbe magari consolato con
un'amante.
Pensieri che non le facevano onore, ma erano però
così sentiti da non potere essere cancellati.
Si arrovellò per vari giorni nell'inquietudine,
senza parlarne con il marito, ch'era in città, mentre
lei era al mare con i ragazzi. Anche quando si sentirono
al telefono non glielo disse, era in collera con lui,
dodici anni di pillole, pochi mesi che aveva sospeso
di prenderle e già era incinta. Non era servito a nulla
caricarsi di ormoni, anche a scapito della salute, e poi
fare l'amore senza sovente provare amore, gelata dal
timore di rimanere gravida.
Intanto si era quasi abituata al pensiero di aspettare
un bambino, ma senza coinvolgimento affettivo, la sua
mente elaborava più che altro piani di ordine pratico,
per potere sistemare la stanza del piccolo in arrivo senza
dovere traslocare, oppure per allevarlo senza troppo
scapito dell'appena riacquistata libertà.
Aveva votato per l'aborto, tanti anni prima, ma ora
scopriva di non avere il coraggio d'interrompere la
gravidanza. Ora che aveva seguito i suoi figli passo dopo
passo, fino al raggiungimento della loro attuale splendida
fanciullezza, ora che aveva conosciuto le commoventi
sfaccettature della loro personalità in trasformazione,
non se la sentiva d'uccidere un embrione che poteva
diventare una meravigliosa creatura, magari simile a loro.
E poi anche Mario non l'avrebbe voluto, era stato
sempre contrario all'aborto.
Mario si era accorto che qualcosa non andava quella
sera di venerdì che aveva raggiunto la famiglia al mare.
Luciana era taciturna e di cattivo umore.
La sera, a letto, gli si rifiutò.
"Si può sapere che cosa hai?" le domandò spazientito
"Le vacanze ti fanno male?"
"Ho... che sono incinta!"
"Incinta?"
"Ti stupisci? Non ti ricordi di quella volta che non
volevo e tu hai detto: tanto devono arrivarti le
mestruazioni? E' passato un mese e non sono arrivate."
"Non è detto per questo che tu sia incinta. Sarà
un normale ritardo."
"Ho fatto il test. E' risultato positivo."
Lui accese la luce e si sedette sul letto.
"Che cosa intendi fare?" le chiese.
"Lo metto al mondo, che cos'altro posso fare? Ma non
lo volevo, lo sai benissimo. Non so se riuscirò ad amarlo.
Preparati ad occupartene. E poi ho quasi quarant'anni.
Sono vecchia per avere un figlio."
Lui tacque per qualche istante, poi disse: "C'è una
sola cosa da fare. Abortire."
Luciana scattò a sedere sul letto. Era sbalordita.
"Ho capito bene? Abortire!? Ma non sei tu che hai
votato contro l'aborto? Che hai sostenuto le tue convinzioni
in un'infinità di discussioni? O sbaglio?"
"E non sei tu quella che era favorevole all'aborto?
Come mai hai cambiato idea?"
"Avevo votato per quelle in condizioni disperate,
ragazzine sole, o donne che sono state madri più volte
e non hanno i mezzi per mantenere un altro figlio. Non è
il caso nostro. A noi non manca nulla. E poi ero giovane
allora... Nel frattempo ho compreso molte cose."
Lui la fissò: "Senti , Luciana, se può aiutarti mi
assumo la responsabilità della scelta. Non avrai rimorsi,
potrai scaricare la colpa su di me. Ma devi abortire.
Non è bene, ma è ancora il male minore. Non mi sento di
ricominciare da capo. Alla mia età."
"Non ti sembra di essere un ipocrita? Hai sempre
dilaniato le abortiste. Cosa c'è di diverso, ora? Solo
il nostro egoismo e la nostra convenienza."
"C'è anche l'età. Tu non te la senti di diventare
madre, ma neanch'io di diventare padre. Solo qualche
anno fa, l'avrei accettato. Ma adesso no. Non voglio
arrivare a sessant'anni con un figlio adolescente.
Sempre se ci arriverò..."
Luciana era sorpresa dalla reazione del marito:
conoscendo il suo pensiero non aveva neanche preso in
considerazione d'interrompere la gravidanza. Ora si
era quasi abituata all'idea d'un figlio in arrivo, e lui
non lo voleva. Era inoltre delusa che usasse un metro
differente, ora che gli conveniva, e ciò diminuiva la
stima che aveva per lui.
Spense la luce. Si coricarono. Pianse piano nel buio.
"Non so se avrò il coraggio di abortire" disse in un
sussurro.
Il lunedì mattina ritornò in città.
Il suo ginecologo la ricevette quel giorno stesso,
ma soltanto per la sua caparbia insistenza.
Ora era seduta di fronte al medico, imbarazzata,
a spiegare ch'era incinta e che il test di gravidanza
che aveva eseguito da sola era risultato positivo.
Lui domandò la data delle ultime mestruazioni.
Poi, quasi le avesse letto nel pensiero, chiese
bruscamente: "Vuole tenerlo?"
"Non lo so. Mio marito non lo vuole."
"Ma lei?"
"Non lo so. Ho paura. In ambedue i casi."
"Capisco." si aggiustò gli occhiali e la guardò
severamente "Sappia comunque che, se decide per l'aborto,
deve farlo presto. La legge lo consente solamente entro
novanta giorni dall'ultima mestruazione. In questo caso
dovrà rivolgersi ad un consultorio, che le prescriverà
tutti gli esami. Se, invece, lo vuole tenere, si ricordi
che, considerata la sua età, conviene che a settembre si
faccia ricoverare in ospedale per gli esami sul feto.
L'incidenza della sindrome di Down sale se la madre ha
superato i trentacinque."
Non osò chiedere altro. Il dottore era gelido
e distaccato più del solito, anche se erano tanti anni
che la visitava facendosi pagare profumatamente, e già
si era alzato per accomiatarla.
"Non mi visita?"domandò soltanto, intimidita.
"Non è il caso. Prima decida che cosa vuol fare."
Tornando a casa in auto era accecata dalle lacrime e
poco mancò che travolgesse un ciclista. Aveva sperato
chissà cosa da quella visita, una parola buona, un
consiglio, un aiuto a prendere una decisione, in un senso
o nell'altro.
Invece era sola, con il suo dilemma.
Mario la trovò che singhiozzava di traverso sul letto.
Si vergognava di se stessa, ma piangeva. Pensava che
c'erano tante persone che avevano problemi più grandi
del suo, ma piangeva ugualmente.
Si sedette vicino a lei e la scosse. " Ma che cosa c'è?
Perché piangi? Se è per il bambino te l'ho detto il mio
pensiero. Quando sarà fatto non ci penserai più. Ma se
desideri tenerlo sono anche d'accordo. Fa come vuoi."
Lei singhiozzò più forte:"Non voglio abortire. Ma non
voglio neanche il bambino. Voglio morire..."
"Ma scherzi?! Ma pensi a che cosa stai dicendo?
Stai esagerando, Luciana. Stai facendo il problema più
grande di quello che è. Se la legge lo permette, non
vedo che cosa ci sia di male ad interrompere la
gravidanza."
"Ipocrita antiabortista"
"Io ero contrario per quelle ragazzine puttane che
aprono le gambe a sedici anni. Per frenare il libertinaggio dilagante..."
"Girala come vuoi. Hai sempre ragione tu..."
"Dai, finiscila. Domani vai al consultorio. Siamo
al 15 luglio. Tra venti giorni dovremo partire. Il
viaggio in Turchia è già stato pagato."
"Tra poco sarò una vecchia con la pancia. Mi
vergognerò da morire."
"Una vecchia tu? Non sei mai stata così bella.
Sarai la panciona più graziosa del mondo."
"Se ne andasse da solo. Perché non te ne vai
bambino? Non ti ho chiamato, non ti voglio..."
Il consultorio era in una vecchia casa situata
in una stradina del centro storico.
La signora che riceveva aveva circa quarant'anni,
gioviale all'apparenza, ma in fondo agli occhi una
luce maliziosa da tenutaria di casa di malaffare (o
era soltanto una sua impressione?)
Luciana parlò svelta, arrossendo: "Vorrei abortire"
Ma aveva appena pronunciato faticosamente quelle
parole che già se n'era pentita, e avrebbe voluto
fuggire.
"Perché sono vecchia, se no lo terrei..." aggiunse,
quasi a giustificarsi.
"Vecchia lei! Non lo dica, siamo ancora giovani,
signora mia" disse quella ridendo, e poi soggiunse
"Si accomodi"
Luciana sedette su di una sedia allineata con le altre
al muro. Prima di lei c'erano quattro donne. Una di queste,
molto giovane, era accompagnata dal suo ragazzo.
Non doveva essere la prima volta che si servivano del
consultorio, perché ognuna aveva in mano una voluminosa
cartella di cartoncino, con il proprio nome sopra. E tutte
erano venute con il medesimo problema, appurò Luciana da
frammenti di conversazione. Una era una cameriera emaciata
che aveva abortito più volte perché il suo uomo non la
voleva sposare. L'altra, quella con il ragazzo, aveva circa
diciott'anni e non sembrava preoccuparsi molto, ridevano
e tubavano in continuazione. Poi c'era un donnone di età
indefinita che aveva già avuto cinque figli. E una giovane
pallida e silenziosa che fissava un punto imprecisato del
muro, con l'infelicità dipinta sul volto.
Anche Luciana era disperata e confusa ma, per non
fuggire, si diceva che la visita era più che altro necessaria per la prescrizione degli esami, che sarebbero comunque
serviti.
Finalmente venne il suo turno.
Il ginecologo era una donna giovane, dal volto dolce.
Scrisse i dati anagrafici di Luciana in cima ad un foglio
prestampato formato protocollo. Poi le chiese dei precedenti parti, dei figli, del marito, di lei, e riportò le
risposte sul medesimo. Barrò la casella "no" dove c'era
scritto "aborti precedenti" e "per contraccezione
fallita" sotto la domanda "perché richiedi l'interruzione
di gravidanza?".
Luciana sentì che con quella donna poteva parlare.
"Non so se abortirò" disse.
La dottoressa sorrise.
"Nessuna la obbliga ad abortire, se non se la sente.
Anzi, firmerà un foglio in cui s'impegnerà a pensarci una
settimana, prima di decidere. Ha tutto il tempo di meditar-
ci."
"E se lo terrò, a quali rischi mi esporrò, alla mia
età? E il bambino?"
"In linea di massima non ci sono grossi rischi. Non le
nascondo però una maggiore percentuale di pericolo al
momento del parto, per l'inferiore elasticità del corpo
rispetto ad una giovane. Poi, dopo il terzo mese di gravi-
danza, le consiglierei il ricovero in ospedale per l'esame
delle cellule fetali perché, oltre i trentacinque anni,
aumenta il rischio di nascita d'un bimbo mongoloide.
Questa analisi si chiama amniocentesi."
"E' un esame pericoloso?"
"No, non lo è, in generale. Ma potrebbe anche succede-
re una interruzione della gravidanza."
"Ma l'ago che viene introdotto nel sacco amniotico non
può danneggiare comunque il bimbo?"
Sorrise. "A parte che l'operazione viene controllata
attraverso un monitor, il feto si sposta istintivamente
quando l'ago viene immesso. E' bello vedere come il
bambino abbia già una sensibilità e reagisca,difendendosi."
Luciana fu intenerita dall'immagine del microscopico
essere che già sapeva contrastare il pericolo, quasi come
una creatura pensante.
La visita confermò un utero appena ingrossato, apparentemente gravido da non più di un mese.
La dottoressa prescrisse gli esami: il test di
gravidanza, l'elettrocardiogramma e gli esami del sangue.
"Ci pensi con serenità. Se desidera parlarmi sono di
nuovo qui venerdì, alla medesima ora. Se decide per
l'aborto le conviene andare al più presto con questo
foglio in ospedale per prenotare l'intervento. Possono
farla attendere anche dieci giorni."
Luciana s'accomiatò confortata dalla sua gentilezza.
Com'era tutto difficile però, a quarant'anni! Che bello
era stato attendere i propri figli quando aveva vent'anni
e non si poneva problemi! Ora c'era comunque la paura,
la paura di abortire, la paura di tenerlo, quel bimbo,
e poi l'analisi a settembre e poteva andarsene anche se
era sano oppure restare e non essere normale, e dover
allora prendere la decisione d'interrompere la gravidanza
dopo il terzo mese, ch'era quasi un omicidio.
"Perché non te ne vai, bambino? Non avrò mai il
coraggio di ucciderti..." pregò, dentro di sé.
Quando, dopo aver aspettato un'ora all'ospedale,
stampigliarono sui fogli di tornare per gli esami il
cinque di agosto, Luciana decise di rivolgersi ad un
istituto privato, anche pagando.
Al centro diagnostico dove si rivolse, prima che
pronunciasse verbo, le precisarono che, se voleva
le analisi gratuite, occorreva il timbro dell'Inail
che autorizzava, considerata l'urgenza, ad eseguirle
presso un laboratorio privato. Lei disse che avrebbe
pagato personalmente ed allora la fecero passare subito.
Quando tornò a casa era esausta e sempre più demoralizzata. Quante attese, quanti corridoi, quante parole,
quanta fatica, per che cosa? Ma perché si agitava quando
sapeva che non avrebbe avuto il coraggio di andare fino
in fondo? Perché teneva ipocritamente due porte aperte?
Forse per non arrendersi ancora alla vita che nonostante
tutto continuava a crescere dentro di lei? E perché la
rifiutava in modo così viscerale, tanto da sentirsi
scombussolata e dolorante, come se una terribile lotta
stesse avvenendo all'interno di sé?
Andò in bagno, e fu allora che scoperse una macchia
scura sullo slip.
"Mi sono venute le mestruazioni!" fu il primo pensiero,
esclamato ad alta voce.
Mario sentì, e disse: "Hai visto? Lo immaginavo.
Quelle analisi che hai fatto da te non contano niente.
Ci siamo preoccupati per nulla."
"Ma la visita al consultorio..."
"Vedrai: domani, quando ritirerai l'esito del test,
scoprirai che è negativo."
Quella notte sognò il bambino. Era piccolissimo
(arrivava all'estremità superiore del tacco della sua
scarpa!) come un lillipuziano di Gulliver.
Camminava svelto, voltandole le spalle, e portava
un sacchettino che pendeva rigonfio dietro la schiena.
Si chinò fino in terra per parlargli: "Dove vai
piccolo?"
Lui voltò il viso triste e minuscolo come un acino,
ma parlò come un adulto: "Torno dove mi trovavo prima
che mi chiamaste, per errore. Perché l'avete fatto?
Stavo bene dov'ero, una luce calda mi circondava. Invece
dentro di te ho tanto freddo... Non voglio venire al
mondo senza amore, mamma..."
"Ma no, non è vero che non ti vogliamo, torna
indietro..." urlò, e tese la mano, che si rinchiuse su
di un nulla. Il piccolo era sparito.
Si svegliò con gli occhi gonfi di pianto.
Il test che ritirò l'indomani confermò ch'era incinta.
Ma le macchie scure, color marrone, erano continue
e sempre più abbondanti.
Telefonò al suo ginecologo perché le fissasse un
appuntamento.
La signorina disse che non era possibile, era l'ultimo
giorno che visitava prima di partire per le ferie ed era
troppo impegnato. Finalmente, alle sue insistenze, la
fece parlare con lui.
Luciana spiegò che cosa le stava succedendo.
"E' una minaccia d'aborto" disse lui" Ha deciso se
vuole tenerlo?"
"Non abortirò, ma se se ne va..."
"E allora cosa mi ha telefonato a fare?"
"Per una visita..."
"La visiterò se sarà decisa a tenerlo. E, in questo
caso, dovrà dimenticare ferie e tutto, e stare a letto..."
"Ma non mi riceve? Non può fare una diagnosi per
telefono. E se mi verrà un'emorragia, a chi mi rivolgerò?"
"Non è mai morta nessuna per un aborto" dichiarò
brusco, e le prescrisse delle pastiglie.
Luciana staccò il telefono e giurò a sé stessa che
avrebbe cambiato medico.
Pensò allora alla dottoressa del consultorio, a quella
donna dolce che le aveva parlato con comprensione, senza
giudicarla. Le aveva detto di ripassare venerdì, se avesse
avuto bisogno, ed era venerdì.
Arrivò al consultorio che stavano chiudendo. La donna
dallo sguardo torbido le disse che doveva ripassare martedì.
Luciana la pregò. Era urgente. La dottoressa sentì la
discussione e la fece entrare. Dopo averla ascoltata, la
visitò. La mano guantata che estrasse dal suo ventre era
rossa di sangue.
"E' un aborto in atto. Risolverà tutti i suoi problemi"
dichiarò.
"Devo fare qualcosa?"
"Nulla. In genere, quando succede, è per un difetto
o una debolezza del feto, oppure perché è in posizione
sbagliata. Specialmente nel suo caso, che non ha avuto
difficoltà durante le precedenti gravidanze. Lasci fare
alla natura."
Era un'immorale? Perché si sentiva sollevata, quasi
contenta,quando uscì dal consultorio.
Al sabato sera ebbe le contrazioni ed espulse con il sangue una pallina gelatinosa:l'embrione? Poi,
all'alba del lunedì, il suo ventre vomitò un sacchetto
floscio color carminio. Pensò che fosse la membrana che
che aveva contenuto il feto.
Mise tutto nel congelatore del frigo, in una
bustina di nylon.
Lo stesso pomeriggio trovò un ginecologo che la visitò,
prescrivendo il ricovero immediato per revisione della
cavità uterina a seguito di "metrorragia da aborto
spontaneo incompleto". L'abbozzo di bimbo e il suo
involucro finirono in un bicchiere sotto spirito, con
i complimenti perché non li aveva gettati.
Quella sera Luciana andò all'ospedale con il suo
bicchiere ma poi scappò mentre chiamavano il medico di
turno, dopo aver preparato il foglio di ricovero.
L'odore dell'ospedale l'aveva sempre terrorizzata.
Ritornò il mattino dopo. Erano le sette e stavano
appena aprendo l'accettazione.
Si era fatta conoscere.
"Attenda qui, mi raccomando senza fuggire, però!"
le raccomandò ironicamente un'infermiera.
Luciana aspettò pensando che non avrebbe più desiderato
di fare l'amore. Per un momento di abbandono, le succedeva
tutto ciò. Per la prima volta in vita sua l'avrebbero
anestetizzata, portata in camera operatoria e lavorato sul
suo corpo mentre era incosciente, come morta. O sarebbe
morta? Aveva paura, ma desiderava anche che tutto finisse,
che fosse già un altro giorno.
Alle otto arrivarono molte donne, che riempirono ben
presto la sala di attesa. Luciana ne contò trentasei.
Erano coloro che avevano scelto di abortire.
"Avrei potuto essere una di loro" si disse Luciana.
No, adesso che aveva visto lo squallore delle poverette
in fila, in attesa di una mano che le scavasse per
sradicare il frutto della loro stessa vita, pensò che,
se anche fosse arrivata a quel punto, non avrebbe resistito
e sarebbe fuggita. Ma se lo diceva per fugare il rimorso?
Non aveva abortito col pensiero?
E poi molte erano state costrette dalle circostanze,
e nessuna aveva l'allegria dipinta sul volto.
"Tutte sgualdrine" sentenziò l'ostetrica che finalmente
la visitò "alcune sono la seconda volta che ritornano in
un anno. Ringrazio il cielo di non dovermi occupare di
loro. Mi rifiuterei."
Era stata fatta accomodare nella stanza a destra della
sala di attesa, mentre le "altre" entravano nello studio
a sinistra.
"Ho avuto il mio ultimo figlio a quarantacinque anni,
e non ho pensato neanche per un istante di abortire"
continuò "e prima di lavorare in ospedale ho fatto nascere
tanti bambini in casa. Ma non mi sono mai prestata ad
ucciderne, anche se diverse volte mi hanno offerto un
sacco di soldi per farlo. Ha visto quante sono? Mai vista
una ressa così. Devono andare in ferie, hanno tutte fretta!"
Luciana taceva. Poteva parlare? Era veramente certa che
non sarebbe stata una di loro, se fosse andata diversamente?
Povere donne, siamo sempre noi a pagare, sulla nostra
pelle, si disse.
Terminata la visita, e dopo essere stata interrogata
per l'ennesima volta, fu mandata al primo piano.
La capo infermiera era nevrastenica, sbraitava con
tutti. Investì Luciana: "E lei che ci fa qui?"
"Ho il foglio di ricovero. Devo essere operata
stamattina"
"Tutte a me le mandano, e io dove le metto? Letti non
ce ne sono, vuole una barella, o ce la fa a stare seduta?"
"Starò seduta. Grazie."
Rimase quattro ore su una rigida panchina, con una
ragazza che attendeva anche lei d'entrare in camera
operatoria. Era giovane, poco più di vent'anni, e i
riccioli biondi-ramati le accendevano il volto pallido
e grazioso.
Quando l'avevano visitata, Luciana aveva sentito i
commenti dei due medici usciti mentre lei si rivestiva:
"Sono dei cani, in quell'ospedale. L'hanno massacrata."
Non era sposata. Aveva abortito volontariamente in
un ospedale della cintura una settimana prima. I suoi
genitori non sapevano nulla, l'avrebbero uccisa.
La sera dell'intervento aveva lavato i piatti e riordinato
la cucina perché non si accorgessero di niente, e il
mattino successivo si era recata regolarmente alla
scuola materna dove insegnava. Ma era stata molto male.
Poi aveva iniziato a perdere frammenti di pelle misti
a sangue. Si era decisa allora a venire in quell'ospedale.
In mattinata dovevano intervenire anche sul suo utero.
"Se ne uscirò, giuro che non mi succederà più. Non
so se riuscirò mai a dimenticare..." disse a Luciana, le
lacrime agli occhi.
Finalmente era pronta per l'operazione, i piedi legati
come un pollo. La luce forte e bianca l'accecava.
Aveva atteso ancora sulla barella nel corridoio asettico
su cui si affacciavano le camere operatorie. Aveva visto il
sangue sulle tuniche dei chirurghi e degli assistenti e una
donna a cui era stato asportato un seno che ancora dormiva.
Riuscì a dire: "Perché mi legate anche le mani?" mentre
gliele chiudevano nel camice bianco che le avevano fatto
indossare.
Poi l'anestesia fece il suo effetto, e si addormentò di
colpo senza accorgersene.
Si risvegliò ch'era di nuovo nel corridoio.
Un medico le accarezzò lievemente il volto e chiese:
"Tutto bene?"
"Sì, tutto bene..." sussurrò automaticamente, ancora
semi-incosciente "...va tutto bene."
Un brivido la percorse. Forse perché il tempo era
cambiato. Si sentiva la pioggia tamburellare sull'opacità
dei vetri lattei.
RITORNO AL PASSATO
La mamma di Lilli è morta improvvisamente, un giorno
bianco appena aurato da un sole smorto. Il babbo se n'era
andato da tempo, ancora giovane, in una notte blu bucata
da luccicori di stelle.
Ora è orfana, Lilli. E non sa come ma, proprio mentre
piange, ripensa al suo amore da ragazzina. A quando lui
veniva in casa, discorreva con i suoi genitori, e poi
correvano ad abbracciarsi nei prati. Baci risa giochi e
la vita pareva schiudersi come un fiore su di un futuro
traboccante meraviglie.
E' una presenza prepotente. Per la prima volta, da
quando si è sposata, ha nostalgia di quell'amore lontano.
Bisogno di essere consolata accarezzata da lui. Di pian-
gere sulla sua spalla, parlando di passato, del tempo in
cui la casa in collina era piena di voci e lei un'adole-
scente scatenata. E' il solo legame con un periodo che
ora sembra l'unico felice. La radice superstite che
impedisce il crollo dell'albero delle dolci memorie.
Il paese di lui ha poche anime. Trova subito il nome
sulla guida telefonica, ha solo cambiato indirizzo.
Le mani tremano esitano mentre compone il numero.
Riconoscerà la sua voce? Sono passati quasi vent'anni.
La voce è di donna. Lei tace e quella si spazientisce.
"Ma chi è? Chi è?"
Lilli riattacca.
Il giorno successivo osa parlare.
"C'è il dottore?" domanda.
"Mio marito non c'è. Ci sarà stasera. Chi lo desidera?"
Di nuovo il silenzio.
Riprova parecchie volte nei lunghi giorni tediosi e
tristi, in cui sembra che solo il sentirlo vederlo possa
riportarla alla vita, ridarle il passato. Sempre di
giorno, pur sapendo che difficilmente lo troverà. O forse
proprio per ciò, vuole sentirlo ma ha timore di sentirlo.
La moglie ora s'infuria sui suoi silenzi, forse è
anche impaurita.
Poi, una sera che suo marito è uscito, si ritrova a
telefonare. Il numero ormai lo sa a memoria. E risponde
lui. La stessa voce leggermente strafottente che aveva
da ragazzino. Solo un po' più roca.
Lilli torna indietro di vent'anni. Lui chinato che
la bacia, il nero ciuffo ribelle adombra appena gli
occhi accesi d'amore.
Non trova la voce per rispondere. Egli si spazientisce.
La moglie gli avrà riferito delle telefonate.
"Chi sei? Vuoi parlare? Hai finito di rompere?"
Lilli riattacca.
E' ormai una fissazione. Vuole rivederlo. S'illude di
poter tornare adolescente? E con l'adolescenza di
riacquistare i genitori,e la spensieratezza di quegli anni?
Non osa più chiamare a casa. Ora telefona alla sua
azienda agricola. E finalmente parla.
"Sono Lilli."
I loro paesi distano una quarantina di chilometri.
L'appuntamento è a metà strada, in un bar racchiuso in
una manciata di case smarrite tra i campi.
Lilli, emozionatissima, arriva in anticipo di un buon
quarto d'ora. Gli unici avventori quattro uomini che hanno
smesso di giocare a carte per spogliarla con occhi lubrici
e curiosi.
E' arrivato. Il sogno è diventato realtà. Ma non ha
più nulla del sogno.
"Anch'io sono cambiata così?" pensa Lilli.
Radi capelli sostituiscono il ciuffo ebano dei ricordi,
i chili di troppo involgariscono i lineamenti marcati del
volto, che lo rendevano affascinante in gioventù.
Convenevoli, parole imbarazzate e senza senso per
nascondere la delusione.
Lilli racconta dei genitori. Lui dice soltanto: mi
dispiace. Erano davvero eccezionali.
Poi parlano dei rispettivi consorti. Dei figli.
Intanto ha iniziato a piovere da un cielo improvvisamente corruscato. Ha voglia di fuggire. Non c'è magia.
Niente può più unirli. Neanche i ricordi.
"Ho distrutto anche i ricordi" pensa Lilli.
Deve arrendersi alla realtà. Quel lontano passato
non può ripetersi. Anche se fosse tornata miracolosamente
giovane, intorno le stesse persone ed il medesimo ambiente,
non sarebbe più stata la stessa. Per esserlo avrebbe
dovuto annullare le esperienze vissute nel frattempo,
esperienze che l'hanno profondamente cambiata. Avrebbe
dovuto riacquistare l'innocenza.
Il passato, come un bel quadro, va tenuto nella sua
cornice: ogni tanto guardarvi con tenerezza ed attingervi
per addolcire il cuore. Parlarne, anche. Perché è parte
dell'esistenza. E' ricchezza, scuola di vita.
Ma non permettere che sia solo sterile inutile
rimpianto, fino a distruggere il presente.
Ora Lilli ha voglia di una cosa sola.
Di ritornare. Di riabbracciare il suo presente.
LA FUGA
Racconto classificatosi al secondo posto del premio PENNA D'AUTORE D'ORO - Sezione racconti brevi - anno 1998
Mare calmo. Immobile. Un lago.
Gabbiani vi dondolano, lo accarezzano, poi cercano il cielo.
Un cane tenta di seguirli ed abbaia nell'aria.
Due innamorati si guardano. I loro occhi hanno il colore del mare. Cilestrino. Blandito a tratti da brume d'afa argentee e leggere come un velo da sposa.
Il molo sembra un ponte sull'infinito. Luisella, alla punta estrema, pare protendersi per afferrarlo (l'infinito).
È appena fuggita dalla città, e respira il silenzio. Immobile.
Anche il pescatore è immobile. La lenza immobile. Un cesto vuoto ai piedi. Immobile.
Ogni tanto si concede un movimento per ributtare l'amo. Tutto qui.
Compie cinquant'anni, oggi, Luisella.
Ha un marito da trent'anni, tre figli, una vita tranquilla alle spalle.
Ed è fuggita da tutto ciò.
Vi pensava, alla fuga, ogni tanto, di sfuggita, quando le pareva di vivere una vita non sua, ma prima i figli erano piccoli poi, con Giorgio, c'erano ancora briciole d'amore... Ora i figli sono grandi, le briciole sono state spazzate da parole fatti pensieri anni...
Cinquanta! L'avevano costretta ad interrogarsi. Voleva finire così i suoi giorni? Nell'appiattimento della consuetudine? Continuare nell'ipocrisia di un'esistenza che Giorgio aveva ritagliato per ambedue, ma su misura per sé?
Ma lei non è come Giorgio. È diversa. Trenta, quarant'anni fa, era una pazza felice. Ora è perfetta. Come lui. Due mostri. Non concedere spazio agli errori. Pianificare tutto. E diventi un mostro.
Non parlavano più. Ma quando avevano parlato? Se guardava indietro, una vera intesa c'era mai stata.
Dialogavano spesso con il corpo. Ma ora che anche il corpo era diventato muto?
«Non voglio passare il resto della vita a dirci niente» aveva pensato Luisella.
Ed era fuggita. Questa volta senza riflettere. Poche cose in una sacca, due soldi. Un salto sull'utilitaria.
Ed era al mare.
Ora è lì che dondola un piede sull'acqua, e forse già la stanno cercando.
È l'una, sono rincasati, ed ognuno ha percepito il senso di vuoto non appena ha aperto l'uscio e non è stato accolto dal profumo della cucina. Li vede: vagano frastornati per la casa che sa ancora di sonno, nulla sul fuoco, sulla tavola gli avanzi della colazione. Tentano di prepararsi il pranzo, ma non sanno dove mettere le mani, li ha serviti sempre lei, per trent'anni. Giorgio sibila ma dov'è andata quella cretina, ma inizia anche a preoccuparsi, è mai successo.
Stasera avranno organizzato la festa di compleanno, pensa. Tranquillamente. E guarda l'infinito, la valigia accanto, più in là il pescatore, il cane, i gabbiani, gli innamorati...
Ad un tratto il pescatore si volta e le sorride.
Luisella lo vede soltanto allora, prima era un'immagine indistinta, parte del paesaggio.
Ha occhi e capelli d'ebano, abbronzato, un bianco solare sorriso. È bello.
È giovane. Non più di quarant'anni.
«Buongiorno».
«Buongiorno».
Si rende conto che è parecchio che è accanto al pescatore. Ed è un po' imbarazzata.
Nonostante i cinquanta è ancora bella, i lunghi capelli arruffati, le lunghe gambe, e gli abiti da ragazzina. Gli uomini la guardano, un automobilista le ha fischiato, quella mattina. Non è poco alla sua età.
«Ha pescato?» domanda, per nascondere l'imbarazzo.
Così è iniziata l'avventura di Luisella.
Il giorno dei suoi cinquant'anni.
Hanno parlato molto sul molo quasi deserto (è ottobre) senza accorgersi che il mare stava diventando viola e le case sospese sull'acqua si spolverizzavano di cinerino.
Il pescatore è un giornalista che ha lasciato la città ed un lavoro importante perché non era la vita che desiderava. Ora sta scrivendo un libro e, per mantenersi, collabora ad un giornale locale.
Luisella gli racconta che ama leggere romanzi ma che lo fa quasi di nascosto perché al marito dà fastidio (è una cosa inutile, anzi dannosa.
Poi, mentre cala la sera, lui raccoglie gli attrezzi, lei la sacca, e si avviano insieme, senza parlare, verso il paese.
Non sa come sia potuto accadere, in cinquant'anni mai un colpo di testa, eppure stasera Luisella è a casa di un uomo appena conosciuto.
Bello, giovane, e con un sorriso di sole.
L'alloggio piccolo affacciato sull'acqua trabocca odora di libri giornali riviste carte quaderni parole pensieri...
Quando lui la volta e la bacia, è accanto alla finestra che guarda un mare nero e giallo di luna e di luci.
Poi la maglia sbottonata scende sulle spalle, scopre l'esuberanza del seno.
Lei si lascia accarezzare e pensa: è il mio regalo di compleanno.
Forse sarebbe accaduto se lui avesse continuato lì, vicino al mare denso di stelle.
Invece la prende per mano e sussurra: «Vieni».
Lei lo segue ardente discinta ma quando scorge il letto (l'attimo magico è passato) dice: «Non posso».
Proprio così. «Non posso».
Ritorna, Luisella, alla sua città. Alla vita di sempre. Corre sull'asfalto lavato da un estemporaneo acquazzone, tra lampi lividi.
È triste. Non per la mancata avventura (o poteva essere qualcosa di più?).
È triste perché sa che, nell'istante che ha rinunciato al pescatore, ha rinunciato a se stessa.
Il coraggio che l'aveva fatta fuggire quella mattina senza lasciare due righe, si era improvvisamente sgonfiato. La visione del letto, che aveva scatenato il suo rifiuto, era la realtà contrapposta al sogno di un giorno.
E lei non ha il coraggio della realtà.
E quando aveva detto «non posso» rispondeva anche all'idea di finire la vita sola, che aveva alimentato la sua fuga, ed ora pareva una pazzia.
A cinquant'anni! Quando non ne era stata capace da giovane.
Già ha dimenticato ch'era fuggita proprio perché aveva compiuto (e rinnegato) cinquant'anni.
Incipit del romanzo “Desiderata”
Mi manca nulla, senz’altro sarei felice se ogni notte non la sognassi, quella manina che si tende, che m’invoca, dalla buca profonda, e tutto intorno è fango, e io vorrei aiutare chi la protende, ma sono paralizzata, vorrei muovermi, ma non mi muovo, non posso muovermi: ed ecco che vedo solo più le ditina, e poi niente, è sparita, precipitata nel baratro, e anche a me allora pare di precipitare da un’altezza infinita, e mi manca il fiato come per un tonfo, come se precipitassi davvero, e mi desto sudata, angosciata, e urlo, e mio marito, come sempre, mi deve consolare, ma rassegnato, non domanda più nulla, mi stringe solamente a sé, e ripete le parole ormai logore:
“Non piangere, stella mia, è solo un sogno …. ci sono io, vicino a te, e ti amo…”
Confortata dalla sua voce, mi sveglio alla realtà e a poco a poco mi calmo, ma l’angoscia è sempre in me, ed è così quasi ogni notte, non vorrei venisse mai, la notte.
E allora penso: “Dio mio, perché devo soffrire, che cosa ho fatto, perché mi castighi così…”
Ma purtroppo lo so il perché, lo so …
Nacqui di primavera, non sotto il solito cavolo ma, come una regina, in un’aiuola di rose, e non mi punsi nemmeno.
Quando mi raccolsero i miei genitori impazzirono di gioia.
Raccontano che fossi talmente bella da apparire irreale.
Sulla testolina la lanuggine dorata era chiara da sembrare argento, e gli occhi splendevano come stelle azzurre.
Mio padre che mi aveva attesa tanto (ero la prima figlia ed aveva quarant’anni) volle chiamarmi Desiderata.
Appena nata, già si diceva ch’ero stata baciata dalla fortuna.
La casa bianca sulle pendici della collina era un tripudio di fiori e di sole.
La culla di legno, vecchia di generazioni, venne dipinta di rosa e rivestita con tendine di organza ricamate con nodi d’amore.
Mio padre attendeva tutto il giorno il momento di rientrare a casa.
Avevo circa un anno.
La mamma aveva cucito dei legacci ad un grosso cuscino.
Lui lo legava sotto il sedere, poi si accovacciava in terra, mi prendeva in braccio e ci trascinavamo sul pavimento imitando il verso del treno.
lo lanciavo piccoli strilli di gioia.
Adoravo mio padre, tanto quanto lui adorava me.
Potevo avere due anni, e già ero esperta nell’arte di mandarlo in visibilio.
“Sei il papà più bello del mondo “ tubavo, accarezzandolo.
E guai se qualcuno osava sostenere il contrario!
Questo è quanto mi narrava la mamma quando, ancora bambina, seduta sul suo grembo, le domandavo: “Mamma, ti prego, raccontami di quand’ero piccina piccina ...”
E tanto adoravo sentirla favoleggiare sulla minuscola Desiderata raccolta in un’aiuola di rose profumate, che mi facevo ripetere spesso la storia così che, alla fine, a forza di sentirla e di immedesimarmi in essa, mi pareva che tutto fosse frutto di una mia reminiscenza, i primi vagiti tra i fiori, le manine festose protese oltre il bordo di organza della culla rosa, i giochi con papà, quasi che, prodigiosamente, la memoria potesse arrivare fino al momento in cui avevo visto la luce, e neppure mi sfiorava il pensiero che le scene che mi apparivano nitide altro non fossero che il risultato del racconto ripetuto e della mia immaginazione.
L'amore
Episodio tratto dal romanzo Desiderata edizioni Montedit
“Ricordo, la prima sera, e quel portone,
dietro di te della città il chiarore
come un'aureola.”
Era ad attendermi. Bellissimo. Fumava, appoggiato ad un pilastro dei portici. Accanto la piazza ormai nera chiazzata di luci.
Mi sentii mancare nel guardarlo. Tanto mi emozionava la sua immagine.
Appena mi scorse mi venne incontro e il suo sorriso fu come un abbraccio.
"Ciao!"
"Ciao!"
Un piccolo mazzo di roselline color cipria era apparso nella mano fino a quel momento celata alla mia vista.
"Sono bellissime. Ma non dovevi ..." Ne sfiorai il profumo.
"Non potevo venire a mani vuote al primo appuntamento con la donna della mia vita ...”
"Come corri!"
Ci eravamo incamminati sotto i portici, chiacchierando e tacendo, ascoltando le nostre emozioni. E senza quasi accorgerci eravamo giunti ai giardini di fronte alla stazione centrale.
Era una serata stupenda, da estate di San Martino, nella leggera brezza il turbinìo delle foglie cadenti pareva una pioggia d'oro.
L'oro copriva il laghetto dei cigni, come un tremore di ninfee e, in terra, scricchiolava dolcemente sotto le scarpe.
L'aura era tiepida e dolce.
Ci fermammo vicino al laghetto, tra gli zampilli della fontana cangianti alle luci della sera.
E fu allora che, voltandomi a guardarlo, mi trovai tra le sue braccia.
Mi baciava. E avrei voluto fermare il tempo.
Le nostre labbra, il viso, il corpo, combaciavano perfettamente, parevano nati per essere una cosa sola.
E mi sentivo confondere, annullare in lui, la piazza ora danzava, le piante le panchine la gente le case si sdoppiavano, e in una dolce vertigine lo udii che mi sussurrava: "Ti amo".
A quelle parole, improvvisamente, mi sentii in pericolo. Se un bacio mi aveva così coinvolto, cosa sarebbe successo se gli avessi creduto rimuovendo le inibizioni che ancora mi frenavano? Sarei stata in suo potere.
Perché la sua presenza m'impediva di ragionare.
Ma come potevo essere sconvolta da una persona appena conosciuta? Appena conosciuta? Ma mi sembrava di conoscerlo da sempre, la sua immagine era nata con me, forse, quand'ero stata con Bob, era già come amassi Marco, un Marco sdoppiato, camuffato da americano, che si burlava di me. Erano così simili!
Con sforzo mi staccai.
"E' ora che torni a casa"
"Come, ma non sarà mezz'ora che siamo assieme!"
"La mamma mi aspetta"
"Speravo che cenassi con me …"
"Sarà per un'altra volta"
"T'accompagno"
"Grazie, prendo l'autobus"
E cosi dicendo scappai come una pazza, lo sentivo chiamarmi, mi dispiaceva di averlo abbandonato in quel modo e al tempo stesso pensavo che avrebbe riso di me, ma intanto correvo, e presi al volo l'autobus che stava arrivando, e quando fui sopra allora guardai fuori, forse speravo mi avesse seguito, invece non c'era, vidi solo il grigio livido del marciapiede deserto.
L'incidente
Episodio tratto dal romanzo Desiderata edizioni Montedit
"C'è una casa ferma
in cima alla collina.
Ha mattoni rossi,
le finestre piccole,
e un cortile aperto
sulla valle.
Crescono il verde, e i fiori,
i pensieri d'infanzia,
le lontane attese,
e gli amori,
e il babbo stanco si aggira
a coltivarli."
Agosto di nuovo in collina.
Ma mio padre pare assente, stanco, triste, tormentato da problemi di cui non vuole parlare.
Se mi avvicino per abbracciarlo fa un sorriso distratto, compiacente, e ricambia appena l'abbraccio.
Se lo chiamo "papalotto" il suo "bella gioia" di rimando è strappato, non sentito col cuore.
Non sta ai giochi, agli scherzi che ci hanno da sempre legato come allegri complici.
Non riesco a riconoscerlo.
Penso persino che non mi ami più, perché non prende l'iniziativa per una carezza, un abbraccio, una confidenza, e sembra subire i miei approcci.
Non s'incontra neanche con gli amici.
La nostra casa d'improvviso è diventata vuota e triste, e mio padre vecchio di cent'anni.
La mamma, da sempre l'ombra felice del babbo, è ora un'ombra mesta, disorientata, che, come me, non capisce che cosa sia successo.
Se gli domandiamo che cosa ha, lui dice nulla, e sfugge il dialogo.
Un giorno che mangiamo sotto il pergolato guardando la valle macchiata dal bianco di un piccolo cimitero in fondo al pendìo, dice: "Quando sarò morto, non ci sarà bisogno del funerale, datemi una spinta e arriverò a destinazione".
Lo esclama in dialetto, come una battuta, e ride, per farci capire che sta scherzando.
Ma non riesco più a sognare.
Né ad essere felice.
Sento un gelo al cuore.
Ho brutti presentimenti.
Sono i primi di settembre.
Siamo di nuovo a Torino.
Questa volta il babbo mi abbraccia e bacia, e mi dice due o tre volte "bella gioia".
Sono lieta che mi dimostri ancora il suo affetto, ma non posso fare a meno di domandargli: "Vuoi fuggire lontano che mi dai tanti baci?"
Sta uscendo per andare al lavoro.
"La mia sciocchina" esclama, ridendo.
E' ritornato ad essere il mio papà.
Sono felice.
Sono ancora felice un paio di ore dopo, quando odo squillare il telefono.
Ho dimenticato la tristezza e i presentimenti che mi hanno accompagnata per un mese intero.
Sto curando le piante sul terrazzino.
Ali bianche di nubi dipingono un cielo azzurro lacca.
Penso ad un ragazzo che ha appena telefonato.
Mille sogni allegri mi frullano in testa.
"Pronto"
"Chi parla?" La voce dell'uomo è triste e compassata.
Dico il cognome e poi "Ma chi è?"
La voce è sempre triste, raggelante. "Vorrei parlare con la signora".
"La mamma non c'è. E' uscita per la spesa. Può dire a me?"
"E' il pronto soccorso dell'Ospedale Molinette". Fa una pausa in cui mi sembra che deglutisca per prendere tempo.
Poi dice il nome del babbo chiedendomi "E' suo padre?"
Mentre sto tremando, riesco a dire "Sì".
"Ha una Giulietta targata TO…”
"Sì. Ma che cosa è successo?"
"Ha avuto un incidente…”
Come faccio a non svenire? "Ma come è accaduto? E' grave?"
"E' uscito di strada con l'auto. E' molto grave. Venite subito".
Poso il ricevitore e scappo pensando a mio padre che sta soffrendo e forse morendo e a come dirlo a mia madre che troverò a fare spesa dal verduriere all'angolo.
Desiderata fa la commessa
Episodio tratto dal romanzo Desiderata edizioni Montedit
"Aspro odore di carta,
di legno intagliato,
d'inchiostro, di timbri,
di cose di ieri ...
Ho sempre amato l'odore dei libri.
Le grandi librerie hanno un odore particolare, di carta appena stampata e carta più vecchia, d'inchiostro, di polvere, di fantasmi di parole infinite: storie raccontate, fantastiche e reali; pensieri sopravvissuti, come un testamento spirituale, a chi li ha partoriti; o riflessioni recenti, ancora sfarfallanti tra le pagine appena scritte: in ogni libreria, insomma, è racchiuso un piccolo mondo. Per quanto estese, sono sempre accoglienti, intime: centinaia di titoli, accatastati fino al soffitto, vestono le pareti e formano come un guscio che pare isolare e proteggere da ciò che succede all'esterno.
Quando vi entro mi sento a casa: mi piace sfogliare i libri che trovo sui ripiani più bassi, leggerne le recensioni, i riepiloghi, una frase qua e là, accarezzarne le copertine colorate, e ho quasi la tentazione di afferrare una scala per raggiungere gli scaffali alti e frugare curiosa fra i titoli dimenticati e grigi di polvere.
Ero entrata in un'antica libreria del centro, un pomeriggio di metà gennaio e, come al solito, non avevo voglia di uscirne.
Avevo scorso quasi tutti i libri a portata di mano, gli ultimi successi, e, infine ne avevo messo uno da parte per acquistarlo, "Il mondo salvato dai ragazzini", ma indugiavo ancora indecisa.
Un uomo, che prima avevo intravisto alla cassa, si era avvicinato, dicendomi: "Complimenti. Ha scelto bene. La Morante. La sua prosa è poesia. Piace alle persone intelligenti e sensibili. Le piacerà."
L'intrusione e il modo di parlare, per arrivare ad un complimento, stupido, perché nemmeno mi conosceva, mi misero sulla difensiva. Ma, osservandolo, incontrai uno sguardo franco e aperto, e compresi ch'era soltanto un malato di letteratura, come me, e stava facendo il suo lavoro.
"La conosco. E' una delle scrittrici che preferisco. Ho già letto Menzogna e sortilegio e L'isola di Arturo “ puntualizzai”.
"Avevo intuito il suo amore per i libri. Da come li guarda e li tocca. Quasi con religiosità. Ma non l'ho mai vista nel mio negozio".
Mentre parlava, si lisciava i baffi neri. La sua parlata aveva una lieve inflessione piemontese, benchè l'aspetto lo facesse assomigliare più ad un siciliano.
"Prima acquistavo vicino all'ufficio. Ora sono rimasta senza lavoro e sto cercando ... Ma poi ho visto la sua stupenda libreria, e non ho resistito alla tentazione di entrare. Anche se dovrei risparmiare."
"Sono uno dei proprietari. Può attendere un momento? Forse ho una proposta per lei."
Quale poteva essere la proposta? Non ne avevo idea. Era sparito nel retro e ora ne era uscito con un uomo che gli assomigliava molto (doveva essere suo fratello, anche se era più piccolo e grasso) che mi guardò senza avvicinarsi e poi si eclissò.
"E' mio fratello" confermò, appena mi fu nuovamente accanto "Scusi se non si è avvicinato, ma è un orso, sta nel suo ufficio a fare conti e non mette mai il naso fuori. E lei è troppo bella, lo mette in soggezione ... Può seguirmi? Vorrei parlarle senza essere disturbato."
Per un'antica scala di legno salimmo al piano ammezzato.
Lo studio dove ci accomodammo era rivestito a boiserie, ma tappezzato anch'esso di libri.
La finestra ad arco guardava sui platani spogli di una piazza settecentesca, che il tramonto tingeva di ciclamino.
"Mi ha detto che cerca lavoro. Io le offro una possibilità" esordì subito "Forse non è molto, ma fino a quando non troverà di meglio ... Ho licenziato un commesso, perché ho scoperto che rubava. Purtroppo! Stavo proprio pensando di mettere un'inserzione sul giornale, quando ho visto lei. E ho pensato: è entrato il sole, tutto pare più allegro e luminoso. Poi lei mi ha svelato, prima ancora con i gesti, gli sguardi, che con le parole, il suo amore per i libri. Ed infine vengo a sapere che sta cercando lavoro. E allora mi dico: ecco la nuova commessa. Non potrei trovare di meglio! Prima mio padre, che ora si è ritirato, poi mio fratello, che è un po' più vecchio di me, mi hanno sempre attorniato di tristi persone. Come ha visto, ho tre commessi macilenti e una donna (che è da noi da una vita) leggermente claudicante, la quale un po' perché zoppica e non è più giovane, un po' perché non vede molto, nonostante le lenti spesse un dito, impiega un'eternità quando deve trovare un libro. Poveretti, non gli faccio colpa per il loro aspetto, né penso di licenziarli. Ma è ora di cambiare rotta. Chi ama la cultura non necessariamente ama lo squallore. Tutt'altro! O pensa che solo chi è fisicamente scialbo sappia parlare di cultura. Poi c'è anche chi entra da noi, e sono i più, per acquistare libri che sono costretti a leggere per motivi di studio o di lavoro, e vedere certe facce non li invoglia certo a leggere, ma conferma soltanto ciò che già pensano, che lo studio fa male, abbruttisce e rincitrullisce, e che bisogna leggere il minimo indispensabile. Se invece ci fosse lei dietro il banco, una bellissima donna che pure sa parlare di tutto, perché ama leggere, allora il loro giudizio si capovolgerebbe! E sono sicuro che tornerebbero spesso e acquisterebbero molti libri. Gli uomini, se non altro, per rivedere lei, le donne per sentire i suoi consigli, per cercare di assomigliarle un poco."
Ero rossa per l'imbarazzo. "La ringrazio dei complimenti, ma non sono necessari. Ho talmente bisogno di lavorare, che accetterei qualunque cosa. E poi, fare la commessa non è un disonore. Lavorare in libreria!" sorrisi felice "Non vi avevo mai pensato, ma ora che me lo ha offerto, sono certa che mi piacerà moltissimo. Ma suo fratello è d'accordo?"
"Lo sarà, non si preoccupi. Quando può iniziare?"
"Anche domani."
"A domani, alle nove, allora. Porti il libretto di lavoro. Il romanzo è omaggio. Non dovrà più spendere soldi per i libri. Mi serve che sia informata e sappia consigliare i clienti."
Una tentata violenza
Episodio tratto dal romanzo Desiderata edizioni Montedit
A settembre iniziai ad accompagnare i clienti anche a cena.
Il capo aveva insistito: la mia collega non se la sentiva più, diceva ch'era ormai vecchia. Nel nostro piccolo reparto lavorava ora anche una ragazzina, ma era minorenne, e non aveva il permesso di uscire la sera.
Insomma, l'incombenza era mia.
L'idea non mi piaceva, anche se non c'era più Peppi a cui dover chiedere il beneplacito. Ma non potevo esimermi, e poi cenavo gratis, e le ore in cui ero impegnata mi venivano retribuite fuori busta con la maggiorazione per straordinario notturno. Erano circa dieci serate al mese, che equivalevano ad un altro stipendio. Non ero nelle condizioni economiche da permettermi di fare la difficile.
Spesso succedeva che qualcuno, che mi conosceva poco, facesse il furbo, un complimento, un'allusione, per vedere se ero conquista facile.
Ma ero sempre riuscita a ristabilire le distanze, ed a farlo senza offendere. Dopo non ero più importunata anzi, abbandonate le idee strane, s'instaurava quasi sempre un rapporto franco di collaborazione e simpatia. E gli incontri si concludevano con successo.
Finché, una sera, accompagnai a cena per la prima volta un cliente tedesco.
Era quasi Natale, aveva iniziato a nevischiare da poco, ed un turbinìo soffice e molle s'intravedeva nell'alone chiaro delle luci e dei lampioni.
In terra restava però soltanto una poltiglia acquosa.
Il tedesco era arrivato con la sua auto, una grossa Mercedes, e, tra le nostre proposte, aveva scelto di cenare in un ristorante della collina, dove c'era anche un po' di musica.
Era un tipo grasso, volgare, di circa cinquant'anni, il viso rubizzo, naturalmente chiazzato di rosa acceso, quando terminammo di cenare era diventato paonazzo per la birra il vino e gli alcolici che aveva trangugiato senza ritegno.
Già fin dall'inizio si era comportato in modo troppo spiritoso per i miei gusti, con complimenti spinti, avances per niente velate, che non ero riuscita ad arginare.
Ora aveva perso ogni inibizione (se mai ne aveva avute) e dovevo scacciargli le mani che, sotto il tavolo, tentavano di frugarmi, e cercavo di farlo con il sorriso sulle labbra, per non offendere la sensibilità di una persona che doveva trasmetterci un ordine di alcune centinaia di milioni (!).
Prevedendo che la serata sarebbe finita male, mi ero anche alzata con una scusa e avevo telefonato al mio capo per chiedere soccorso, ma non lo avevo trovato in casa. Ora dovevo affrontare il viaggio di ritorno, tra i tornanti deserti della collina, sull'auto di quell'energumeno depravato.
Mi veniva da piangere perché sapevo ciò che mi aspettava.
Appena in macchina, aveva allungato una mano ad afferrarmi un seno, e per una volta ancora mi ero fatta forza per non urlare, e lo avevo respinto senza profferire verbo.
Ma mi ero anche preparata ad affrontare il peggio.
Avevo un ombrello pieghevole che ora tenevo saldamente ancorato alla mano destra.
Non mi avrebbe oltraggiata, giurai a me stessa. Al diavolo il contratto, i milioni (che tanto io non avrei visto), non sarebbe passato sul mio corpo.
Vidi che svoltava in un sentiero scuro, ma non mi stupii, era una scena che mi ero aspettata, che nella mente avevo già vissuta. Anche le mie urla, di tornare indietro, facevano parte di quella scena. E lui che non mi ascoltava, andava ancora avanti, e poi, fermata l'auto, mi saltava addosso.
Ed io che lo colpivo con l'ombrello fino a farlo sanguinare, fino a farlo desistere.
E poi scappavo verso la strada, e stavolta ero fortunata, qualcuno subito mi soccorreva.
Mentre nevicava sempre più fitto.
Il tedesco parti la mattina dopo, senza nemmeno passare dall'ufficio.
In effetti non doveva essere molto presentabile.
Telefonò al direttore per annullare tutte le trattative, dicendo, più o meno, "siete un'azienda di cafoni" (l'insulto era in tedesco) e poi aggiunse ch'io ero stata molto maleducata e lo avevo pure insolentito.
Tacque sulle ombrellate, perché avrebbe dovuto anche raccontare altro.
Il direttore era viola di collera.
"Che cosa ha combinato ieri sera? Mi ha fatto perdere centinaia di milioni. Un contratto quasi definito, andato in fumo!"
"Mi sono semplicemente difesa! L'ho anche cercata, per chiedere soccorso, ma lei non c'era ... Se l'affare era così importante poteva presenziare alla cena, o perlomeno rendersi reperibile!"
"Quello che faccio io non la riguarda. E lei, da che cosa si è difesa? Non è capace di tenere a bada un uomo senza ricorrere agli insulti?"
"Ho fatto di più che insultarlo, l'ho preso ad ombrellate, l'ho anche ferito, non glielo ha detto? Ma non c'era altro modo. Era una furia. L'alternativa era essere violentata. E proprio non mi andava. Ha girato in una strada deserta e mi è saltato addosso ... non sentiva ragioni ... Ho dovuto reagire."
"Se è arrivato a tanto, lei lo aveva illuso, non me la conti..."
"Come si permette? Sono stata solo gentile, come sempre. Per la sua azienda di merda ... Per quei quattro soldi che mi da, e che purtroppo mi servono …”
"Non le permetto di parlare così. Allargate le gambe con tutti e poi, quando serve, fate tanto le preziose..."
"Porco schifoso, cerca la puttana che ti serve, perché io me ne vado, e non starò più un istante in questo ufficio!"
Ero furibonda. Mi vidi scaraventare sul pavimento con una manata tutto ciò che si trovava sulla scrivania.
Prima di voltarmi per uscire incontrai la sua faccia sbalordita.
Non si aspettava la mia reazione.
Mi aveva sempre visto dolce ed educata.
Anch'io ero stupita di me stessa. Ma ero stufa di subire.
Fuori pensai ch'era quasi Natale ed ero senza lavoro.
Torino 2006
(Le Olimpiadi in città)
In un tempo sospeso rallentato
lieve
come una dolce pacifica alluvione
un'umanità calda sorridente
nuova
scendeva dai colli al fiume alla città
invadeva vicoli si infilava ondeggiava
parlava anche, miracolosa sintonia,
trovava le parole universali
che sono sguardi e sorrisi e mani tese.
Anche chi non aveva i soldi
per arrivare a fine mese
poteva stringere la mano al mondo
e dare e ricevere allegria
- non occorre denaro per quello -
ecco ciò era bello
che l'operaio in cassa integrazione
fosse uguale al riccone
anche nei ticket gratis
al Medal Plaza,
in cui l'unica incombenza per avere il biglietto
era avere pazienza e aspettare in coda,
ma si sa chi non ha i soldi
alle attese è abituato e perciò favorito,
e questa poi non appare noiosa
ha il sapore della libera uscita,
l'alternativa è la tivu accesa
nella casa rinchiusa
o, da ricchi smaniosi, la casa fortezza
in cui rintanarsi la sera.
E andavamo complici, era Eden o Limbo
o non so cosa,
c'era un'aura in cielo e non paura,
ci guardavamo negli occhi, sì, ci guardavamo,
eravamo il mondo intero
panna, limone e caffè nero,
belli e brutti storpi e sani alti e nani,
eppure nella discordanza uguali,
era lo sport a renderci universali, a unirci?
Può darsi, anche, ma era la città a unirci
la città stregata
la si sentiva pulsare forte passionale
- passion lives here -
così com'è sotto la calma apparente
bianca e nera angelo e demone, da sempre.
Ma passato il momento l'euforia
da buoni piemontesi attendiamo
torni a parlare il vuoto nelle piazze
e il silenzio alle strade appeso indugi
chiaro,
ma chissà perché siamo un po' diversi ora
c'è rimasta la voglia di far festa
in fondo.
TORINO
L'aria è aria di monti
se il cielo è terso prova
tendi una mano e afferri
piramidi d'azzurro
l'aria è aria di boschi
la campagna è lì
inizia anzi continua
appena dopo la collina
l'aria è aria di mare
- non è poi così lontano il mare -
la senti arrivare con il vento del sud
e odora di sale
l'aria è aria di storia
non servono parole
vai e lasciala parlare, la città,
racconterà una lunga storia
l'aria è aria di silenzi
taci ancora, ti prego,
per sentirne la vera voce il canto
mentre scolora il sole
l'aria è aria di mistero
alita in antichi cortili
serpeggia in portici suggelli
di tenere malinconie
l'aria è aria di gioia
ora che della città hai l'anima
puoi urlare e raccontarti
tirando l'alba ai Murazzi
o nei tanti bar ove
giovani s'incontrano
mentre lento a sprazzi irruente
scorre a due passi il fiume.
LA CASA
C'è una casa ferma
in cima alla collina.
Ha mattoni rossi
le finestre piccole
e un cortile aperto
sulla valle.
Crescono il verde e i fiori
i pensieri d'infanzia
le lontane attese
e gli amori
e il babbo stanco
s'aggira a coltivarli.
ATMOSFERA
Atmosfera
è la sera
che scende sul fiume
colora
monti e colline
tra sole luna
poi sfuma
cortili accesi ai silenzi
piazze superbe
che salgono al cielo.
Atmosfera a Torino
è anche
la nebbia sottile d'inverno
al Valentino
a nasconder
nell'erba
giochi d'amore
a rincorrere ali di luce
per poi danzare eterea
fino a Superga.
ALLA RICERCA DEI CARI PERDUTI
Luna stelle stampano
dentelle di luce
sui nostri visi cercanti
in labirinti d'immenso
i cari viandanti smarriti
in giorni infelici.
Saranno nella via Lattea
o oltre?
Oltre cosa?
Il cielo sta venendo rosa
sparite strade d'oro
e chimere
non resta ch'attendere
un'altra sera.
CAPODANNO
(è bello perdersi)
A Nizza di Francia a mezzanotte quasi
del trentuno dicembre duemilauno
tre uomini distratti avanti a
tre donne cicalanti fitto
d'averle perse s'accorsero
solo a destinazione.
Tre donne cicalanti fitto
dietro tre uomini distratti
s'avvidero improvvisamente
d'esser sole quella sera
e che Nizza in quel rione
pazza non era
nella lieta ricorrenza ma
metafisicamente vuota.
La strada smarrirono
fluttuanti
in vapori leggeri di rosa
e senza l'esistenza di passanti
impossibile era
risalire il dedalo di vie.
Eppure risero le donne
per nulla spaventate
e libere
come libellule
all'attimo fuggente
idealmente brindarono
con immaginari
bicchieri di stelle.
Quella pazza notte a mezzanotte a Nizza.
IN RADA A TAVOLARA
(Armonia Universale)
Gira la barca lenta
come la rosa dei venti gira
nord est sud ovest e
lenta la barca gira
la vela alta di luci sfiora
alla vicina si confida
gira la barca lenta
come la rosa dei venti gira
ammicca Tavolara
panna chiara di luna
e grappoli di stelle in cielo
che altro conta
gira la Tavolara
come la rosa dei venti gira
calda la notte calda
del Re la rocca affonda
nell'acqua calma e complice
ci strizza occhi di fuoco
gira di Tonino ostello di paglia
come la rosa dei venti gira
guarda - ogni cosa gira -
noi raminghi - gira la vita gira -
gira la barca lenta
e guarda il cielo.
UTOPIA
Nel paese di non so dove
v'è sempre il sole, azzurra l'aria
e piume azzurre hanno gli uccelli
e cantano alberi in fiore
e le case hanno un giardino
e un tetto color fragola.
Nel paese di non so dove
non si conosce dolore
i bimbi hanno occhi ridenti
regalano uomini sorrisi
e animali corron liberi
in prati luminosi.
Nel paese di non so dove
quando giunge l'ultim'ora
una nuvola rosa atterra
un angelo al timone
e traghetta allegria
sotto bianche chiome
per non so dove cosa:
un altro paradiso?
ALLUVIONE
Giallo immenso gonfia
s'allarga il fiume
sotterra travolge
grande madre accoglie
nel grembo inghiotte
possente ogni cosa divora
terra casa storia
l'uomo impotente ancora
innanzi al creato la furia
è grande il fiume ch'avanza
è forza spettacolo ingiuria
lo scorgo in giù spietato
una abbandonata stanza violare
ma rimango a guardare
anatre allegre slittare nel gorgo
anch'esse ammaliate incoscienti
in fronte alla veemenza del fiume
confusa ai torrenti
son lago i sentieri Moncalieri
traballa il ponte a ponente
eppure vago
e ancora
due anatre m'incanto a guardare.
UNA VOLTA, REVIGNANO
Una bimba immersa
nel fango del fiume.
Scuote con un ramo
i girini e ride contenta.
Tre bimbe corrono
tra odori d'erba di grano.
Giocano come maschi
rotolando in profumo di terra
ma poi colgono spighe
e fiori di campo.
Sfiorando un piccolo cimitero
quasi bagnato dall'acqua
gaie ciarliere salgon la collina
ove due sorrisi attendono.
ORTA S. GIULIO
C'è un lago laggiù in fondo
piombo azzurro l'acqua
alte le sponde, verdi
ed una piazza appesa
a d'isola un sussurro.
D'anitre cigni bisbigli
di vecchie chiatte lente
tracce barbagli chiari
soli a interrompere
la calma irreale.
NEMMENO UN SOGNO
Mamma
quando m'hai lasciato per l'Eden
- oasi fabulosa -
ho rovistato a lungo
- in cerca di non so cosa -
ma sono rimasta delusa
non c'era un sogno scordato
in fondo a un cassetto.
IL PAESE SENZA LUNA
Padre Madre
è tanto che siete andati
in una terra che non conosco
ove le nubi son soffici molli
- e d'argento -
il sole tramonta mai
e la luna non esiste
- almeno penso -
perchè non so com'è - dov'è - il paese
da dove mi guardate fino ai vizi
più intimi, che pure capite
- e perdonate -
E' vero, è tanto che siete andati,
eppure ancora alita profumo di baci,
discorsi - pensieri detti, non detti
sussurrati -
e giochi di bambina, e poi bisticci
di parole ormai adulte, e scherzi allegri
- anche -
e mentre il tempo correva inesorabile
- com'è stato, sempre -
ma più contavo rughe sui vostri volti
- più vi amavo.
Son fuggiti anni da quando vi ha rapito
quel paese lontano e vicino
- anzi vicinissimo.
Polvere di stelle.
I vostri volti luminosi accanto a me.
QUEL MATTINO CHE MIA MADRE MORI'
Ogni tanto mi sorprendo
ad afferrare il telefono.
“Lo dico alla mamma”penso.
Ma non ci sei più ad ascoltarmi.
Posso parlarne soltanto ora, che è trascorso molto tempo dal giorno in cui mia madre morì. E debbo parlarne. Per riordinare i ricordi, affrontando il dolore che ne deriverà e, se risultassi colpevole, il rimorso.
Fin dalle prime ore del mattino il sole splendeva chiaro. Era una giornata che prometteva allegria. Già estiva. Anche se si era ai primi di giugno.
Con mio marito mi ero alzata presto ma, poiché era domenica, l'avevamo presa comoda: la colazione , il giornale, due passi in giardino.
Per pranzo attendevo la mamma e gli suoceri, ma non avevo fretta, molte cose erano già pronte.
Avevo sentito mia madre al telefono solo la sera prima, alle venti, era allegra
perché, al pomeriggio, era andata a far spese con l'altra figlia.
“Ti sento finalmente bene” le avevo detto.
“Sì, stasera sto bene” mi aveva risposto con voce squillante. Non la voce amorfa e infelice degli ultimi tempi.
Pochi giorni prima, il lunedì. L'avevo vista improvvisamente vecchia e curva, senza voglia di parlare, ed avevo avuto una stretta al cuore, un presentimento. Era appena tornata da Parma, ove aveva assistito per tre giorni
una sorella ammalata. Era andata e tornata da sola, in treno.
Quando mi ero recata a salutarla non mi pareva più la donna di prima, in tre
giorni era come se fossero passati almeno dieci anni, e mi ero domandata se
avessimo fatto bene a lasciarle affrontare il viaggio da sola. Mia madre aveva
quasi ottant'anni, ma era una donna eccezionale, lucida, vitale, piena d'interessi. A gennaio aveva avuto un lieve collasso, ma poi si era ripresa.
Quell'ultimo lunedì lei, che non si lamentava mai, mi aveva detto che sentiva
un gran vuoto dentro.
“Sarai esaurita”
“No, non hai capito. Non so come spiegartelo. E' un gran vuoto. Come la vita che se ne va ...”
Le avevo detto di venire da noi, ma lei, al solito, aveva detto no. Amava l'indipendenza (da quando il babbo era morto viveva sola) o almeno ce lo faceva credere, per lasciarci liberi. E io non avevo insistito quel tanto che l'avrebbe convinta, come quando non era stata bene, che l'avevo trascinata quasi di peso. Ora pensavo di costringerla a fermarsi da noi almeno una settimana. Aveva bisogno di compagnia. Ed io avevo rimorso per la sua solitudine.
Intanto ero entrata in cucina e mi ero messa a lavare l'insalata. In quel momento mio marito aveva attraversato veloce l'ingresso dicendo che andava
fino al nuovo stadio per vedere il tragitto che gli sarebbe convenuto fare al pomeriggio (c'era la prima partita dei mondiali di calcio).
Non ebbi il tempo di parlargli ch'era già fuori.
Mentre ero rimasta imbambolata con in mano una foglia d'insalata, pensai di
chiedergli se intendesse anche passare a prendere mia madre, al ritorno dallo
stadio.
Uscii ch'era a metà discesa e non mi poteva più sentire.
Impossibile contattarlo. Non avevamo ancora il cellulare.
Guardai l'ora. Erano le nove e mezza.
Lo stadio era lontano, mio marito non sarebbe tornato prima di due ore, i figli dormivano ancora. Potevo andare a prendere la mamma. Avremmo chiacchierato noi due sole in cucina mentre terminavo di preparare il pranzo.
L'avrei fatta parlare dei suoi problemi. Volevo approfondire il motivo di quel recente disagio che le avevo letto negli occhi e nel corpo improvvisamente
incurvato. Quando ci vedevamo m'invogliava a parlare di me ed io dimenticavo
che forse lei aveva problemi maggiori dei miei. Era sempre così allegra, piena di vitalità!
Ma se passava mio marito a prenderla? Poiché io non andavo mai prima di mezzogiorno, era probabile. E allora si sarebbe inquietato perché non l'avevo
avvisato.
Ciò mi frenò, e mi arrabbiai con me stessa per non averglielo chiesto.
Così, vado, non vado, ero rimasta lì, a lavare l'insalata.
Intanto un figlio si era alzato, gli avevo preparato colazione, poi il giardiniere mi aveva chiamato per chiedermi come doveva sistemare la tenda
sopra il tavolo dove avremmo pranzato.
Erano le dieci. In quel momento mia madre stava morendo. Sola.
Se avessi seguito il mio istinto di andarla a prendere, non l'avrei forse salvata, ma avrei potuto raccogliere le sue ultime parole.
Proprio allora pensai le telefono, le domando se sta bene, se ha dormito, poi
due stupidaggini, se è già andata in chiesa, se si è messa in ghingheri per il pranzo...Avevo voglia di parlarle.
Ultimamente, da quando aveva avuto il collasso, avevo preso l'abitudine di chiamarla tutte le mattine verso le nove, dopo ero più tranquilla.
Mi frenai di proposito. L'avevo sentita solo la sera prima, fra due ore l'avrei vista, le telefonavo fin troppo spesso, ero io a metterla in apprensione.
Per innumerevoli altre volte, e sempre per lo stesso motivo, frenai l'istinto di telefonarle.
Mi sono spesso domandata: ma se l'avessi chiamata e non l'avessi trovata, sarei corsa da lei? No, avrei pensato che fosse a Messa. E mi sarei allarmata soltanto dopo un po' di tempo.
Mancavano quindici minuti a mezzogiorno quando mio marito rientrò. Con i
suoi genitori e un fratello. Ma non mia madre.
Si sedettero al sole a conversare.
Sistemai sul tavolo in giardino una tovaglia azzurra come le strisce della tenda, i piatti candidi e i bicchieri di cristallo.
Fasci di luce interrompevano le zone d'ombra e cangiavano sulla tavola apparecchiata.
Osservai soddisfatta.
Quell'anno era la prima volta che pranzavamo all'aperto.
Nel mentre avevo preparato degl'involtini di pesce spada che ora stavo friggendo e allora pensai di mandare il giardiniere a prendere la mamma.
Telefonai per avvisarla che si tenesse pronta.
Non rispose.
Pensai: sarà a Messa.
Riprovai un'infinità di volte, sempre più in apprensione, e dicendomi ch'era
assurdo che lo fossi, all'uscita della chiesa si sarà fermata a chiacchierare.
Telefonai a una sorella (siamo in tre) per chiederle se sapeva se fosse andata
a Messa e a che ora.
Rispose il marito dicendo che mia sorella riposava ancora. Non era stata bene, si era svegliata alle otto per prendere la medicina, poi si era riaddormentata.
“Tua madre sarà a Messa senz'altro” mi disse “Sta tranquilla”
“Hai ragione. Non la svegliare”
Riagganciai.
Intanto avevo mandato il giardiniere dalla mamma, dicendomi nel frattempo
rientrerà, ed ora rigiravo come un automa il pesce, che non doveva bruciarsi.
Il pesce stava comunque venendo una schifezza, ogni istante ero al telefono,
che suonava a vuoto, ora ero proprio allarmata, la mamma era precisa, sapeva
che andavamo a prenderla, non si sarebbe attardata così a lungo.
Presi anche la guida per telefonare alla sua vicina e sentire se avesse notato qualcosa d'insolito e se poteva andare a vedere, ma non ricordavo il nome di
battesimo e c'erano tre pagine con quel cognome, tremavo e non riuscii a
trovarlo.
Alle dodici e un quarto non resistetti più e telefonai a un'altra sorella che
abitava vicino alla mamma.
Rispose mio cognato.
Gli dissi che avevo provato più volte a telefonare, ma mia madre non rispondeva.
“Sarà a Messa” disse anche lui.
“Ma sapeva che andavamo a prenderla verso mezzogiorno, glielo avevo detto ieri sera... Se è andata alla undici, dovrebbe già essere rientrata. Ho mandato il
giardiniere, ma non sono tranquilla. Ho paura che si sia sentita male per strada...
Tu, o Mirella, che siete vicino, potete andare a vedere?”
“Vado subito io, che sono vestito”
Tornai automaticamente a cucinare, pensando che la mamma si era già inquietata altre volte, che avevamo messo a soqquadro mezzo mondo perchè non l'avevamo trovata in casa, e si sarebbe arrabbiata anche ora.
“Non posso dirvi ogni passo che faccio!”avrebbe borbottato “Non so perché
dobbiate sempre mettervi tutti in agitazione!”
Intanto continuavo a fare il numero a vuoto, ora ero quasi certa che fosse successo qualcosa, ma in casa non se ne accorsero (erano tutti in giardino)
e io non esternai la mia preoccupazione.
“Finirà tutto bene, si sarà fermata a chiacchierare”mi illudevo”E non voglio che poi dicano: quella pazza, ci ha fatto preoccupare per niente!”
Dopo dieci minuti, saranno state le dodici e venticinque, rispose mio cognato:
“Oh, finalmente, la mamma è rientrata? Sta bene?”
Una pausa. “Tua madre è morta”
Proprio così, disse, soltanto così, senza preamboli: tua madre è morta.
Non sta male, ha avuto un malore, ma “tua madre è morta”, senza appello,
senza remissione.
Era talmente enorme ciò che mi stava dicendo che quasi non ci credevo.
Forse si sarà sbagliato, pensai, sarà solo svenuta, non sarà morta.
Ma poi mi dissi che non poteva essersi sbagliato, mia madre era morta.
E fu una sensazione spaventosa, di dolore, di rabbia, di rimorso, d'impotenza.
Avrei potuto andarla a prendere io, anziché mandare il giardiniere. Questo, forse, la mamma non ci avrebbe perdonato (non è vero, la mamma ci avrebbe
perdonato qualunque cosa) che a trovarla morta, ad abbracciarla per primi, a vederla scomposta, fossero stati un estraneo ed un parente acquisito, e non una
figlia.
La strinsi ch'era ormai fredda.
Era quasi pronta per uscire: le calze, la sottoveste, la camicetta di seta, un giro di perle ed uno d'oro intorno al collo.
Poi doveva essersi sentita male, e si era distesa sul letto.
Aveva le mani serrate sulle tempie, come per ripararsi dall'improvviso dolore, era un po' rannicchiata, quasi in posa fetale, non si era messa la dentiera, e sembrava proprio una vecchietta, tenera e fragile, com'era mia nonna
(e sua madre) quando l'avevo vista sul letto di morte.
Le mie sorelle, mio marito, i miei cognati, tremavano, mi feci forza e le misi la dentiera prima che s'irrigidisse.
Mandammo fuori dalla stanza gli uomini, poi la lavammo, la sistemammo, noi tre da sole.
Ora, distesa sul copriletto di pizzo, era bellissima come sempre, il viso sereno, pareva soltanto dormire.
Fu l'inquilina del piano di sotto a dirci ( e lo confermò il dottore ) che la mamma doveva essere mancata verso le dieci. Un infarto, forse. Riuscimmo ad evitare l'autopsia.
Costei, una fissata che patisce anche il più lieve rumore, riferì che l'aveva udita muoversi fino a quell'ora. Poi niente. E si era preoccupata (sic!) che si
fosse sentita male. Perchè non aveva tirato su le persiane, e non l'aveva sentita
uscire.
La mamma aveva l'abitudine di far colazione, lavarsi e poi (mai oltre le dieci) arrotolare le tapparelle di tutto l'appartamento.
Le domandammo perchè non ci aveva chiamato, aveva i nostri numeri di telefono. Disse che non glieli avevamo mai dati, poi che l'aveva persi.
Con mia madre, quel dieci di giugno, è morta anche una parte di me.
Improvvisamente mi sono sentita persa, senza radici, senza sostegno.
Perché, ora lo so, era lei a sostenerci, a consigliarci, noi avevamo bisogno di lei forse più di quanto ella avesse bisogno di noi!
E la mamma ci ha “fregato” andandosene in un lampo, senza darci tempo di
occuparci di lei. Mentre a noi faceva comodo pensare che, anche se viveva sola, quando avesse avuto bisogno, saremmo state presenti.
L'unica cosa che può placare il rimorso è che non se ne sia accorta, ma se ne sia andata così, mentre si preparava per una giornata felice.
QUEST'ESTATE, IN SARDEGNA
È successo quest'estate, in Sardegna. Colpevoli le circostanze, i sentimenti ed io che, appena approdo in questa terra selvaggia, mi sento diversa euforica libera, e come drogata dall'inconfondibile profumo portato dal vento. Eravamo arrivati in gruppo, con la barca d'un amico. Il viaggio era durato più del previsto per la burrasca che ci aveva costretti ad attendere due giorni a Porto Vecchio che il mare si calmasse. Il contrattempo ci aveva disturbato ma, passate le bocche di Bonifacio, il nostro umore era già cambiato. Un tramonto stupendo colorava il mare e il cielo lavato dal vento. Procedevamo come in un immenso lago iridescente: a sinistra le sponde erano le isole rupestri di Budelli, Spargi, la Maddalena, Caprera, a destra il paesaggio dolce e aspro sardo, con i monti che svettavano, minareti scarlatti nell'imbrunire.
Lo champagne, in barba al nazionalismo, frizzava nei bicchieri levati in lieti brindisi, e i nostri canti ci rincorrevano sul mare.
Ecco il pontile in legno che ci accoglie, sotto le case abbarbicate sul pendìo. Ed è proprio nella confusione del momento dello scarico dei bagagli, nell'euforìa dell'arrivo, che provo la prima allarmante sensazione.
Carlo, il ragazzo della mia vita (lo chiamo così perchè da quando mi sono svezzata non ho conosciuto che lui), è già sceso con una parte dei fagotti. Sto raccogliendo le ultime cose quando si avvicina Alessandro per aiutarmi. Nel far ciò mi sfiora una spalla nuda e mi fissa intensamente con il verde dei suoi occhi. Ed io mi sento rimescolare dentro come non mi è mai successo.
Alessandro è il proprietario della barca e un vecchio amico di Carlo. Qualche volta l'avevo anche visto in città ma non mi era simpatico. Troppe ragazze stravedono per lui, che le cambia in continuazione, senza porsi problemi. In viaggio ho dovuto ricredermi. É l'anima della compagnia, sempre allegro, un trascinatore, inoltre è un tipo sveglio che non si arrende di fronte alle difficoltà. Il costume adamitico ne esalta il fisico snello e muscoloso, e gli occhi chiari risplendono maliziosi sul volto abbronzato.
Ma è solo un attimo di smarrimento. Ecco Carlo che mi attende sul pontile, buffo e patetico. Il sole lo ha dipinto di un rosso aragosta. Mi fa tenerezza. È l'uomo che sposerò tra un mese.
Ci siamo accampati nell'appartamento di uno del gruppo, quattro camere da letto più due bagni e un soggiorno. Siamo dodici in tutto, sei femmine e sei maschi, per cui dormiamo tre per stanza, le ragazze da una parte e i giovanotti dall'altra.
Poiché non siamo ordinati, siamo giovani e in vacanza, si può immaginare come la confusione regni sovrana, insieme ad una elettrizzante allegria.
Solo Carlo è spento, abulico e scottato in modo orripilante. La sua pelle bianca, da sedentario incallito, è paonazza, arrostita dal sole che ha dovuto subire suo malgrado sulla barca. Ora le vesciche si stanno staccando rivelando strati profondi di pelle rossa. Abbiamo pure dovuto chiamare un medico perchè gli è venuta la febbre. E' noioso, non posso fargli una carezza che strilla. Dice di uscire, che lui vuole stare a casa solo e tranquillo, e sia maledetto 'sto paese e 'sto mare di merda.
Me lo lascio dire una volta, poi, alla seconda, non me lo faccio ripetere e fuggo con gli altri, nel sole.
L'arena è così bianca e fine che si è incollata alla nostra pelle bagnata.
Siamo distesi direttamente sulla spiaggia e ci divertiamo ad avvolgerci nel velo della sabbia, per poi buttarci nuovamente in acqua.
Alessandro si è disteso vicino a me, ogni tanto una gamba un braccio sfiorano la mia nudità.
Scherza, facendomi piccoli dispetti, e io, fingendomi arrabbiata, evito di guardarlo, perchè ogni volta che i nostri sguardi s'incontrano sento un turbamento, un'eccitazione coinvolgermi, ed ho quasi paura di ciò che provo.
I cespugli di ginepro e lentisco dividono per cinque o sei metri la spiaggia dal sentiero dove abbiamo lasciato la jeep.
Sono rimasta ultima perchè non trovavo un sandalo e Alessandro mi ha aspettato. Ora mi aiuta a risalire le dune sospingendomi delicatamente per un braccio.
Ma ad un tratto la pressione della sua mano aumenta, inequivocabilmente. Ed io,nel voltarmi a guardarlo risentita, mi perdo invece nella passione dei suoi occhi, e sento che sarebbe bello annullare i complessi di colpa e buttarsi nelle sue braccia.
Dico invece: "Mi fai male"
Ma lui stringe più forte e mi sussurra: "Mi fai impazzire, sono pazzo di te"
Ora barcollo, mentre mi avventuro a casaccio tra i cespugli, pungendomi le gambe.
La discoteca è bianca, bassa, circondata da vetrate, una veranda affacciata sul mare.
Carlo finalmente si è deciso ad uscire di casa ma, dopo avermi concesso un ballo strillando che non appoggiassi le mani in nessuna parte del suo corpo piagato, per cui alla fine abbiamo danzato a debita distanza, si è seduto immusonito per il sacrificio che gli era stato imposto.
Alessandro mi ha allora invitata a ballare.
Che bello essere finalmente tra le sue braccia!
Mi dimentico completamente di colui che fino ad un istante prima era il mio "promesso sposo" (almeno questo era ciò a cui m'imponevo di credere). Non esiste più. La meravigliosa realtà è Alessandro, l'estasi dei nostri corpi
allacciati, degli sguardi persi l'uno nell'altro.
Tutta una vita che uscivo con Carlo e mai avevo provato una sensazione così forte e completa.
Il mare trema nero sotto la luna, la brezza porta l'odore della macchia sarda, e a me viene voglia di piangere per la felicità.
Ogni ritegno è abbandonato, anche Carlo deve essersi accorto della nostra passione, perchè se ne va, ed io quasi non me ne accorgo.
La barca di Alessandro oscilla nella brezza, ancorata nel porticciolo.
Poi lui accende i motori, io mollo gli ormeggi, e partiamo nella scìa della luna.
Al largo buttiamo l'ancora e poi siamo noi due soltanto.
Finalmente! Il desiderio proibito agognato che diventa realtà. Le parole d'amore s'intrecciano tutta la notte e levitano accarezzando il mare, mentre ci possediamo con inesauribile gioia e curiosità, fino alle profondità più intime del nostro animo.
Siamo andati nell'alloggio a ritirare le nostre cose. Non ci hanno quasi rivolto parola e siamo usciti in fretta, respinti da un muro d'indifferenza ostile. Carlo ha continuato a leggere un libro, come se fossi diventata invisibile. Ci rimproverano il torto che abbiamo fatto a Carlo, e quindi a tutti loro, che gli sono amici. Dopo quanto è successo ci considerano indegni di appartenere al loro clan.
Usciamo mortificati, consapevoli delle nostre colpe.
Ma poi, dopo un po', ripensando a quelle facce immusonite, ci vien da ridere e, forti della nostra intesa, ridiamo ridiamo fino alle lacrime e ci rimandiamo, imitandone il tono e l'espressione, le poche parole indispensabili che si erano degnati rivolgerci.
Quasi due mesi vissuti in barca, girovagando per la Sardegna più segreta, noi due soli. Pernottare in rada a ridosso di insenature stupende e irraggiungibili da terra, lasciando che il mare culli i nostri appassionati
abbracci. Attendere che sia il sole a svegliarci filtrando dall'oblò sopra il letto e giocando con i nostri volti addormentati. Bagnarsi vestiti soltanto della propria pelle. Camminare abbracciati per i piccoli paesi ove approdiamo, non ancora violentati dal progresso.
Ma ogni tanto, nella felicità, s'insinua doloroso il timore che la nostra storia possa finire, perché troppo bella per durare.
Ed allora, se pur inconsciamente, bruciamo le tappe, vivendola il più intensamente possibile.
Talvolta mi ricordavo di avere dei genitori che mi attendevano, e telefonavo. Succedeva comunque di rado, perché quando lo facevo dovevo udire soltanto recriminazioni e rimproveri.
"Ecco, è il diciannove di settembre, e ancora non torni" si era lamentata l'ultima volta mia madre "E pensare che, se fossi stata una ragazza con la testa sulle spalle, saresti già da cinque giorni la moglie di Carlo."
Difatti le nozze erano state fissate per il quattordici di settembre.
Il pensiero del dolore dei miei, del dolore di Carlo, dell'appartamento arredato rimasto vuoto, di tutto ciò a cui avevo dato un calcio per quella passione improvvisa, riusciva momentaneamente a spegnere la felicità.
Ma ormai non potevo e non volevo tornare indietro.
Settembre volge al termine.
Le giornate sono sempre più fredde e più corte.
E così, un giorno bigio, giriamo la prua a nord e iniziamo la traversata.
Siamo tristi, come il tempo. Il presentimento che molte cose cambieranno al rientro in città, mi fa desiderare che qualcosa succeda a prolungare la vacanza.
Qualunque cosa, anche una burrasca che ci sospinga in direzione opposta alla meta, non importa se mettendo a repentaglio la nostra stessa vita. Già immagino un'isoletta deserta che accoglie i naufraghi, che vivranno felici
soltanto del loro amore, lontani da ogni contatto con la realtà.
Invece il mare livido è piatto come una tavola sotto il cielo plumbeo.
Un solo momento di allegria quando, dopo aver lasciato la Corsica, un branco di delfini circonda saltellando la barca. Poi l'umore ritorna nero. Alessandro, poiché siamo in mare aperto, è impegnato a pilotare, io inseguo
malinconici pensieri.
Dopo quattro ore di acqua e cielo, cielo e acqua, ci appare infine l'isola della Gallinara.
Siamo in costa.
La prima volta che usciamo in città, litighiamo.
Sono passati tre giorni dal nostro rientro ma non abbiamo potuto vederci prima perché lui è sempre impegnato. Deve difatti partire per uno stage negli
Stati Uniti, dopo la laurea che ha conseguito a giugno.
Dice che prima deve sistemare una miriade di cose, perché poi rimarrà via un anno intero. Mi sembra che dovrebbe trovare un po' di tempo per noi, appunto perché poi rimarrà via così a lungo.
Il fatto è che non siamo più gli stessi, e niente può essere come prima. E che, appunto perché la nostra breve storia è stata così bella, non riusciamo ora ad accontentarci di qualcosa di diverso e, insistendo, distruggeremo soltanto l'incanto del ricordo.
Lo so che è finita, quando lo abbraccio all'aeroporto, mentre l'altoparlante annuncia la partenza del suo volo.
Ti scrivo, mi scrivi, ti telefono, sono solo parole.
Non fingiamo Alessandro, non rimpiango nulla, sapevo che non poteva durare. Il profumo della Sardegna ci aveva drogato, ma abbiamo trascorso due mesi irripetibili, indimenticabili.
Non rimpiango neanche l'ometto che il destino sembrava avermi assegnato per marito.
Anzi ti ringrazio per avermi aiutata a capire che l'amore può essere qualcosa di più d'un tepido affetto, qualcosa che ti sconvolge, ti distrugge anche, ma ne vale la pena, perché ti fa sentire viva.
E prima che mi legassi definitivamente ad un uomo che ora so non era adatto a me, né io a lui.
QUELLE ESTATI IN CAMPAGNA
ovvero: TRE SORELLE
Eravamo tre bambine bionde dagli occhi di fiordaliso.
Una foto di quell'epoca: più o meno una quindicina d'anni in tre.
Tentiamo di essere composte: siamo vestite a festa! Ma sprizziamo ironia. Un'ironia già amblematica della nostra personalità. Io, la maggiore, mi atteggio a diva, ho assunto una posa vezzosa, appoggiata sulla gamba appena flessa, sorrido all'obiettivo.
La seconda ostenta invece un piglio deciso, da maschiaccio: il mento sollevato, le mani sui fianchi, le gambe divaricate, lo sguardo diritto, sembra dire: qui comando io!
Poi c'è la piccina, una patatina tenera, due passi indietro rispetto a noi, che ci guarda con adorazione. Sullo sfondo un'aiuola, il profilo di un portico con l'altalena e colline sfumate di sole.
Eravamo tre bambine bionde, dagli occhi di fiordaliso.
Di domenica andavamo a messa, indossando gli abiti migliori che mamma aveva preparato sul letto. Sembravamo tre angioli. Ma le calzine bianche ad uncinetto non riuscivano a celare i graffi e le spellature conseguenti agli scivolamenti giù per le ripe e i lividi per i pestaggi con i ragazzini nostri vicini.
Eravamo tre maschiacci.
Non avevamo varcato la soglia che già ci sfilavamo gli abiti, le scarpe immacolate, che atterravano a casaccio nonostante gli strilli di mamma. Con che sollievo indossavamo le magliette slabbrate i calzoncini stracciati e scappavamo a piedi nudi sull'aia e giù per la ripa fino al fiume!
Eravamo due incoscienti. Più una patatina che ci seguiva ovunque senza fiatare.
Amavamo il fiume. Vi sguazzavamo. Lo guadavamo in lungo e in largo. Sempre in fila indiana. Io per prima tenendo avanti un bastone per misurarne la profondità. Se non superava un nodo che era all'altezza dei fianchi della più piccina, potevamo procedere. Ogni tanto lei piangeva, anche perché le raccontavamo storie su rettili e mostri che popolavano il fiume. Era troppo buffa quando il viso paffuto si rigava di lacrime. Ma non avrebbe mai rinunciato a seguirci.
Eravamo tre zingare.
Già allora amavamo la libertà assoluta. Essere zingare, per poi trasformarci in principesse.
Quando ne avevamo voglia, cioè non troppo spesso, eravamo capaci d'agghindarci e stupivamo le amiche di mamma per le buone maniere.
Eravamo allora tre principesse in miniatura.
Adesso.
Siamo tre principesse.
Siamo tre maschiacci.
Non siamo più tre bambine bionde dagli occhi di fiordaliso.
CRONACA DI UNA NOTTE
Dalla Stampa:"Stanotte mille stelle cadenti"
17 Novembre 1999
E' una notte tersa e gelida, spazzata da un sentore
di prossima neve. Cuori di stella pulsano in cielo.
A ovest una luna bianca celia dietro un pino macchiandolo
d'argento.
Guardando ad est, verso la costellazione del Leone,
aspetto dietro i vetri che la cometa Tempel-Tuttle
scuota la coda regalando una pioggia di luce. Posso
stare ore di fronte ad un cielo stellato, a vedere
palpitare l'infinito. Ecco: è come un dialogo con
l'infinito. E con chi è volato via, e mi parla...
Da dove?
Sono le due.
Tempel-Tuttle non ha ancora scosso la coda. Ma la
notte è splendida. Non una stella è mancata all'appuntamento, e tutte hanno indossato le vesti migliori, pare
un'immensa festa, un gran bisbigliare, un gran danzare,
nel cielo.
Ore 3.
Il cielo è immutato. Ma ancora mi parla (o almeno mi
pare). Tempel-Tuttle non ha ancora scosso la coda. La
pioggia di Leonidi non si è vista.
Ora già la luna riposa dietro il pino.
La volontà di stare sveglia vacilla. Domani, come al
solito, la sveglia è alle sette e mezza.
Ma devo resistere.
Ore 4.
Delusione. Niente di niente. Ho solo più un occhio
che stento a tenere aperto. L'altro è già partito per
il mondo dei sogni.
Mi sono svegliata indolenzita, al primo raggio di
sole, la testa sul davanzale. Sghignazzamento generale
per la mia perenne ingenuità.
E' vero: non ho visto nulla. Ma anche questa volta ho
sognato guardando le stelle.
"UN ANGELO"
Quasi tremila metri. Lo skilift è arrivato sulla
cima. Proseguo per qualche metro con gli sci, prima
d'iniziare la discesa. E, in un cielo terso, mi appare
allora tutto il cerchio delle montagne.
Come dieci anni fa, in questo medesimo punto.
Anche allora c'era il sole, ma pure un vento gelido
che, con lunghe dita di ghiaccio, sollevava in improvvise
vorticose folate il velo di neve caduto nella notte.
Avevo vent'anni, a quel tempo. Sciavo da poco e degli
amici fetenti mi avevano convinto a tentare il Motta, una
delle discese più impegnative di Sestriere. Poi, da incoscienti, ritenendo che non avrei avuto problemi, si erano
lanciati giù per il pendìo (ai miei occhi di allora "precipizio") ed io ero rimasta sola, bloccata dal panico ed
accecata dal pulviscolo di neve e dal vento.
Lacrime impotenti di rabbia, che inutilmente tentavo
di reprimere, mi offuscavano gli occhi, mentre mi ripromettevo vendetta, guardando loro, punti neri in fondo
alla valle, sbraitare perchè mi decidessi a scendere.
Oltretutto il terrore di affrontare la discesa mi
aveva fatto procedere in orizzontale, ed ero quindi
finita sull'orlo estremo della pista, dove non avevo
spazio, nè coraggio, per girare, benchè fosse l'unica
cosa che avrei dovuto fare, se non volevo precipitare
in una voragine di massi e neve fresca, dove non sarei
riuscita a fermarmi.
Ormai avevo deciso. Sarei rimasta lì fino a quando
non fossero venuti a prelevarmi con un taboga.
Ogni tanto scendevano degli sciatori, ma nessuno
pareva preoccuparsi di me.
Nel frattempo il freddo, insieme al timore di
essere dimenticata lassù, aveva cambiato le mie
intenzioni, e tentai cautamente di girare gli sci, che
presero velocità, e mi ritrovai quindi in terra, miracolosamente appesa ad un arbusto che spuntava dalla
neve.
Fu in quel momento che sentii dirmi: "Posso
aiutarti?"
Il ragazzo mi apparve come un angelo, anche se
l'aureola era formata da un arruffio di riccioli neri.
Gli occhi scuri danzavano allegri in un viso abbronzato,
schiarito dal bianco di uno splendido disarmante sorriso.
"Grazie. Quei disgraziati che si definiscono amici
mi hanno abbandonato in questo casino."
Si era messo più in basso di me, per evitare che
i miei sci slittassero ancora. "Adesso cerca di raddrizzare gli sci":
Poiché però a quel punto non riuscivo a connettere,
si chinò e li raddrizzò lui stesso.
"Ora puoi alzarti, sta tranquilla, di quì non puoi
sfuggire, ci sono io." E mi aiutò sollevandomi per un
braccio.
Dato ch'ero a monte,rispetto a lui, ed egli era
parecchio più alto di me, i nostri visi per un istante
furono vicini, quasi a sfiorarsi, e lo vidi bellissimo.
"Adesso scendi adagio, in derapage"
Così facendo, con lui accanto, dopo un periodo che
mi parve interminabile, arrivammo al fondo della discesa.
Avrei ucciso gli esseri informi che mi attendevano
sghignazzando. Non risparmiai comunque gli insulti, che
servirono soltanto a scatenare ancora di più la loro
ilarità.
A quel punto l'angelo bruno mi salutò scendendo a
valle seguito da una nuvola di neve che si sollevava
a serpentina dietro gli sci, che usava splendidamente.
Il percorso rimanente, dopo quell'esperienza, mi
sembrò facile.
Per un paio di giorni sbirciai ovunque, con la
speranza di rivederlo, ma pareva svanito nel nulla,
così com'era apparso.
Due sere dopo andammo a cenare in un rifugio a 2500
metri, dove si arrivava solo con la funivia.
Era una sera chiara e serena, di luna piena.
Al ritorno i più bravi sarebbero scesi con gli sci,
portando ognuno una fiaccola per far luce, benché non ce
ne fosse bisogno, perché le piste erano illuminate dalla
luna.
Chi non se la sentiva sarebbe ritornato in funivia.
Naturalmente "chi non se la sentiva" ero soltanto io.
Si offersero magnanimamente di tirare a sorte per
designare chi mi avrebbe accompagnato, per non farmi
ritornare sola, ma si capiva chiaramente che sarebbe stato
un sacrificio per il malcapitato, e premisi allora che
mi sarebbe bastata la compagnia dell'uomo della funivia,
con la rotonda faccia paonazza dal sole e il sorriso
sdentato.
Del resto erano venuti equipaggiati per la discesa
e, se fossi stata più esperta e meno paurosa, non avrei
rinunciato nemmeno io a quell'avventura tra i pini intrisi
di luna.
Eravamo arrivati in gruppo, scendendo dalla funicolare in un clamore di risa e di grida, che avevano violentato il silenzio rimbalzando contro l'erta parete
del monte Rognoso, che le aveva rimandate con l'eco.
Il rifugio giallo senape, macchiato dal verde
smeraldo delle imposte, era letteralmente abbarbicato su
uno spuntone di roccia. Da un lato un grande terrazzo si
protendeva sospeso sulla valle, mentre dagli altri lati
scendevano le piste per gli sciatori. Dentro, il locale
era senza pretese, ma intimo e caldo, e dalle vetrate
s'intravedeva uno scenario incantevole. C'erano solo due
tavoli apparecchiati, e del resto di più non ce ne sarebbero stati, uno lunghissimo, il nostro, e un altro più
piccolo, ove stavano già cenando alcuni giovani.
E' di spalle, ma è lui! Nessuno ha quei capelli
ribelli color dell'ebano, sui quali a momenti la luce
accende riflessi blu. E difatti si volta, come se sentisse
il mio sguardo, e mi saluta con il suo sorriso che sembra
abbracciare il mondo.
I cari amici lo vedono, e hanno così un argomento
ghiotto, che li terrà occupati per buona parte della cena.
L'hanno soprannominato " il Salvatore" e trovano molto
divertente scimmiottare come mi ha "portato giù dal
precipizio".
Ma io neanche mi arrabbio, il loro cicalare
mi arriva come un borbottio lontano e indistinto,
percepisco solo il filo invisibile che mi lega allo
sconosciuto, come un muto dialogo senza fine.
Le fiaccole vengono accese in un tripudio
di scintille che sprizzano ovunque, gli sciatori sono
pronti.
Anche lui, l'angelo bruno, così bello che fa
quasi male a guardarlo.
"Scendi in funivia?"mi domanda.
"E me lo chiedi? Non mi hai visto l'altro
giorno?"
"Posso insegnarti un'altra volta."
"Lascia perdere. E' meglio."
"Ma nessuno ritorna con te?"
"Non ho voluto"
"Allora, se permetti, ti accompagno."
"Non sacrificarti. Divertiti, è una notte
stupenda"
"Mi diverto di più ad accompagnarti". Così
dicendo si leva gli sci.
I rispettivi amici ci chiamano a gran voce, poi
capiscono e sparano le solite battute furbe.
Noi li guardiamo scendere salutandoli, è uno
spettacolo la scia di luci che corre sul bianco della
neve.
"Come ti chiami?"
"Barbara. E tu?"
"Gualtiero"
"Che bello. Mi viene quasi da piangere."
Non so neanche a chi lo dico, se a lui, così
perfetto e dolce, o allo scenario in mezzo al quale
viaggiamo sospesi come Icaro nella notte.
La funivia scende verso Sestriere, che ci viene
incontro come un anfiteatro candido punteggiato dai lumi
e incoronato dai monti.
Poi i nostri sguardi s'incontrano smarrendosi
in mille emozioni. Come calamitate le labbra si cercano
in un bacio estatico, complice il sorriso sdentato del
nostro unico testimone.
Seguirono tre giorni felici. Gualtiero dimenticò
gli amici, e anche di sciare in modo divino, per adeguarsi
a me.
Sciavamo tutto il giorno, io ascoltando i suoi
consigli, poi, quando eravamo stanchi, ci sdraiavamo tra
i pini in neve fresca a parlare e a gioire guardandoci e
baciandoci, mentre i raggi di sole che filtravano attraverso i rami tramavano arabeschi luminosi sui nostri
volti.
Poi, dopo una doccia veloce, ci trovavamo
nuovamente e andavamo incontro al sole che calava tingendo
con sprazzi di vermiglio il cielo e i contorni delle cose.
La sera camminavamo abbracciati per i campi e
le strade appena fuori dal paese, sentendo la neve
crepitare sotto i nostri passi e respirando l'aria
rarefatta che aumentava la nostra allegria, e ci spingeva
a giocare e a rincorrerci come ragazzini.
Il tempo fu sempre splendido, e di notte una luna
tonda ci illuminava il cammino e le nostre ombre si
proiettavano nitide sul bianco della neve.
La terza sera incontrammo degli amici di
Gualtiero che, dopo averci canzonato perché ci
eravamo eclissati, gli dissero che l'indomani avevano
intenzione di sciare fuori pista, e se voleva unirsi a
loro.
Vidi che Gualtiero aveva timore di dispiacermi
ma, al tempo stesso, teneva molto ad andarci. Per uno
sportivo come lui tre giorni sulle piste da principianti
doveva essere stato un sacrificio, nonostante ciò che
provava per me.
E così gli dissi: "Va, Gualtiero. Tanto domani
non avrei sciato comunque. Sono a pezzi. Dormirò tutta
la mattina e alla sera sarò così in splendida forma."
"Davvero, non ti dispiace?" mi chiese baciandomi.
"No, te l'assicuro"
Presero accordi per l'indomani. Alle otto si
sarebbero trovati alla funivia Fraiteve. Avevano
intenzione di scendere in fuori pista dall'altro versante
della montagna.
Quella sera Gualtiero mi disse, accarezzandomi
il viso: "Ti amo, ti amo tanto. Non voglio perderti,
quando ritorneremo in città. La nostra storia deve
continuare tutta la vita."
"Sì, Gualtiero." Lo guardai commossa. Il
Creatore era stato superbo nel dipingere quelle fattezze.
Inoltre gli aveva donato quel qualcosa in più che viene
da dentro, che conferiva al suo viso una bellezza quasi
soprannaturale. Tanto che, alle volte, avevo timore che
si volatilizzasse e mi domandavo se stavo vivendo un
sogno o era tutto vero.
"Addio. Divertiti. Ci vediamo domani."
"E tu riposati. Faremo cose folli domani sera.
Ti telefono appena arrivo."
Prima di entrare in albergo,mi voltai a guardarlo
mentre si allontanava con il suo passo un po' ciondolante
sulle lunghissime gambe.
Per l'ultima volta.
Aspettai inutilmente la telefonata, l'indomani.
Alle diciannove pensai che non era da lui
mancare ad un impegno, e incominciai a preoccuparmi.
Telefonai a casa sua, ma non c'era nessuno.
Scesi allora alla sala Funivie e trovai un suo
amico che mi disse che i due ragazzi ch'erano con
Gualtiero erano ritornati senza di lui.
Aveva voluto provare una pista differente,
e si era perso. Ora battevano la montagna alla sua
ricerca.
Il tempo intanto peggiorò. Una bufera s'abbattè
sui monti e oscurò la luna e le stelle.
Cominciai a disperare di rivederlo.
Alle due di notte i soccorritori ritornarono
semi-assiderati dicendo che, per il momento, ogni ricerca
era inutile, perché la visibilità era nulla e il freddo
insopportabile. Avrebbero ripreso all'alba.
Un amico di Gualtiero si assunse il triste
incarico di avvisare i genitori a Torino.
Io corsi in albergo e piansi.
Sapevo che Dio aveva reclamato la sua creatura
perfetta, troppo perfetta per i mortali, e che non l'avrei
più visto.
Lo trovarono difatti, il giorno dopo, sfracellato in fondo ad un crepaccio, il mio angelo bruno, con
le braccia aperte come ali, i capelli neri dispersi tra
il sangue e la neve.
Non ebbi il coraggio di andarlo a vedere, non
volli vedere cosa restava di una giovinezza così splendida
frantumata dal destino.
Volevo ricordarlo com'era, con la sua vitalità,
gli occhi danzanti d'allegria, mentre mi diceva: "Staremo
insieme tutta la vita".
Sono tornata, dopo tanto tempo, a Sestriere.
Finalmente ne ho avuto il coraggio.
Per anni non ho pensato che a Gualtiero, e non sono
riuscita ad interessarmi ad altri.
Il fatto che fosse piombato nella mia vita come
una meteora per finire in modo così tragico ne aveva
ingigantito e idealizzato il ricordo. Mi dicevo che non
avrei più amato, perché nessuno poteva essere come lui.
Poi, un anno fa, mi sono rinnamorata. Tanto da
sposarmi. E riesco ora a ripercorrere i luoghi che mi
avevano vista con Gualtiero, magari commuovendomi, ma
insieme al mio compagno, che sa che quella storia fa
ormai parte del passato. Anche se il ricordo di un angelo
non potrà non accompagnarmi tutta la vita.