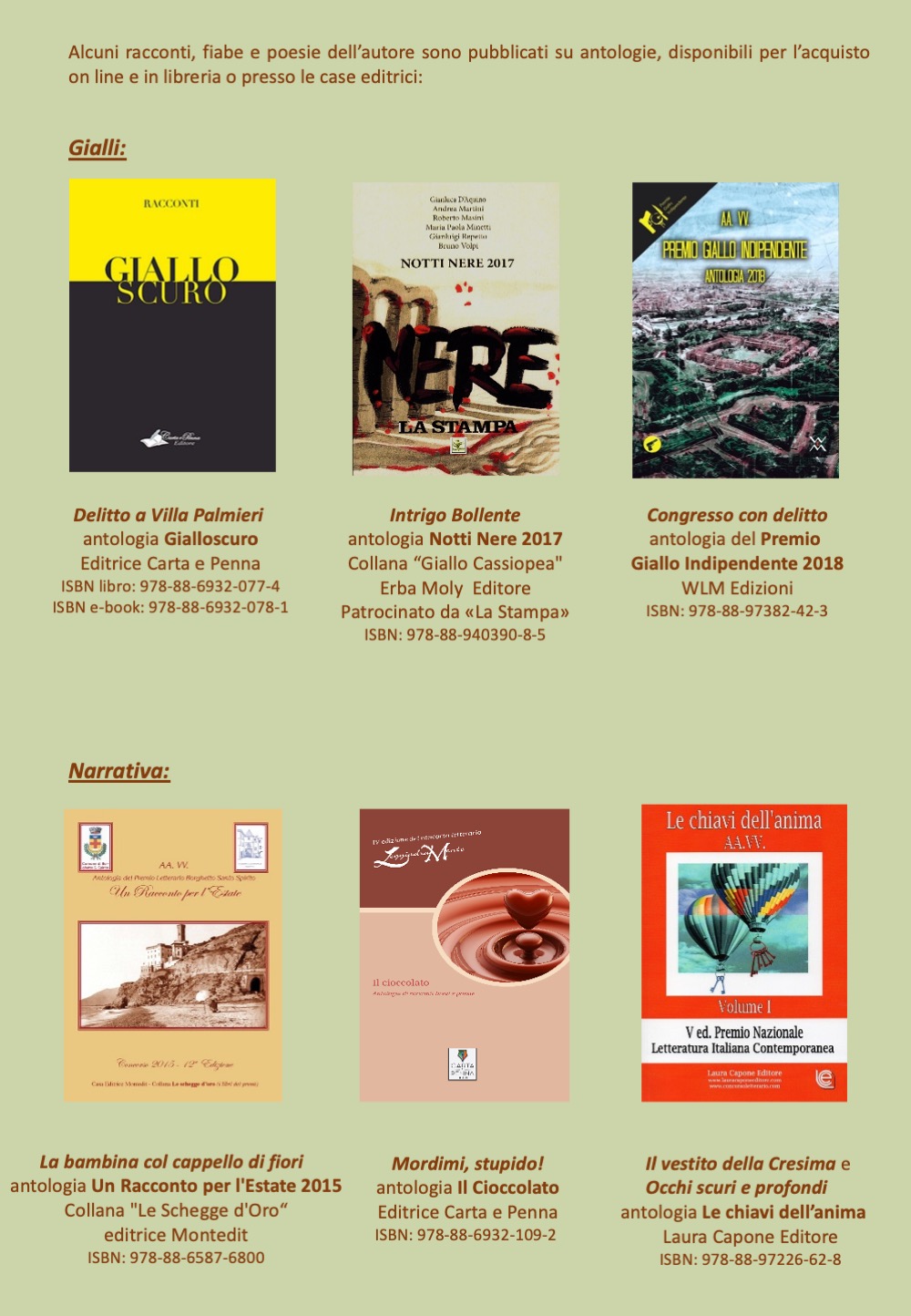IL MILAN DI RIVERA
Nel 1968 avevo ancora sette anni. Avrei dovuto compierne otto, ma il compleanno non arrivava mai. Se sei nato a fine dicembre, i mesi passano e tu hai sempre un anno in meno di tutti i tuoi compagni. E quando finalmente sei diventato più grande, ti ritrovi ancora ad inseguire gli altri che via via ne stanno già compiendo nove.
A sette anni, sopra il mio letto, nella mia cameretta, volevo appendere il manifesto del Milan di Rivera. Sì, perché il Milan di quegli anni era quello di Rivera.
Non che non ci fossero altri campioni in quella squadra. Cudicini, il ragno nero, il Trap, Schnellinger, il tedesco dal cognome impronunciabile, Hamrin, Lodetti, Sormani. E ancora tanti altri. Ma quel Milan non sarebbe stato tale senza Rivera. Per un tifoso milanista lui era un mito, per un milanista nato ad Alessandria anche qualcosa di più.
Lo avrei voluto appendere nella mia cameretta, il manifesto del Milan. Quello dove i giocatori erano tutti schierati, quelli dietro in piedi e quelli davanti inginocchiati. L'avevo visto sul muro dietro al bancone del bar dove mio padre mi portava a prendere il ghiacciolo alla menta. Io succhiavo il ghiacciolo e mi incantavo a guardarlo; le prime volte non avevo capito che era il Milan; i giocatori erano vestiti di bianco e io sapevo che la maglia del Milan era a righe rosse e nere.
Il signor Carlo, il barista, un giorno mi spiegò che quello era il manifesto di quando si era vinto la Coppa dei Campioni nel 1963. Pensai che forse si erano vestiti di bianco per essere più eleganti per la premiazione.
Poteva andare bene anche un manifesto di Rivera da solo, fotografato mentre calciava. Tutte le sere, prima di dormire, sarei rimasto a fissarlo, sognando di essere lì, in campo, con lui, con le scarpe coi tacchetti, nere, lucide. Mi sarei addormentato felice.
Mi sarebbe piaciuto avere un manifesto con Rivera sopra il mio letto, nella mia cameretta.
Ma io non l'avevo, una cameretta. Dormivo in cucina, su un divano che ogni sera la mamma, con una magia, trasformava in un morbido letto con le lenzuola profumate di lavanda. Poi al mattino, mentre mangiavo pane, burro e zucchero e bevevo una tazza di latte con l'Orzoro, per avere l'energia giusta per affrontare la scuola, il letto tornava divano, con un'altra magia di mamma.
Così, uscendo di casa, con la cartella sulle spalle, volgevo un rapido sguardo verso la parete sopra il divano. Niente da fare! Le magie della mamma su Rivera non avevano effetto. Lui, lì, non ci voleva proprio venire.
LA FATA TURCHINA
Chi non si è mai innamorato della Fata Turchina scagli la prima pietra!
Io, purtroppo, la Fata Turchina l'ho scoperta tardi.
La favola di Pinocchio era la mia preferita, anche perché era quella che in famiglia sapevano tutti. Una volta la mamma aveva iniziato a raccontarmi quella del Gatto con gli stivali. Io mi ero addormentato quasi subito. Il giorno dopo avevo chiesto a nonno Mario come andava a finire, ma lui non la sapeva. Allora la sera avevo detto alla mamma che non volevo più che mi raccontasse il Gatto con gli stivali.
Il brutto delle favole è che ogni sera si ricomincia dall'inizio. E io, puntualmente, mentre Pinocchio si bruciava i piedi, dormivo già da un pezzo.
Così ho scoperto che c'era una Fata dai capelli turchini soltanto quando, terminata la prima elementare, una vicina mi regalò il libro con la favola. Papà e mamma non avevano bisogno di leggerla, mentre cercavano di farmi addormentare. Loro la favola di Pinocchio la sapevano a memoria.
Quando arrivò la vicina col libro, andai subito da nonna Maria, le misi in mano il libro e le dissi, in modo anche un po' imperioso; “Leggimela, nonna!”.
Quel pomeriggio ho scoperto che il gatto e la volpe, almeno quelli delle favole, sono cattivi. Una volpe in realtà non l'avevo mai vista, però Minou, la gattina siamese della vicina non mi sembrava cattiva; quando me la facevano accarezzare stava lì buona buona e faceva uno strano rumore che sembrava quasi che russasse, come il nonno, quando si addormentava sul divano.
Poi, dopo qualche pagina del libro, è arrivata la Fata Turchina. Io ho subito capito che, visto che Pinocchio non aveva una mamma, lei, la fata, era la sua mamma adottiva. In famiglia si era parlato tante volte dei cugini di Milano che stavano adottando un bambino e quel pomeriggio la Fata Turchina me l'ero immaginata un po' come la cugina Elena, coi capelli lunghi e ricci e un bel sorriso accogliente, solo che lei i capelli ce li aveva neri.
Elena era venuta a trovarci solo due volte, ma a me piaceva perché stava tutto il tempo a farmi giocare. E poi profumava di buono, e quando mi stringeva io chiudevo gli occhi e stavo lì, quasi senza respirare.
Sì, la Fata Turchina doveva essere proprio come lei.
COME PIERINO PRATI
Quella mattina il maestro, un po' seccato, mi disse “Ma dove hai la testa, oggi?”. Di solito a scuola stavo attento e il maestro era contento di me. Ma quel giorno tutto passava in secondo piano, anche la scuola.
Era il 28 Maggio 1969. Quella sera ci sarebbe stata la finale di Coppa dei Campioni tra Milan e Ajax. Papà aveva promesso che mi avrebbe portato a vederla nel bar, dove avevano il televisore grande.
Il maestro mi aveva fatto qualche domanda di geografia, ma io avevo fatto scena muta. Sapevo tutte le capitali, anche quelle extraeuropee, perché il nonno me le aveva insegnate, ma quel giorno avevo in testa solo Madrid.
Era lì, al Santiago Bernabeu, che si sarebbe deciso, in 90 minuti, se il Milan di Rivera era davvero grande o no. Questo dicevano gli amici di papà; da giorni non parlavano d'altro che della finale. Perché la squadra olandese era sì giovane, ma erano fortissimi; e poi c'era quel Cruiff che era anche lui un po' un “Rivera”.
Alle quattro di pomeriggio avevo già finito tutti i compiti, più quelli che il maestro aveva dato solo a me per castigo per non aver studiato geografia, solo che io l'avevo studiata e se mi avesse interrogato il giorno dopo avrei preso un dieci di sicuro. Non mi pesarono quei compiti di castigo. L'unico pensiero era di finire in tempo per essere pronto per la finale.
Nel bar c'era molto fumo e mi veniva da tossire. Ma cercavo in ogni modo di trattenermi, non volevo che papà mi portasse via. Dopo sette minuti urlarono tutti. Il Milan aveva segnato. Urlai anche io, cercando di esultare come facevano i grandi. Un signore amico di papà mi sollevò verso il cielo, gridandomi: “tutte le volte che gioca il Milan dì a tuo papà di portarti”.
Quasi mi spaventai, ma ero felice.
Di quella finale ricordo solo i dribbling di Rivera, che saltava quei grandurioni degli olandesi come fossero birilli, e papà che alla fine mi fece bere un po' della sua gazzosa.
Appena a casa mi addormentai subito. L'ultima immagine prima di chiudere gli occhi era Rivera che mi passava la palla e io spingevo la palla in fondo alla rete e poi correvo ad abbracciarlo, con il mio numero 11 sulla schiena, come Pierino Prati, e la maglietta a strisce rosse e nere, perché quella sera non avevano messo la divisa bianca come nel manifesto.
PINOCCHIO EQUILIBRISTA
Una sera mio padre rientrò dal lavoro con un fagotto sotto il braccio. Mi chiamò e con cautela quasi religiosa iniziò a rompere la carta da giornale che avvolgeva un misterioso oggetto. Pensai che se ci metteva così tanta cura doveva trattarsi di qualcosa di importante.
Dall'involucro di carta tirò fuori una specie di supporto in ferro, come un portacandela. Aveva uno stelo che veniva su dritto e terminava con piccolo disco, concavo verso l'alto.
Poi, con ancora più cautela, iniziò ad estrarre uno strano oggetto, che mi mostrò con entusiasmo: “Vedi, questo è Pinocchio Equilibrista. L'ho fatto per te!”.
Si trattava di un bilanciere di ferro ricurvo verso il basso, all'estremità due sfere piene, ed esattamente nel mezzo Pinocchio, che reggeva il bilanciere. Aveva un naso lunghissimo e i piedi appoggiavano su una specie di cono rovesciato.
Papà lo appoggiò con delicatezza sul supporto in ferro, in modo che il cono rovesciato rimanesse esattamente nel mezzo del disco concavo, poi gli diede un colpetto con la mano e Pinocchio iniziò ad oscillare pericolosamente a destra e sinistra.
“Mah… adesso cade!” esclamai d'impeto.
“Non può cadere, ti ho detto che è un equilibrista!”.
Pinocchio continuava ad ondeggiare ritmicamente a destra e sinistra senza stancarsi. Io lo fissavo incantato, così come facevo coi giocatori nel manifesto al bar del signor Carlo.
Solo che quell'esibizione col bilanciere, degna del miglior trapezista da circo, nella favola non c'era. Io avrei voluto mettercela, ma non sapevo in quale punto della storia. Potevano essere il Gatto e la Volpe che avevano obbligato Pinocchio a fare il giocoliere per recuperare le sue monete, o Mangiafuoco, che lo teneva in equilibrio con dei fili invisibili.
E intanto Pinocchio oscillava senza interruzione. D'un tratto mio padre con un gesto della mano lo fermò.
Era chiaro: se volevo cambiare la favola, insieme a Pinocchio equilibrista, dovevo trovare un posto anche per papà.
17 GIUGNO 1970
Ci sono date che restano nella storia, talvolta più per il sentire popolare che per la rilevanza del fatto a cui le si associa.
Il 17 Giugno 1970 è una di quelle date: il giorno di Italia-Germania 4-3.
Erano i mondiali di calcio in Messico; a detta di molti l'evento che lanciò la televisione a colori a livello internazionale. La mia famiglia aveva comprato da poco un televisore, ma in bianco e nero, e quella sera ottenni il permesso di stare alzato a vedere la partita. Già, perché in Messico la partita si giocava alle quattro di pomeriggio, ma da noi in Italia iniziava soltanto alle undici di sera.
Papà mi aveva spiegato che era un problema di fuso orario, ma io non ci avevo capito granché. Però ero tutto galvanizzato da quella “licenza di stare alzato” che mi era stata concessa.
L'inizio fu subito una delusione: “Ma papà, non gioca Rivera!”.
Purtroppo era così. Quel mondiale sarebbe passato alle cronache come quello della "staffetta" tra Mazzola e Rivera.
“Papà, ma Rivera è il più forte, ha vinto il pallone d'oro l'anno scorso. Perché non gioca?”. In realtà la risposta la conoscevo già. Durante tutto il mondiale avevo sentito gli amici milanisti di papà dire cose molto brutte sul commissario tecnico dell'Italia; oltre a non capire niente di pallone, ce l'aveva pure con Rivera.
L'Italia andò subito in vantaggio con un bel gol di Boninsegna e a mezzanotte esatta, l'ora in cui accadono le magie, entrò in campo, finalmente, Rivera. Con quella maglia azzurra, che sul nostro televisore era grigio scuro, mi sembrava ancora più mitico di quando l'avevo visto giocare con la divisa del Milan.
Andava tutto benissimo, la partita stava per finire, mancavano ormai pochi secondi, eravamo praticamente già in finale, sembrava tutto perfetto.
“Adesso fischia, sono già due minuti oltre il novantesimo!”
Ma l'arbitro il fischietto, anziché portarlo alla bocca, lo tiene nel taschino e Schnellinger, il biondo difensore del Milan, proprio lui che non aveva mai segnato con la Nazionale, mette dentro il gol del pareggio.
Accidenti, proprio un milanista. E pensare che mi stava persino simpatico. Si va ai tempi supplementari.
Mio padre che inveisce contro l'arbitro giapponese e io che penso tristemente che è quasi l'una di notte e, appena finito di occuparsi dell'arbitro, mi manderà a letto.
Ma papà è tutto preso dalla partita e quasi non si accorge che sono ancora lì. E allora l'incontro scorre via e io lo seguo in silenzio; segnano ancora i tedeschi, pareggia Burgnich, vantaggio di Riva. Accidenti no! Ancora i tedeschi: 3-3.
A me ogni tanto veniva un po' da sbadigliare, e allora mi ripiegavo su me stesso per non farmene accorgere.
Al gol di Riva mio padre si era voltato verso di me, mi aveva guardato, aveva dato uno sguardo alla sveglia sul ripiano del mobile in cucina, poi mi aveva sorriso e si era rimesso a fissare il televisore.
Io invece, più che guardare la partita, stavo lì a domandarmi come mai Rivera non segnasse, lui che era il più bravo. Forse non era poi così bravo! Eppure gli avevano dato il pallone d'oro!
Oltretutto, al gol del 3-3 dei tedeschi, il portiere italiano si era arrabbiato proprio con Rivera che, fermo sulla linea di porta, si era fatto superare dal pallone, quasi come un salame. Io cercavo di convincermi che non era colpa sua, ma non ne ero tanto sicuro. Nove anni e mezzo sono troppo pochi poter accettare senza contraccolpi il crollo di un mito!
Ero triste, e mi ero messo a guardare per terra. Poi Martellini, il telecronista, urla: “Riveraaa…”. Alzo la testa e vedo il pallone finire alle spalle del portiere tedesco e lui, Rivera, saltare di gioia, e i compagni che lo abbracciano.
D'istinto mi lancio anch'io ad abbracciare papà. Lui mi solleva e mi tiene sulle sue ginocchia a vedere la fine della partita.
Il bello dei sogni è che qualche volta si avverano, soprattutto di notte. Ma devi restare sveglio!
LUCIGNOLO IN GONNELLA
Non so di chi si innamorino i bambini di oggi. Quelli di ieri si innamoravano della maestra o di qualche compagna di classe. Io, che ero in una classe tutta maschile, governata da un maestro, maschio pure lui, dovetti ripiegare su Luisa.
Luisa era la figlia dei nostri padroni di casa, di due anni più grande, e, soprattutto, ricca! Non essendoci altri bambini nel cortile su cui affacciavano le nostre abitazioni, decise, per così dire, di adottarmi.
Luisa mi fece scoprire quel mondo che, dopo qualche anno, la televisione avrebbe iniziato a portare anche nelle case degli operai. Con Luisa leggevo Topolino, seduti sul letto della sua cameretta, dove le lenzuola erano candide e sapevano di lavanda. Nel salone di casa sua guardavamo la TV dei ragazzi; ci piacevano Pippi Calzelunghe e i ragazzi di Padre Tobia. Nel tinello facevamo merenda: la signora Elisabetta, la madre di Luisa, preparava sempre due fette di pane con un leggero strato di quell'invitante crema alla nocciola che, da allora, non ho mai smesso di amare.
Il giorno più trasgressivo fu quello del suo dodicesimo compleanno. Era stata organizzata una festa con molti dei suoi compagni e compagne di classe, dodicenni pure loro. Fui invitato anch'io. Non compresi mai se fu Luisa a volerlo o se la madre glielo impose per bon ton. Si sa che a dodici anni, in una festa in cui pensi a ballare e divertirti, un marmocchio di dieci tra i piedi non ce lo vuoi.
Durante quella festa scoprii il mangiadischi. Non era certo la prima volta che ascoltavamo musica in quella casa. Il padre di Luisa aveva un giradischi costosissimo in salone e qualche volta la “signorina” otteneva il permesso di usarlo, ma con cautela. Il dottore aveva molti dischi di musica classica, ma prediligeva Strauss. Così avevo imparato un po' di valzer viennesi, e facevamo finta di ballare, e ridevamo come matti. Quel giorno, però, la musica era diversa. Era quella che sentivo qualche volta per radio, quando c'era la “Hit Parade”, lo slogan che Lelio Luttazzi gridava all'inizio della trasmissione, prima di presentare le canzoni. Ne riconobbi alcune, che stavano uscendo, come per magia, da una specie di tostapane, in cui Luisa e le sue amiche infilavano i dischi per farli suonare. E lui, il tostapane, alla fine della canzone, il disco lo risputava fuori, aspettando di inghiottirne un altro.
“Hai visto che bello il mio nuovo mangiadischi? Me l'ha regalato mamma per il compleanno!”
Io, che ero piccolo e non sapevo ballare, durante la festa finii per fare il disk-jockey. Luisa e le sue amiche sceglievano il disco e io lo infilavo in quella strana bocca musicale e aspettavo, tutto eccitato, che lei lo ricacciasse fuori.
A festa finita, Luisa ed io continuammo a “giocare” col mangiadischi e far finta di ballare. A casa, i compiti attesero invano. Rimasi lì fino a tardi, quando la mamma, forse anche un po' imbarazzata, venne a chiamarmi per la cena.
Avevamo trovato il paese dei balocchi. Chissà se a Luisa, la mattina dopo, sarebbero spuntate le orecchie d'asino?
L'ABITO NON FA IL… CALCIATORE
Compiere gli anni a ridosso del Natale è una fregatura! Ben che vada, almeno un regalo te lo giochi! Così era più facile che le sorprese arrivassero durante l'estate, quando qualche parente lontano compariva a fare visita alla mia famiglia.
I parenti di Roma, quelli, passavano tutte le estati. Erano due signori anziani, lui grasso e calvo, lei ugualmente grassa, ma con una cofana di capelli biondi. Andavano ogni estate in vacanza in Valle d'Aosta. Al ritorno si fermavano qualche ora da noi. Io li chiamavo “gli zii di Roma”, anche se si trattava solo di cugini alla lontana di mia madre. Li chiamavo così perché mi portavano sempre un regalo e mi facevano un mucchio di complimenti.
Quell'anno arrivarono con un bel pacco, tutto infiocchettato. La “zia” faceva un sacco di versi: “Vedrai che sorpresa! Non hai mai ricevuto un regalo così! Quando lo apri, rimani a bocca aperta!” L'ultima frase fu profetica. Rimasi per un tempo indefinito, ad occhi sgranati e bocca spalancata, ad ammirare il contenuto di quel pacco “speciale”.
Era una divisa da calciatore. Del Milan, naturalmente. Numero 10, il mio idolo.
“Provala, vediamo come stai!”. Fu la voce dello “zio” a ridestarmi. La indossai in un baleno. Andava benissimo!!!
In verità tirava da tutte le parti e i calzoncini sembravano quasi un costume da bagno. Gli zii avevano calibrato l'acquisto sulle mie misure della loro precedente visita. Ma era passato un anno e, a quell'età, si sa, i bambini cambiano drammaticamente.
Io, però, ero talmente felice che convinsi tutti, contro ogni lampante evidenza, che la taglia andava bene. Ero impaziente di andare là fuori a dare calci al pallone con quella divisa. Sarei stato il più forte del mondo.
L'occasione di collaudare la mia divisa “magica” si presentò qualche giorno dopo in oratorio. Partitella tra coetanei. “Io ho la maglia di Rivera, quindi gioco in attacco!” pensai, lanciandomi subito verso la porta avversaria.
Al quarto tiro ciccato, di quelli che “bastava toccarla per fare gol”, Francesco, che era bravo a giocare a calcio, e, dunque, capitano “honoris causa”, mi apostrofò con un: “Vai in porta, schiappa d'un milanista!”. Da bambini, i meno dotati calcisticamente venivano messi a fare il portiere. Evidentemente non contava quanti gol si prendevano. L'importante era segnarne uno di più degli avversari.
Mi avviai verso la porta col capo chino. Pensavo a quella divisa che non ero stato capace di onorare. Non potevo accettare che Rivera non segnasse in quella partita. Allora andai verso Roberto, che era bravo anche lui come Francesco, ma era mio amico e tifava per il Milan, mi tolsi la maglietta e gliela porsi: “Toh, mettila, e fa tanti gol. Me la ridai alla fine!”
E che Rivera non si lamentasse, altrimenti poteva pure tornarsene a Roma con gli “zii”!
LA FIGURINA NEL CASSETTO
Il passaggio dalle elementari alle medie rappresentava per un ragazzino un cambio epocale. Non avevi più il maestro, ma una serie di professori con il registro sotto il braccio che si alternavano in classe. Al posto del sussidiario “Noi e le cose” c'era una serie di libri pesantissimi, uno per ogni materia; persino applicazioni tecniche, una materia fantastica perché anziché studiare si facevano dei lavoretti, aveva un suo libro, peraltro quasi mai aperto.
Ma l'aspetto più eccitante del passaggio alle medie fu la mia prima raccolta delle figurine dei calciatori. In realtà tutto iniziò da una debolezza del nonno. Ormai era diventata un'abitudine quasi quotidiana chiedergli: “Nonno, mi compri le figurine dei calciatori?”. Un giorno il nonno, improvvidamente, cedette.
Trasse dalla tasca quaranta lire e le diede al giornalaio che, insieme alle 4 bustine verdi gli allungò anche un grosso album e, rivolto verso di me, con un sorriso, disse “Vediamo se riesci a finirlo tutto!” La presi come una sfida!
La gioia per il mio nuovo album di figurine fu tale che anche la mamma dovette cedere: “Se sarai bravo a scuola, potrai comprarle.”
L'appuntamento col giornalaio diventò quasi una costante. Arrivavo orgoglioso davanti all'edicola, con i miei soldi in mano, mettevo in tasca le bustine e mi dirigevo verso casa con passo spedito.
Dopo pranzo mi mettevo sul divano e, con un rituale appreso quando guardavo i ragazzi più grandi, strappavo l'involucro per vedere quale campione mi ero portato a casa per sole dieci lire. Ricordo ancora la mia prima figurina: Giuseppe Vavassori, portiere del Bologna; aveva i capelli biondi con un ciuffo sulla fronte, una bella faccia pulita e un colletto rosso fuoco che risaltava sulla maglia blu scuro.
Le figurine, per noi ragazzi dei '70, furono uno dei principali strumenti di socializzazione. Si scambiavano, si usavano come “moneta corrente” in cambio di soldatini o fumetti, i più scaltri le vendevano.
Ma, soprattutto, ci si giocava.
Con le figurine si facevano giochi “da seduti”, girandole a turno dal proprio mazzo fino a quando non venivano due calciatori della stessa squadra e allora vincevi tutte quelle in tavola. Io, con i miei amici Fabrizio e Roberto, giocavo a lanciarle sul marciapiede davanti a casa. Se la figurina lanciata planava su quella di un altro, l'avevi fatta tua.
Giocare con le figurine era diventato uno sport nazionale; si vedevano ragazzini che giravano con borse di plastica piene di figurine. Se eri bravo, o fortunato, in un giorno potevi vincerne anche qualche centinaio.
Le mie prime figurine le avevo conservate quasi come una reliquia, e se le avessi perse sarebbe stata una tragedia greca; man mano però che il loro numero cresceva, mi accorgevo che la faccia stampata sopra perdeva di importanza. Erano diventate tutte uguali. Tutte tranne una, ovviamente.
La figurina di Rivera la trovai abbastanza presto. Un segno, forse, perché non era tra le più facili. Ricordo la cura con cui la incollai sull'album. Non dovevano esserci sbavature di colla, lui era il più grande.
Dopo qualche mese cominciai ad averla doppia, ma non la scambiavo con gli altri. La tenevo in un cassetto. Se si fosse rovinata quella sull'album, avrei sempre potuto sostituirla.
Rimase in quel cassetto fino ad un giorno del 1984, verso la fine dell'università. La ritrovai casualmente in mezzo alle fotografie di quando ero bambino. La osservai qualche secondo e fu come essere investiti da una secchiata di ricordi. Quel giorno iniziava anche per me quella fase della vita in cui infanzia comincia a far rima con nostalgia.
PINOCCHIO CHE NON SEI ALTRO!
Pinocchio equilibrista, lui, invece, non l'ho più trovato. Non so che fine abbia fatto, se si sia perso in qualche trasloco o sia finito a cerchiare di stupore le labbra di qualche altro bambino.
Con la sparizione di quello strano tipo di giocattolo, che mio padre aveva fabbricato appositamente per il suo figlio unico, pian piano, era venuta meno anche la passione per la favola. Iniziavo a dimenticarlo, quel burattino di legno!
Ma non immaginavo che sarebbe stato così difficile. Perché lui, che era stato il mio primo compagno di viaggio, a farsi escludere dalla mia vita proprio non ci stava.
Era stata nonna Maria a farlo entrare per la prima volta, quando, con aria minacciosa, mi ricordava che, ogni qualvolta avessi detto una bugia, il mio naso avrebbe preso ad allungarsi a dismisura come accadeva a quello del burattino.
Per qualche tempo funzionò. Avevo una paura tale di dir bugie che, quando mi facevano una domanda, ci pensavo su un sacco di tempo. Qualcuno avrà di certo immaginato un deficit nello sviluppo cognitivo e relazionale; altri, più semplicemente, che fossi un po' tonto!
Capitava, però, che la bugia scappasse. Allora correvo in camera da letto dei miei genitori per guardarmi nello specchio grande. Aspettavo lì davanti un paio di minuti, ma il naso non si allungava. Forse la bugia che avevo detto era troppo piccola? No. Non doveva esser quello il motivo. Padre Bernardo, il parroco, nel catechismo, ci aveva insegnato che tutte le bugie sono peccato, nessuna esclusa. Tutte sono gravi. Ma allora era il mio naso che non funzionava bene?
La “favola “del naso durò poco. Le bugie invece continuarono, anzi crescevano di anno in anno, e diventavano sempre più raffinate. Le dicevo per schivare i rimproveri. Le dicevo per sentirmi grande. Il problema era che, dopo averle dette, mi restava un peso allo stomaco che non andava via, un po' come dopo la peperonata della nonna. Avrei preferito il naso lungo.
Una notte sognai la cugina Elena, la mia Fata Turchina personale, che mi abbracciava e mi diceva “Ah, Pinocchio che non sei altro! Quando smetterai di essere un burattino e diventerai un uomo?” Così, per anni, ogni volta che mi veniva l'istinto di mentire, me la vedevo davanti, severa e sorridente al contempo, a ripetere quella frase. Spesso funzionò.
EPILOGO
Sono passati una quarantina d'anni. Con Pinocchio ogni tanto ci rivediamo. Anche se non lo cerco, è lui a farsi vivo.
Lancia martelli al Grillo Parlante, quando quello si prende in prestito la mia faccia e sputa sentenze. Insegna al mio Mangiafuoco che gli altri non sempre ci stanno a lasciarsi manovrare come burattini. Mi urla nell'orecchio di andare dritto sulla strada, tutta buche, della vita vera, ogni volta che mi scopre a svoltare verso il paese dei balocchi.
Con Rivera, invece, non ci siamo mai incontrati. Anzi, quando ha smesso di essere un mito, per quel ragazzo che ne conservava gelosamente la figurina, è tornato uno come tanti altri.
Perché il mondo è pieno di Rivera sconosciuti, che quei medesimi talento, abilità ed impegno li mettono a servizio di cose anche più nobili che dare calci ad un pallone. E la loro grandezza sta proprio nel riuscire a rimanere degli sconosciuti. Pensandoci bene, alcuni li conosco, e un po' li invidio.
C'erano anche i loro volti tra le immagini che si rincorrevano sul palcoscenico dei ricordi mentre scrivevo queste poche pagine, narrando di quel ragazzino che amava Pinocchio e Rivera, parlando di parenti e amici di cui ho inventato qualche caratteristica, non fosse altro almeno il nome, raccontando storie che il passaggio degli anni inevitabilmente ha intrecciato e confuso con quelle di altri bipedi incontrati, conosciuti e talora amati.
Storie, il cui lieto fine, come ripeteva nel sogno la cugina Elena, sta nel passare, giorno dopo giorno, anno dopo anno, con fatica, da burattini col naso lungo e i piedi bruciati, a uomini con un cuore di carne e occhi ben aperti, per vedere, e, talvolta, per piangere. E forse, anche nel rendere normale ciò che sembra impossibile, o nel cambiare i finali, per trasformare in favole le vicende di ogni giorno. Quello che sapevano fare mamma e papà, senza aver mai vinto un pallone d'oro.
TI HO VISTO PARTIRE
Ti ho visto partire, amore mio.
Verso un paese straniero, ti ho visto partire.
Ammassati come bestie vi ho visti partire.
Ho un cuore troppo vecchio per vederti tornare.
Ho un cuore troppo giovane per saperti in fondo al mare.
LA TRINCEA NEL CUORE (Fronte italiano, gennaio 1918)
Tracce di matita annebbiate dal tempo,
tempo che ingiallisce i ricordi,
tempo che setaccia i sentimenti.
Una lettera dal fronte italiano,
testimone silenziosa di un amore,
testimone urlante di una lontananza.
Poche le parole, incerta la grafia:
“Sto bene. Qui fa tanto freddo. Presto tornerò.
Aspettami, Amore mio!”
Nascosta tra i ricami della vita,
lei l’aveva conservata in un cassetto,
lei l’aveva sigillata nel suo cuore.
Giovane alpino, scriveva, Il nonno.
Scriveva dall’abbraccio mortale dell’inverno.
Scriveva e tremava.
Scriveva dal fronte, le mani dure di freddo.
Scriveva dal fronte, gli occhi bagnati di lacrime.
Scriveva dal fronte, una trincea nel cuore. |